Clemente era un tipico intellettuale ellenistico, un uomo dell’Impero Romano del II secolo1. La sua biografia, ricostruita in gran parte grazie alle informazioni da lui lasciate nelle sue opere, è quella tipica di un uomo di cultura greco. Nato con tutta probabilità ad Atene intorno al 150 dopo Cristo, condivideva con i suoi concittadini l’amore per la filosofia. Per questo, come lui stesso racconterà, si mise in viaggio per tutto il Mediterraneo alla ricerca della vera sapienza. Giunse così nella Magna Grecia, poi in Siria, infine in Egitto. Tra i suoi maestri ci furono greci, ma anche assiri ed ebrei. Quando giunse ad Alessandria d’Egitto, che era allora la seconda città dell’Impero dopo Roma, ascoltò gli insegnamenti di Panteno, un greco della Magna Grecia, che da filosofo stoico era divenuto cristiano e aveva creato una scuola nella grande città egiziana. Clemente divenne anche lui cristiano in età adulta, continuando a fare filosofia, cioè a cercare la verità, seguendo però le indicazioni del Vangelo.
Quando, secondo la tradizione, Panteno lasciò Alessandria per andare in Oriente (forse in Persia, forse in India) in aiuto ai cristiani più lontani, Clemente gli succedette alla guida della scuola di Alessandria. Non bisogna forse pensare a una scuola catechetica strutturata, ma a un luogo di insegnamento nato su iniziativa del maestro, sul modello delle scuole filosofiche. Qui Clemente cominciò a spiegare il Cristianesimo ai greci residenti nella grande città della foce del Nilo. Lo faceva alla maniera di un filosofo. Non a caso il suo primo libro lo intitolò il Protrettico, cioè esortazione. Aristotele aveva scritto un libro dallo stesso titolo. In questo libro il filosofo esortava ad abbracciare la filosofia, non in quanto attività speculativa, ma come vera e propria “pratica di vita”2. Clemente lo richiama esplicitamente. Riprendendo una distinzione classica, già presente in Aristotele (cfr. Poetica 47a) e poi adottata dalla filosofia stoica (cfr. Seneca, Epistolae, 95; 65), egli spiega che il Logos dapprima invita l’uomo e lo esorta alla conversione (è il Logos esortante, in greco Logos protreptikos), poi lo guida per mano, come un pedagogo, e lo ammaestra nella vita pratica (Logos consigliere, in greco hypothetikos, che è poi il Pedagogo, cioè il secondo dei suoi libri), infine lo istruisce nelle verità di fede (Logos istruttore, didaskalikos). A queste tre fasi corrispondono le tre parti della trilogia che Clemente si era proposto di scrivere e di cui scrisse solo le prime due: il Protrettico e il Pedagogo.
Clemente era un educatore, innamorato del suo mestiere e quindi anche sensibile ai giovani che gli erano affidati (anche se non va dimenticato che la scuola antica non conosceva le classi divise per età). Questa sensibilità educativa emerge bene nelle prime pagine del Pedagogo, la seconda delle sue grandi opere.
D’altronde due delle cose più belle e più perfette che ci siano in questa vita, l’educazione (cioè la paideia) e la pedagogia (paidagogia), anche noi, onorandole, le designiamo con termini che rimandano alla fanciullezza (pais = bambino)3.
E poi aggiunge una delle definizioni più belle, mai date, della pedagogia:
Possiamo dire che la pedagogia sia il condurre i giovani, nel modo migliore, dalla fanciullezza alla virtù4.
A testimonianza del suo amore per la pedagogia, Clemente cita un passo tratto dalla Medea di Bioto: “Tra i mortali l’allevare i bambini procura spesso più magia d’affetto che il solo generarli”5.
È importante però, per capire l’intento con cui Clemente scrive questo testo, ricordare che il pedagogo in greco era lo schiavo che accompagnava i bambini a scuola, mentre il maestro si chiamava didascalos. Come lo schiavo portava i bambini al maestro, così Clemente intende portare i suoi lettori/ascoltatori all’incontro con Gesù-maestro. In questo senso non si vergogna di dire che tutti siamo fanciulli e tutti dobbiamo essere condotti al Maestro.
Eppure, malgrado tutte queste premesse, certamente favorevoli a un atteggiamento positivo verso l’infanzia, Clemente lascia trasparire più volte un giudizio negativo nei confronti dei bambini. Ciò appare quando deve commentare alcune pagine dei vangeli in cui si narrano comportamenti, da Clemente percepiti come problematici, dello stesso Gesù di Nazareth.
Il Signore stesso con molta chiarezza ci manifesta che cosa indica il termine “bambino”. Gli apostoli avevano cominciato a discutere chi fosse il più grande fra di essi. Allora Gesù mise al centro un bambino e disse: “chi si farà piccolo come questo bambino, quegli è il più grande nel regno dei cieli”. Egli infatti non utilizza il termine bambino per indicare l’età in cui si è privi ancora di ragione come è apparso ad alcuni6.
Il problema di Clemente deriva dall’opinione corrente sui bambini, giudicati privi di intelletto, non ancora pervenuti all’età della ragione. Per dirlo con linguaggio rozzo: i bambini prima di una certa età erano considerati stupidi, incapaci di comprendere e di volere. Di qui la difficoltà a interpretare l’invito di Gesù: come poteva invitare i discepoli a diventare stupidi come bambini? Clemente si affretta a precisare:
… e quando [Gesù] dice: “se non diventerete come questi bambini non entrerete nel regno dei cieli”, non bisogna intendere la frase superficialmente. Noi non siamo più bambini che si rotolano per terra e strisciano a mo’ di serpenti sul suolo come prima e si rivoltano con tutto il corpo nei desideri irrazionali7.
La difficoltà non va sottovalutata. Il pregiudizio anti infantile infatti non era soltanto popolare, ma anche colto. L’idea dei bambini che si rotolano per terra e strisciano come serpenti richiama direttamente la celebre affermazione di Aristotele, secondo il quale i bambini, quando nascono, sono i più incompiuti tra gli animali compiuti. Vale la pena di rileggere il passo de La riproduzione degli animali di Aristotele:
I bambini invece… trascorrono dapprincipio nel sonno più tempo degli altri animali, perché vengono al mondo più incompiuti di tutti gli altri animali compiuti e sono soggetti all’accrescimento principalmente nella regione superiore del corpo8.
Non vi è dubbio che il grande filosofo abbia osservato con attenzione i bambini appena nati: nota che passano molte ore dormendo e fa osservazioni molto interessanti sul colore dei loro occhi. I cuccioli dell’uomo, a differenza di quelli degli altri mammiferi, non sono rapidamente autosufficienti, non cercano da soli la mammella della madre, non sono in grado di muoversi e tanto meno di assumere la posizione eretta. Per questo Aristotele giustamente dice che “vengono al mondo più incompiuti di tutti gli altri animali compiuti”.
Aristotele però va oltre, notando una similitudine tra i bambini e le donne. Lo fa parlando della calvizie:
Gli uomini sono chiaramente gli animali che diventano più calvi… l’unicità tra gli animali al fatto che l’uomo possiede un cervello di molto più grandi proporzioni e assai umido. Anche le donne non diventano calve, perché la loro natura è simile a quella dei bambini: entrambi sono privi di escrezione seminale9.
La similitudine tra donne e bambini è nella mancanza di escrezione seminale. Aristotele riconduce questa mancanza alle dimensioni del cervello, l’organo che, a suo parere, trasforma il sangue in seme virile: sia le donne che i bambini hanno un cervello più piccolo di quello del maschio adulto. Si arriva così alla spiegazione “scientifica” della mancanza di ragione nei bambini. In sostanza, donne e bambini hanno il cervello più piccolo e… più caldo.
Tra gli animali, l’uomo ha il cervello più grande in rapporto alle sue dimensioni, e tra gli uomini i maschi l’hanno più grande delle femmine: in entrambi i casi, infatti, la regione del cuore e del polmone è la più calda e ricca di sangue. Ed è per questo che l’uomo soltanto, fra gli animali, ha posizione eretta: la natura del calore con la propria forza fa sì che l’accrescimento avvenga, a partire dal centro, nella sua stessa direzione. All’abbondante calore si deve dunque contrapporre una maggior quantità di elemento fluido e freddo; e a questa quantità si deve anche la solidificazione assai tardiva dell’osso attorno alla testa che alcuni chiamano ‘bregma’, poiché il caldo impiega molto tempo a evaporare. Questo fatto non si verifica in nessun altro degli animali sanguigni10.
Aristotele ha osservato che l’osso attorno alla testa si solidifica solo qualche tempo dopo la nascita e attribuisce questo al calore del cervello del neonato, che non è ancora freddo come quello dell’adulto. Per questa stessa ragione il bambino non ha la capacità di assumere la posizione eretta. Mancanza di intelligenza e incapacità motoria sono quindi due aspetti della stessa deficienza naturale.
Si capisce così tutta la difficoltà incontrata da Clemente Alessandrino: come aveva potuto Gesù di Nazareth invitare i suoi discepoli a «farsi piccoli come bambini»? Si potevano invitare degli uomini adulti a rinunciare alle loro caratteristiche fisiche e naturali?
Il ragionamento di Aristotele sui bambini non si ferma però alla sola osservazione “naturalistica”, perché dalla dimensione del cervello fa discendere una incapacità che è anche di ordine morale. Nell’Etica Nicomachea infatti dice che i bambini come gli animali, sono incapaci di proponimenti, cioè di atti dettati da ragione e riflessione11. I bambini, come gli animali, perseguono il piacere, ma non il bene12… “Dei piaceri alcuni sono buoni in senso assoluto, ma non tutti sono buoni, proprio quest’ultimi sono cercati dalle bestie e dai bambini, ed è il dolore provocato da questi che fugge il saggio”13. Il paragone qui non è più tra i bambini e le donne, ma tra i bambini e gli animali. Gli uni come gli altri, proprio per la mancanza di valutazione razionale, non sono in grado di distinguere e perseguire il bene. Le conseguenze sono, per certi versi, paradossali:
Logicamente non diciamo che è felice un bue, un cavallo o un altro animale; nessuno di essi infatti è capace di essere partecipe di una tale attività. Per questa causa neppure un bambino può essere felice; a causa dell’età egli infatti non è ancora in grado di essere attivo in tal maniera: i bambini sono detti felici solo in vista delle speranze future. La felicità infatti, come dicemmo, richiede una perfetta virtù e una vita compiuta14.
Il bambino dunque per Aristotele non può essere felice. Torna quindi la domanda che si deve esser posto Clemente, che, come si diceva, conosceva e apprezzava Aristotele: come è possibile che Gesù di Nazareth abbia invitato a “farsi piccoli come bambini”? La risposta di Clemente è, per certi versi, geniale:
Questa, certo, sembrerà una follia a quelli che sono esperti di astuzie e malvagità. Ma coloro che hanno conosciuto solo Dio come padre sono senz’altro fanciulli, sono semplici, bambini, integri, amanti delle corna degli unicorni. A coloro che hanno progredito del logos egli annuncia queste parole, invitandoli a non curarsi delle cose di quaggiù e a rivolgere la loro attenzione solamente al Padre, imitando i bambini. Per questo poco dopo aggiunge: “Non preoccupatevi del domani, a ogni giorno basta il suo male”. In tal modo egli ci ingiunge di mettere da parte le preoccupazioni di questa vita e di abbandonarci al solo Padre. Chi mette in pratica questo precetto è realmente un bambino, un fanciullo, agli occhi di Dio, e anche agli occhi del mondo: ma per quest’ultimo lo è in quanto ingannato, per Dio invece lo è in quanto amato. E se, come dice la Scrittura, uno solo è il maestro nei cieli, allora dobbiamo riconoscere che tutti coloro che sono sulla terra saranno chiamati discepoli. La verità infatti è questa: il Signore, essendo perfetto, insegna sempre; noi che siamo bambini sempre impariamo15.
Per Clemente è bambino chi si dispone ad imparare, chi si affida al Padre, in ultima analisi, è bambino ogni cristiano che non si preoccupa per il domani. È, certamente, una bella interpretazione del passo evangelico. Solo che, in un certo senso, nelle parole di Clemente spariscono i bambini concreti. Lo si capisce nel passaggio immediatamente successivo.
A questo punto è giusto che concentriamo la nostra attenzione sul termine “bambino” (nepios). Esso, infatti non designa colui che è privo di intelligenza, questi è detto puerile (nepytios). “Bambino”, invece, è colui che è nuovamente dolce (neepios): dolce (epios) è la persona dai pensieri teneri, che è divenuta dolce in maniera nuova e mite nei modi. È questo che con molta chiarezza il beato Paolo fa intendere, quando dice: “Noi potevamo in quanto apostoli di Cristo avere potestà, ma ci facemmo dolci (epioi) in mezzo a voi come una madre che tiene in braccio i suoi figli”. Il bambino dunque è dolce e perciò è anche più innocente, delicato, semplice, senza inganni e senza finzioni, giusto e retto di mente: e questa invero è l’essenza della semplicità e della verità16.
Il bambino è diventato così una categoria morale: per Clemente è il simbolo della semplicità, a cui si collegano le altre virtù, l’innocenza, la delicatezza, la sincerità. Per cogliere tutto il valore di questa operazione culturale, bisogna collocare la riflessione di Clemente nel contesto del suo tempo.
Nell’Alessandria del II secolo erano molto diffuse le dottrine che oggi vengono chiamate gnostiche. I cristiani gnostici dividevano il popolo cristiano in due categorie: da una parte gli uomini e le donne semplici, coloro che non avevano istruzione, che si accontentavano di una fede fatta di devozione, dall’altra i veri cristiani, quelli che avevano accesso alla gnosi, cioè alla conoscenza e che quindi avevano la piena comprensione dei misteri della fede. Clemente in questo come in altri passi si preoccupa di contestare questa divisione elitaria e intellettualistica. Per lui i veri cristiani non sono i sapienti, i sottili ragionatori, gli iniziati ad una gnosi esoterica, bensì i semplici, i piccoli, quelli che somigliano ai bambini di cui parla Gesù nei vangeli.
Il dubbio che resta, dopo aver letto le pagine di Clemente è il seguente: dove sono finiti i bambini veri? I bambini infatti non sempre sono innocenti, sinceri, puri e non sempre corrispondono all’immagine di purezza descritta da Clemente.
E, legata a questa domanda, ve ne è un’altra: siamo sicuri che Gesù di Nazareth si riferisse ai bambini come categoria morale e non ai bambini concreti? Per rispondere occorre prendere in esame il concreto atteggiamento del profeta galileo verso i bambini, come traspare dal racconto dei testi che ne raccontano le vicende: i vangeli.
Il punto di partenza per questa riflessione non può che essere l’ambiente giudaico in cui Gesù è nato e cresciuto. In tale ambiente l’atteggiamento verso i bambini era ambivalente: da un lato tutta la religione dei figli di Abramo era fondata sulla promessa di una discendenza, per cui i figli erano la prima benedizione chiesta a Dio da ogni fedele; allo stesso tempo però il giudizio generale sui bambini restava prevalentemente negativo: cattive inclinazioni, mancanza di intelligenza e di coraggio. Pur non essendo possibile analizzare a fondo la Sapienza di Israele, alcune massime dei libri sapienziali rivelano un atteggiamento repressivo:
“Chi risparmia il bastone odia suo figlio, chi lo ama è pronto a correggerlo”17. “Non risparmiare al giovane la correzione, anche se tu lo batti con la verga, non morirà; anzi, se lo batti con la verga, lo salverai dagli inferi”18. “La verga e la correzione danno sapienza, ma il giovane lasciato a se stesso disonora sua madre… Correggi il figlio e ti farà contento e ti procurerà consolazioni”19. “Chi ama il proprio figlio usa spesso la frusta, per gioire di lui alla fine. Chi corregge il proprio figlio ne trarrà vantaggio e se ne potrà vantare con i suoi conoscenti…”.
L’educazione è intesa simile all’addestramento degli animali domestici.
“Un cavallo non domato diventa restio, un figlio lasciato a se stesso diventa sventato. Coccola il figlio ed egli ti incuterà spavento, scherza con lui, ti procurerà dispiaceri… Non concedergli libertà in gioventù, non prendere alla leggera i suoi difetti. Piegagli il collo in gioventù e battigli le costole finché è fanciullo, perché poi intestardito non ti disobbedisca”20.
Un altro esempio interessante è l’atteggiamento verso i bambini della Comunità di Qumran. Questo gruppo religioso dissidente, che aveva il suo centro principale vicino al mar Morto, è ben conosciuto grazie al ritrovamento di alcuni interessantissimi papiri. Nella legislazione di Qumran si prevedeva:
Nessun ragazzo giovane e nessuna donna entreranno nei loro accampamenti quando essi usciranno da Gerusalemme per andare in battaglia, finché non saranno tornati21.
Le persone stupide, i pazzi, i semplicioni, i dementi, coloro che essendo deboli di vista non possono vedere, gli zoppi, i sordi, i minori, nessuno di costoro entrerà a far parte della comunità, perché gli angeli santi (stanno in mezzo ad essa)22.
In questo contesto il comportamento di Gesù appare, sotto molti riguardi, stupefacente. Possiamo riprendere, nella versione del vangelo di Matteo, il passo citato da Clemente:
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?”. Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: “In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me”23.
Non c’è il minimo accenno alla purezza, alla semplicità o ad altre virtù dei bambini. Gli uomini ai quali Gesù si rivolgeva non si curavano minimamente delle qualità intrinseche dell’infanzia. Se Gesù avesse voluto attirare la loro attenzione su questo punto, avrebbe dovuto esplicitare un pensiero che li avrebbe sicuramente stupiti. Gesù non contesta il giudizio sfavorevole per cui i bambini sono considerati essenzialmente come esseri imperfetti, trascurabili, privi di intelligenza e di ragione. Ma queste deficienze, che provocano il disprezzo degli adulti, attirano su di essi la benevolenza specialissima di Dio. Ciò che impedisce agli uomini di dare ad essi una qualche importanza, è proprio ciò che fa di essi i privilegiati del Regno di Dio24.
A questo proposito si può mettere in relazione la prima delle Beatitudini, “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”25, con un frase tratta dal vangelo di Marco: “a chi è come loro [i bambini] appartiene il regno di Dio”26. È chiaro il parallelismo: i bambini e i poveri sono i primi destinatari del Regno di Dio che Gesù è venuto ad annunciare. Il motivo della scelta dei bambini non è qualche loro merito o predisposizione, ma il beneplacito del Padre. Come risulta da un altro testo: “Così non è volontà davanti al Padre vostro che è nei cieli che uno solo di questi piccoli vada perduto”27. Gesù capovolge il modo di vedere tradizionale. Sono i semplici, gli ignoranti, coloro ai quali Dio ora accorda la rivelazione dei suoi segreti; ai bambini e a chi ad essi assomiglia egli intende riservare i benefici del suo Regno. Il grande esegeta Jacques Dupont, nel secolo passato, ammoniva:
Bisogna lasciare a questo insegnamento tutto il suo carattere paradossale, senza interpretarlo partendo da una concezione idealizzata dell’infanzia o da una osservazione più attenta della psicologia infantile, senza inoltre trasformare la ingenuità dei nepioi in una nobile semplicità di cuore. I privilegiati agli occhi di Dio sono coloro che non contano agli occhi degli uomini28.
Come si vede, la moderna esegesi rimette in discussione la lettura di Clemente, il quale, tra i primi ha proposto una concezione idealizzata dell’infanzia. In tal modo egli ha permesso ad un pubblico colto di cultura greca di accedere al cristianesimo, ma forse senza avvertire pienamente la forza sovversiva del vangelo che annunciava.
1 Il primo degli autori presi in esame in verità non appartiene al Medioevo, ma la sua testimonianza è particolarmente importante perché la sua impostazione del problema diverrà canonica per gran parte dei pensatori cristiani, anche al di là di una conoscenza diretta delle sue opere.
2 Cfr. Clemente Alessandrino, Gli Stromati. Note di vera filosofia, introduzione di Marco Rizzi, Ed. Paoline, Milano 2006, p. XI.
3 Clemente Alessandrino, Il pedagogo, libro I, 16,1.
4 Ibidem.
5 Ibidem, 49, 4, p. 81.
6 Clemente Alessandrino, Il pedagogo, libro I, 16, 1, p. 49.
7 Ibidem.
8 Aristotele, Riproduzione degli animali, libro V, 1, p. 1012.
9 Aristotele, Riproduzione degli animali, libro V, 3.
10 Ibidem, libro II, 7.
11 Aristotele, Etica nicomachea, III, 2.
12 Idem, VII, 11.
13 Idem, VII, 12.
14 Idem, I, 9.
15 Clemente Alessandrino, Il Pedagogo, libro I, 17,3, p. 50.
16 Ibidem, XIX, 1-3, p. 51.
17 Pr 13,24.
18 Pr 23,13.
19 Pr 29,15 17.
20 Sir 30,1-12.
21 1 OM 7,3-6.
22 4QDb.
23 Mt 18,1-5.
24 Cfr. Jacques Dupont, Le beatitudini, p. 842.
25 Mt 5,3.
26 Mc 10,15.
27 Mt 18,14.
28 Jacques Dupont, Le beatitudini, p. 841.
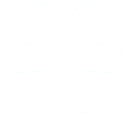 NOTEdiSTORIA
NOTEdiSTORIA