Non tutti però si comportavano come Rabano nei confronti di Gotescalco. Non tutti praticavano una pedagogia repressiva. Vi sono diversi esempi di monaci che rivelano un’altra sensibilità. Uno dei casi più conosciuti è quello di Anselmo. Questo grande intellettuale, che proveniva da Aosta, ma poi fu monaco e abate nel monastero di Bec e terminò i suoi giorni come arcivescovo di Canterbury, fu anche un grande pedagogo. Nella sua Vita, scritta subito dopo la morte dal monaco Eadmero, si dedicano diversi capitoli per descrivere il suo atteggiamento verso i giovani. In particolare nel capitolo XI, intitolato “La ragione per cui si è occupato più dei giovani, in vista della loro crescita, che non degli altri”.
Dedicava, comunque, la sua massima cura agli adolescenti e ai giovani, e a quanti gliene chiedevano il motivo rispondeva con una similitudine. Paragonava l’età giovanile alla cera, ammorbidita al punto giusto per riceve l’impronta del sigillo. “Infatti, diceva, se la cera è o troppo dura o troppo molle, non riceve perfettamente la figura impressa nel sigillo. Se, invece, la durezza e la mollezza si contemperano in giusta misura, allora la cera può essere marcata col sigillo, allora l’immagine del sigillo vi risalta nitida e integra. Così è delle età dell’uomo. Prendiamo il caso di un uomo che dall’infanzia alla più avanzata vecchiaia ha trascorso la sua vita nelle vanità di questo mondo, dilettandosi unicamente delle cose terrene, e totalmente fissato in esse. Prova a parlare con costui delle cose spirituali e della profondità della contemplazione divina; insegnagli a esplorare i segreti celesti: ti accorgerai che non sarà in grado di vedere nulla di quello che tu vorresti. E non c’è da stupirsi. La cera si è indurita; non ha trascorso la sua vita in queste cose, ma ha imparato a seguire cose affatto diverse. Prendi al contrario il caso di un fanciullo, ancora in tenera età e digiuno di sapere, inesperto nel discernere il bene e il male, che neppure riesce a comprendere le tue disquisizioni in merito. In tal caso la cera è certamente molle e quasi liquida, del tutto inidonea a ricevere l’impronta del sigillo. In posizione mediana tra questi due si collocano l’adolescente e il giovane, nei quali malleabilità e durezza si trovano convenientemente amalgamate. Ebbene, se dispenserai loro degli insegnamenti, riuscirai a modellarli come vorrai1.
Chi era Anselmo? Intanto, forse non a caso, non era un ex bambino oblato, perché era entrato in monastero solo dopo la morte del padre, quando era già adulto. Egli conserverà un vivido ricordo della sua infanzia in Val d’Aosta, testimoniato in una pagina della sua biografia in cui si riporta una visione avuta da bambino.
Anselmo quando era un bambino piccolo, ascoltava volentieri – come gli consentiva la sua età – le conversazioni della madre. E, udito che c’è un solo Dio in cielo, che regge e contiene ogni cosa, immaginò, come un bambino allevato tra i monti, che, siccome il cielo, dove si trova la reggia di Dio, incombe sui monti, potesse raggiungerla, passando per i monti. Tornando spesso a pensare a ciò, accadde che una notte vide in visione se stesso che doveva salire la cima del monte, e giungere alla reggia del grande re Dio. Però, prima che cominciasse a salire il monte, vide nella pianura che si estendeva ai piedi del monte delle donne, che erano ancelle del Re, raccogliere le messi, ma facevano ciò con molta negligenza e contro voglia. Il bambino, dispiacendosi e arrabbiandosi per la loro negligenza, si propose di accusarle presso il signor re. Quindi, scalato il monte, salì alla casa regale. Trovò il signore solo con un suo servitore. Infatti aveva inviato – così gli pareva – la sua famiglia a raccogliere le messi. Entrando il bambino fu chiamato dal signore. Si avvicinò e sedette ai suoi piedi. Interrogato con gioconda affabilità chi fosse, da dove e cosa volesse, rispose alle domande quel che sapeva. Allora, su comando del signore, fu portato dal servitore del pane bianchissimo, e davanti a lui mangiò. Il giorno dopo, ritornando con il pensiero a ciò che aveva visto, essendo un bambino semplice e innocente, credette che veramente fosse stato in cielo e avesse mangiato il pane del Signore, e ciò affermava pubblicamente davanti a tutti2.
Questo racconto è piuttosto interessante per diversi motivi. Anzitutto non vi è dubbio che sia stato raccontato dallo stesso Anselmo. Il grande intellettuale non ha paura di raccontare che da bambino credeva che dalle montagne fosse possibile arrampicarsi fino al cielo. Non ha paura nemmeno di dire che si tratta di un sogno, sognato durante la notte. Ma che da bambino, una volta svegliato, credeva di aver veramente vissuto quel che aveva visto. Si può dire che questo sia uno dei primi sogni di bambino nella storia, di cui sia rimasta traccia scritta.
Questa sensibilità di Anselmo nei confronti dell’infanzia si vede in un caso, raccontato sempre nella sua Vita, in cui deve affrontare un piccolo oblato recalcitrante. Si può dire che la sua strategia fu totalmente diversa da quella usata da Rabano Mauro nei confronti di Gotescalco.
Un certo Osberno, ancora adolescente, era monaco di quello stesso monastero. Di ingegno penetrante, dotato di mani abili nel produrre una varietà di lavori, con le egregie capacità che possedeva fondava la speranza di una buona riuscita. Ma la sua condotta assai perversa ne offuscava il pregio, senza dire dell’odio che, come un cane rabbioso, nutriva contro Anselmo. Questi, senza dare, per parte sua, molto peso a un tale odio, nel vivo desiderio di accordare il suo comportamento all’acutezza dell’ingegno, incominciò con santa astuzia a blandire con amorevoli attenzioni quell’adolescente, a passar sopra benevolmente alle sue monellerie, a concedergli molte delle cose che si potevano tollerare senza danno per la disciplina monastica, e in cui la sua età trovasse modo di divertirsi e il suo spirito sbrigliato piegarsi e diventare docile3.
I risultati di tale strategia non si fanno attendere.
Il bambino si rallegra per tali cose, e, poco a poco il suo animo viene ammansito. Cominciò ad amare Anselmo, ad accogliere i suoi ammonimenti e a cambiare i suoi comportamenti. E lui, intuendo ciò, più di tutti gli altri lo abbracciava, lo nutriva, lo sosteneva, e lo istruiva ed esortava affinché progredisse sempre più in ogni cosa. Da allora, poco alla volta, le cose puerili che gli aveva concesso, gliele sottrasse, e lo spinse a giungere a una onesta maturità di costumi. Non deluso con la sua pia sollecitudine, i suoi moniti sacri giovano e rafforzano nel giovane. Perciò dove dubitava di confidare della fermezza dell’impegno dell’adolescente, subito eliminava in lui ogni atto puerile e se si persuadeva che ci fosse qualcosa da rimproverare, non solo con le parole, ma anche con la verga subito lo puniva. E quello? Sostiene ogni cosa serenamente, confermato nel proposito di vita religiosa, fervendo nell’esercizio per imparare ogni buona azione, sopporta pazientemente le offese, gli insulti, le maldicenze degli altri, conservando verso tutti un affetto di amore sincero. Il padre si rallegra in queste cose, più di quanto si possa dire, e ama quel figlio con un santo fuoco di carità, più di quanto si possa credere4.
Come si vede, i metodi usati sono pur sempre quelli della disciplina. Anche Anselmo non tralascia di usare la verga, se lo ritiene necessario. Quel che è cambiato però è l’atteggiamento: Anselmo non ha paura del bambino, pensa di poterlo correggere poco per volta, più con l’amore che con il castigo. Questa impostazione si vede ancora meglio in un altro episodio, riportato sempre nella Vita scritta da Eadmero.
Una volta un certo abate, che era ritenuto molto religioso, parlava con lui di quelli che erano nella vita monastica, e tra le altre cose diceva qualcosa dei bambini che erano allevati nel chiostro, aggiungendo: “Mi chiedo, cosa fare di questi? Sono perversi e incorreggibili, non smettiamo di picchiarli giorno e notte, ma quelli diventano sempre peggio”. A queste parole stupito Anselmo: “Non smettete” disse, “di picchiarli? E quando saranno adulti che adulti saranno?”. “Ebeti” disse, “e bestiali”. Ma quello: “Con quale buon risultato spendete il vostro nutrimento, se da uomini ne fate delle bestie?”. “E noi” disse, “cosa possiamo fare? In tutti i modi li costringiamo perché migliorino e non migliorano affatto”5.
È chiaro che il dialogo mette in discussione uno dei principi fondamentali della pedagogia antica e medievale: quello dei metodi coercitivi. Il problema che Anselmo pone con chiarezza è quello dell’utilità dei castighi corporali.
“Li costringete? Dimmi, ti chiedo, signor abbate, se pianti un albero nel tuo giardino, e subito lo chiudi da ogni parte, così che non può stendere i suoi rami da nessuna parte, se dopo anni lo liberi, che albero credi che avrai prodotto? Prevedo un albero inutile, con rami ricurvi e aggrovigliati. E di ciò di chi sarà la colpa se non tua, tu che lo hai chiuso senza moderazione? Certamente avete fatto così con i vostri bambini: sono stati piantati con l’oblazione nel giardino della Chiesa affinché crescano e diano frutto per Dio. Voi però li avete talmente coartati con terrori, minacce e botte che non è loro permesso godere di alcuna libertà. Così, oppressi in maniera indiscreta, hanno concepito tra sé pensieri malvagi, contorti come spine, e crescono si nutrono e si sostengono a tal punto con essi, che sfuggono con mente ostinata ogni cosa che possa correggere tali pensieri. Per questo accade che, poiché non sentono in voi nulla di amore, nulla di pietà, nulla di benevolenza o di dolcezza verso di loro, né essi attendono da voi in seguito qualcosa di buono, ma credono che ogni vostra azione nasca dall’odio e dalla invidia contro di loro. Accade quindi in maniera miserabile che, come crescono nel corpo, così cresce in loro l’odio e il sospetto di ogni male, sempre inclini e pronti ai vizi. Non essendo stati nutriti per nulla nella vera carità, nulla sapranno guardare se non con sopraccigli alzati e con occhio torvo. Ma, per Dio, voglio che mi diciate, qual è la ragione per la quale siete stati tanto ostili verso di loro? Non sono uomini? Non sono della stessa natura di cui anche voi siete? O vorreste che accada a voi quel che fate a loro? Se veramente ciò che essi sono voi siete? Ma sia. Li volete formare alle buone maniere solo con botte e frustate? Avete mai visto un artista formare una bella immagine da una lamina di oro solo con percussioni? Non credo. E allora? Fino a quando la lamina non si adatta alla forma, ora dolcemente la preme e la percuote con il suo strumento, ora la rialza e le dà forma dolcemente con delicato sostegno. Così anche voi, se volete che i vostri bambini siano bene educati, è necessario che insieme ai rimproveri delle parole usiate con loro il sostegno e il conforto della pietà e della dolcezza paterna”6.
Difficile sottovalutare l’importanza di queste parole. Anselmo chiarisce con forza l’inutilità di un approccio pedagogico basato sulla violenza. L’esempio dell’albero e dell’orefice descrivono bene il progetto educativo prospettato da Anselmo. Non si tratta solo di reprimere, ma anche di incoraggiare e sostenere.
A queste parole l’abbate: “Quale conforto? Quale sostegno? Noi ci impegniamo a far loro affrontare gravi e improvvise difficoltà”. Al quale lui: “Bene davvero, sia un pane che un denaro sono utili e buoni, vantaggiosi per chi li usa. Ma se togli il latte e vuoi nutrire un lattante, vedrai che si strangolerà piuttosto che divertirsi. Perché questo? Non voglio dirlo, dal momento che è evidente. Tuttavia ricordatevi che, come il corpo, se fragile o forte, per la sua qualità ha bisogno del cibo opportuno, così l’anima fragile o forte, per la sua misura ha bisogno del suo cibo. L’anima forte ha bisogno e si rallegra con cibo solido, come la pazienza nelle tribolazioni, il non desiderare le cose altrui, l’offrire l’altra guancia a chi ti percuote su una guancia, il pregare per i nemici, l’amare chi ci odia, e molte altre cose di questo tipo. L’anima invece fragile e ancora tenera nel servizio di Dio, ha bisogno di latte, cioè della mansuetudine degli altri, della benignità, della misericordia, della consolazione gioiosa, della sopportazione caritatevole, e molte altre cose simili. Se vi adatterete in tal mondo ai vostri, sia forti che deboli, per la grazia di Dio, per quanto è in vostro potere, li conquisterete tutti”7.
L’anima forte è diversa dall’anima fragile. In queste parole Anselmo rivela tutta la saggezza della pedagogia monastica. Chi parla è, prima di tutto, un vero “pastore d’anime” come avrebbe voluto Gregorio Magno, e, proprio per questo, è anche un grande educatore. In qualità di abbate, Anselmo ha imparato a “discernere”, cioè a comprendere nell’intimo, l’anima dei suoi monaci e applica gli stessi criteri anche ai monaci bambini, cioè a quegli oblati, che venivano educati in monastero.
1 Eadmero, Vita sancti Anselmi, XI, ed. critica S.W. Southern. trad. it. S.M. Malaspina, Milano 2009, p. 45.
2 Eadmero, Vita sancti Anselmi, II, trad. mia.
3 Eadmero, Vita sancti Anselmi, X, trad. it. S. Malaspina, Milano 2009, p. 39.
4 Eadmero, Vita sancti Anselmi, X, trad. it. S.M. Malaspina, Milano 2009, p. 41.
5 Eadmero, Vita sancti Anselmi, libro I, n. 22, trad. mia.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
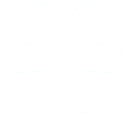 NOTEdiSTORIA
NOTEdiSTORIA