Innocenzo III è forse il papa più studiato del Medioevo. La sua importanza storica è fuor di dubbio. Egli riuscì per diversi decenni ad essere l’ago della bilancia della politica europea. Il suo pontificato può essere considerato il vertice della potenza temporale dei pontefici. La sua influenza, anche attraverso il Concilio Lateranense IV, da lui promosso nel 1215, è stata decisiva nella storia della Chiesa per molti secoli. Le sue idee e le sue azioni nei confronti dei bambini però sono state poco studiate. Eppure non vi è dubbio che ebbero un’influenza notevole nel suo tempo e in seguito.
Tutti sanno che, quando ancora era un giovane cardinale, l’allora Lotario dei Conti, scrisse un libello, intitolato De miseria humanae conditionis, conosciuto anche con il titolo De contemptu mundi. Il contenuto è una riflessione sulla fragilità della vita dell’uomo, con l’invito a non confidare nelle proprie forze. L’incipit del libello è quanto mai efficace:
“Perché sono uscito dal grembo di mia madre, a vedere tribolazioni e dolori e a consumare i miei giorni nella confusione?” Se così parlò chi fu santificato nel grembo dal Signore [il profeta Geremia n.d.c.], che dirò io, concepito da mia madre nel peccato? Ohimè, dirò, perché o madre mia mi concepisti come un figlio di amarezza e dolore? “Perché non morii nella vagina? E subito uscito dalla vagina non sono morto? Perché fui accolto sulle ginocchia e allattato alla mammella?” nato come sono “per esser bruciato, per esca del fuoco? Oh, fossi stato ucciso nel grembo, e tomba mi fosse stata mia madre, e il concepimento della sua vagina non avesse avuto mai fine! Sarei stato come se non fossi stato, trasferito dalla vagina alla tomba”. Chi dunque darà ai miei occhi “una sorgente di lacrime” affinché io pianga la nostra pietosa entrata nella condizione umana, la rea avanzata nella società umana e la dannata uscita con la dissoluzione fisica? Esaminerò dunque, nel pianto, di che sia fatto l’uomo, cosa faccia e cosa avverrà di lui. L’uomo è fatto certamente di terra, concepito nella colpa, nato per la punizione; le sue azioni sono malvagie e illecite, turpi e indecenti, vane e inutili. Egli sarà esca del fuoco, nutrimento di vermi, un ammasso di putridume. Mi spiegherò più chiaramente; farò una descrizione più completa. L’uomo è costituito di polvere, di fango e cenere, ancor peggio: di un seme immondissimo. È concepito da un prurito della carne, nel bruciore della libidine, nel fetore della lussuria, ancor peggio, con l’onta del peccato1.
Il giovane cardinale riassume qui tutta la tradizione precedente. La condizione umana è marcata, sin dal concepimento, dalla fragilità e dal peccato. Il riferimento alle idee di Agostino è del tutto evidente. L’idea della trasmissione del peccato originale attraverso la libidine dell’atto sessuale risaliva a Tertulliano. Lotario esprime concetti antichi con forza originale. La condizione infantile ne è caratterizzata sin dal concepimento.
Il concepimento è duplice, del seme e della natura. Il primo è nell’atto il secondo nell’effetto, e il primo è opera dei genitori, il secondo è la prole che ne deriva. Chi ignora che l’amplesso, anche fra coniugi, non può essere mai compiuto senza il prurito della carne, l’ardore della libidine, il fetore della lussuria? Perciò il seme fecondato è infetto, contaminato e corrotto, e l’anima che vi è infusa contrae la corruzione del peccato, la macchia della colpa, la sozzura dell’iniquità, come il liquido versato in un recipiente guasto si guasta, e al tocco di un oggetto infetto si è infettati dal semplice contatto2.
Lotario unisce le conoscenze teologiche con quelle filosofiche e, per così dire, scientifiche. In questo senso sono molto interessanti le sue osservazioni sul feto. Egli si pone infatti la domanda “di quale cibo si nutra nell’utero il nascituro”.
Ascolta ora quale cibo nutra nell’utero il nascituro. È chiaro: nient’altro se non sangue mestruale, il quale cessa nella donna dopo il concepimento per nutrire il bambino concepito nel suo grembo. Di quel sangue si dice che sia una così abbominevole sozzura da impedire col suo solo contatto la germinazione delle messi, seccare le piante, far morire l’erba, far perdere agli alberi i frutti, rendere idrofobi i cani che ne mangiano. Il feto concepito contrae il difetto del seme, per cui da quella corruzione nascono lebbrosi ed elefantiaci. Perciò nella legge mosaica la donna durante il periodo mestruale è considerata immonda e per chi allora l’avvicina è comminata la pena di morte; a causa dell’impurità del mestruo vige la prescrizione per la donna di astenersi dall’entrare nel tempio per quaranta giorni se genera un maschio, per ottanta se partorisce una femmina3.
Qui pregiudizio antifemminile e anti infantile si sposano. Il feto è tanto più disprezzabile in quanto, come il sangue mestruale di cui si nutre, è immondo. E, forse proprio per questo, è anche costituzionalmente fragile. Lotario parte dall’immagine dei bambini disabili.
“Perché mai viene data la luce a un infelice e la vita a chi ha un’anima amara?”. Fortunati i morti prima della nascita, chi subisce la morte prima di conoscere la vita! Alcuni nascono così deformi e singolari da sembrare non esseri umani ma abomini della natura: probabilmente per costoro sarebbe stato più provvido non essere mai venuti alla luce, poiché li si mostra come mostri e li si presenta come portenti. Molti nascono con gli arti contratti e i sensi insufficienti, tristezza per gli amici, onta per i genitori, disagio per i parenti4.Ma il riferimento ai disabili serve a Lotario solo per dire che, alla fin fine, ogni neonato è simile a loro.
Ma perché accennare a qualcuno in particolare, quando tutti indistintamente nasciamo ignoranti, muti, inetti? E gemebondi, deboli, fragili, poco più che bestie, anzi in molte cose inferiori a loro. Le bestie appena venute alla luce camminano, mentre noi non soltanto non camminiamo eretti sulle gambe ma non strisciamo nemmeno con le mani5.Il riferimento diretto di Lotario, in questo caso, è Aristotele, il quale, come abbiamo visto, aveva detto che i piccoli dell’uomo “vengono al mondo più incompiuti di tutti gli altri animali compiuti”6. Il discorso in ogni caso prosegue con la descrizione del parto.
Tutti nasciamo gemendo, quasi a esprimere la miseria della nostra natura. Il maschio appena nato grida: “Ah!” la femmina “Eh!”. Onde il verso: Dirà “Eh!” o “Ah!” chiunque nasce da Eva. Infatti il nome Eva cos’altro è se non un Eh e un a? Due esclamazioni che esprimono entrambe un dolore grandissimo; e perciò la donna prima del peccato fu chiamata giustamente “virago”, e dopo il peccato “Eva”, quando le fu detto: “Partorirai con dolore”. Nessun dolore pareggia quello delle partorienti. Rachele per l’eccesso di dolore nel parto morì, e morendo chiamo il suo figlio «Benoni», ossia “Figlio del dolore”… La donna, come un naufrago, “nel partorire ha una pena, ma dopo aver partorito un bambino non ricorda più l’afflizione per la gioia della venuta al mondo di un uomo”. Concepisce dunque con immondezza e fetore, partorisce con tristezza e dolore, nutre con pena e fatica, alleva con ansia e timore7.
Lotario si rifà ad Agostino, che aveva sottolineato come i bambini, nascendo, piangono, profetizzando così i dolori che li attendono nella vita8. È interessante notare come la citazione del passo evangelico di Giovanni 16,21, in cui invece si parla della gioia perché è venuto al mondo un uomo, non impedisca al cardinale di ribadire che la nascita non è un evento gioioso, ma piuttosto foriero di difficoltà e sofferenze. La prova in definitiva è, agli occhi di Lotario, nella nudità del neonato.
Nudo l’uomo viene al mondo e nudo ne esce, povero giunge e povero parte. “Nudo” dice Giobbe, “uscii dal grembo di mia madre e nudo tornerò in quello della terra; nulla abbiamo portato in questo mondo, e senza dubbio non possiamo portarne via nulla”. Se vi si entra vestiti, ecco di quale indumento: con un nome osceno a dirsi, più osceno a udirlo, e oscenissimo alla vista: una membrana schifosa, sozza di sangue9.
Lotario divenne papa nel 1198 all’età di 37 anni. Nella sua attività come vescovo di Roma volle dare subito ampio risalto alla predicazione. Ci restano numerosi sermoni pronunciati da Innocenzo III in diverse occasioni, che lui stesso volle conservare e riunire. In questa attività di predicazione il papa non poteva non misurarsi con le feste liturgiche da una parte e con le particolari tradizioni della chiesa di Roma dall’altra. Un caso molto interessante è quello dei sermoni pronunciati da Innocenzo in occasione del Natale, perché in essi si doveva misurare con l’immagine di un Dio che si fa bambino.
Il Signore si è fatto servo, l’eterno è diventato un bambino, l’eccelso un fanciullo, l’immenso un particolare, il semplice è divenuto composito, l’immortale mortale, Padre di sua madre e figlio di sua figlia… alla nascita di Cristo ai Magi apparve una stella, come aveva vaticinato Baalam: “una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele”10.
Il paradosso è soltanto apparente: proprio perché aveva un’idea così debole del bambino, Innocenzo sottolinea la riflessione su un Dio che si umilia fino a farsi bambino. Ci sono dunque attitudini ambivalenti del papa nei confronti dei bambini, ma bisogna anche dire che il suo atteggiamento subì dei cambiamenti legati alle circostanze storiche in cui visse.
In quanto papa infatti Innocenzo dovette fronteggiare una situazione sociale che andava cambiando. Il suo pontificato infatti coincide con un momento particolare della storia della città di Roma, la quale stava uscendo dalla depressione in cui era caduta nei secoli precedenti. Nell’Alto Medioevo la città che era stata capitale dell’Impero era finita ad essere poco più di un borgo di 20.000 abitanti. Nel secolo precedente al pontificato di Innocenzo III, però, Roma, come tutte le città in Italia centro settentrionale, ma anche in Linguadoca, nelle Fiandre e nella valle del Reno in Germania, aveva conosciuto una nuova espansione demografica ed economica. All’inizio del XIII secolo le città, in queste aree dell’Europa, tornavano ad avere un ruolo centrale nella vita sociale e culturale della cristianità. La svolta era di non poco conto. Per tutto l’Alto Medioevo, cioè dal VI all’XI secolo, la società europea era stata prevalentemente rurale. I due monumenti-simbolo del Medioevo non a caso sono ancora oggi due monumenti rurali: l’abazia e il castello.
Quando la città riprende ad essere il motore della crescita della società europea, si registrano numerose trasformazioni sociali. La nascita di nuovi ceti legati all’economia mercantile, la diffusione di nuove domande culturali, la crescita del numero dei salariati, lavoratori senza garanzie, sempre esposti al pericolo di cadere in povertà. Anche la condizione dei bambini in città è diversa dalla condizione dei bambini in campagna. Davanti a tutte queste trasformazioni Innocenzo non resta indifferente, secondo la testimonianza dei Gesta di Innocenzo III, la biografia scritta immediatamente dopo la sua morte.
Dall’inizio del suo pontificato, destinò ad elemosine tutti i proventi che gli spettavano dalle offerte alla basilica di San Pietro… Faceva dunque sfamare gli affamati, rivestire gli ignudi, maritare le ragazze povere, alimentare i fanciulli abbandonati11.
In città i bambini abbandonati divengono un problema sociale. Mentre in campagna si praticava l’infanticidio di nascosto, sotto le spoglie di culti religiosi o meno, in città i bambini abbandonati vagavano per le strade, cercando qualcosa da mangiare. Bambini mendicanti, bambini di strada, bambini in ogni caso a cui non riusciva più a rispondere l’aliena misericordia, cioè la pietà dei singoli fedeli. Innocenzo con molta probabilità pensando anche a loro, creò, o forse riorganizzò, un’istituzione, che si sarebbe dovuta occupare di tutte queste nuove povertà: l’ospedale di Santo Spirito. I Gesta lo raccontano con molti particolari.
A proprie spese, per i malati e i poveri, fece anche l’ospedale di Santo Spirito presso Santa Maria in Sassia, sulla strada pubblica presso il Tevere, davanti alla basilica di san Pietro; è già abbastanza evidente di per sé quanto lo abbia arricchito e dotato di edifici, possessi, rendite, tesori, ornamenti, libri e privilegi, perché vi sovrabbondino sempre il culto religioso e la grazia dell’ospitalità, che già ora vi sono presenti12.
Tra i malati e i poveri è molto probabile che, sin dall’inizio, fossero compresi anche i bambini. Quasi alla metà del lato dell’attuale Ospedale di Santo Spirito che dà sulla Via di Borgo S. Spirito si può ancora vedere la «ruota» girevole entro la quale le madri disgraziate, volendo conservare l’anonimato, deponevano i neonati di cui volevano sbarazzarsi. Non sappiamo se questa «ruota» sia ancora quella del XIII secolo, in ogni caso l’ordine religioso che si occupava dell’Ospedale si dotò di una Regola, che gli studi recenti fanno risalire alla prima metà del XIII secolo. In questa Regola compare, tra le altre opere di misericordia, la cura dei bambini proietti, cioè l’assistenza ai bambini esposti, abbandonati.
Nei secoli seguenti la cura di questi bambini diverrà l’opera che assorbirà la maggior parte delle entrate del pio istituto13. L’abbandono dei minori diverrà un fenomeno sempre crescente nella società europea. Ancora oggi la diffusione del cognome Proietti in area romana dimostra l’importanza che l’istituzione voluta da Innocenzo III ha avuto nella vita di tanti bambini.
1 Lotario di Segni, La miseria della condizione umana. De contemptu mundi, trad. it. di Carlo Carena, Mondadori, Milano 2003, pp. 5-7 [il volume riproduce anche il testo latino, tratto dall’edizione a cura di M. Maccarone, Lugano 1955]
2 Innocenzo III, La miseria della condizione umana, I, 3, p. 10.
3 Lotario di Segni, La miseria della condizione umana, I, 4, pp. 12-13.
4 Ibidem, I, 5, trad. it. p. 14.
5 Ibidem.
6 Aristotele, Riproduzione degli animali, libro V, 1, p. 1012.
7 Lotario di Segni, La miseria della condizione umana, I, 6, p. 16.
8 Agostino d’Ippona, Sermo 167, 1: «Istos pueros qui nascuntur, interrogemus, quare a ploratu incipiunt, qui et ridere possunt. Nascitur, et statim plorat; post nescio quot dies ridet. Quando plorabat nascens, propheta suae calamitatis erat; lacrimae enim testes sunt miseriae. Nondum loquitur, et iam prophetat. Quid prophetat? In labore se futurum, vel in timore. Et si bene vixerit et iustus fuerit, certe in mediis positus tentationibus semper timebit.»
9 Lotario di Segni, La miseria della condizione umana, I, 7, p. 16.
10 Innocenzo III, Sermone B2, in I Sermoni, in PL 217, Paris 1890, coll. 309-688; trad. it. Stanislao Fioramonti, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006, p. 263.
11 Gesta di Innocenzo III, n. 143, traduzione di S. Fioramonti, a c. di G. Barone A. Paravicini Bagliani, Viella, Roma 2011, p. 274.
12 Gesta di Innocenzo III, n. 144, traduzione di S. Fioramonti, p. 274.
13 Anna Esposito, I proietti dell’ospedale S. Spirito di Roma: percorsi esistenziali di bambini e famiglie (secc. XVXVI).
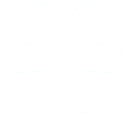 NOTEdiSTORIA
NOTEdiSTORIA