Francesco d’Assisi non è soltanto un santo cristiano molto venerato, è anche il personaggio storico del Medioevo su cui si scrive di più. Più dello stesso papa Innocenzo III, o dell’imperatore Federico II di Svevia, che erano suoi contemporanei. La cosa è piuttosto sorprendente, se si considera che Francesco non aveva fatto studi approfonditi e si definiva semplice e idiota.
Non sono molti però gli studi dedicati all’atteggiamento di Francesco d’Assisi verso l’infanzia. Eppure si tratta di un tema certamente non secondario. Tutti infatti conoscono un episodio raccontato nella prima Vita, scritta, subito dopo la sua canonizzazione da un suo discepolo, frate Tommaso da Celano. Si tratta dell’episodio del Natale di Greccio. Tommaso colloca l’episodio in una posizione strategica: al termine del suo primo libro, in cui narra tutta la vita di Francesco, subito prima del secondo libro, che è invece dedicato esclusivamente agli ultimi due anni del santo, con le Stimmate e il racconto della morte. È quindi un racconto a cui l’autore vuol dare molto rilievo.
C’era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita anche migliore, ed era molto caro al beato Francesco perché, pur essendo nobile e molto onorato nella sua regione, stimava più la nobiltà dello spirito che quella della carne. Circa due settimane prima della festa della Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé e gli disse: “Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico: vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra un bue e un asino”. Appena l’ebbe ascoltato, il fedele e pio amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto l’occorrente, secondo il disegno esposto dal Santo1.
Francesco intende riflettere sulla condizione del bambino nato a Betlemme, con i disagi di chi manca delle cose necessarie ad un neonato, messo in una greppia, in mezzo alle bestie. Anche Innocenzo III, pochi anni prima, aveva descritto con crudezza la debolezza e la fragilità dei neonati. In Francesco però questa estrema debolezza non suscita disprezzo, ma, al contrario, tenerezza. È tutto organizzato come per un’occasione di festa.
E giunge il giorno della letizia, il tempo dell’esultanza! Per l’occasione sono qui convocati molti frati da varie parti; uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ciascuno secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per illuminare quella notte, nella quale s’accese splendida nel cielo la Stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco: vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio ed è raggiante di letizia. Ora si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l’asino. In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l’umiltà. Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. Questa notte è chiara come pieno giorno e dolce agli uomini e agli animali! La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima, davanti al nuovo mistero. La selva risuona di voci e le rupi imponenti echeggiano i cori festosi. I frati cantano scelte lodi al Signore, e la notte sembra tutta un sussulto di gioia. Il Santo è lì estatico di fronte al presepio, lo spirito vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile.
Che cosa avviene esattamente quella notte a Greccio? Una festa? Una rappresentazione teatrale? Un presepe vivente? Niente di tutto questo. Francesco vuole che, lì, in quel posto da bestie, si celebri una liturgia, cioè la Messa di Natale.
Poi il sacerdote celebra solennemente l’Eucaristia sul presepio e lui stesso [Francesco] assapora una consolazione mai gustata prima. Francesco si è rivestito dei paramenti diaconali, perché era diacono, e canta con voce sonora il santo Vangelo: quella voce forte e dolce, limpida e sonora rapisce tutti in desideri di cielo. Poi parla al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato Re povero e la piccola città di Betlemme.
A questo punto avviene qualcosa di straordinario. I frati erano abituati al modo di parlare di Francesco, che non usava un linguaggio clericale, ma sapeva suscitare con le sue parole i sentimenti più profondi. Anche in questo caso le parole di Francesco hanno un valore inconsueto.
Spesso, quando voleva nominare Cristo Gesù infervorato di amore celeste lo chiamava “il Bambino di Betlemme”, e quel nome “Betlemme” lo pronunciava riempiendosi la bocca di voce e ancor più di tenero affetto, producendo un suono come belato di pecora. E ogni volta che diceva “Bambino di Betlemme” o “Gesù”, passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole2.
Si comprende questo passaggio della Vita di Tommaso da Celano solo se si pensa che Francesco dovette predicare a Greccio non in latino, come facevano i chierici, ma in lingua volgare, nel dialetto di quelle parti, che era lo stesso che si parlava ad Assisi. In latino infatti “Bambino di Betlemme” si dice – ed è così che lo chiama Tommaso da Celano – “puer de Bethlehem”. Ma la parola “puer” non ricorda affatto il belato delle pecore, a differenza della parola “bambino”.
Francesco aveva riflettuto a lungo sul belato delle pecore. Secondo una fonte poco conosciuta, in un’occasione avrebbe detto: “Fratello mio agnello, animale innocente e tanto utile agli uomini, che chiami sempre e annunci il bene”3. Adesso invece si sofferma a pronunziare con delicatezza le parole “bambino di Betlemme”, passandosi la lingua tra le labbra, per gustare e trattenere la dolcezza di queste parole.
Se questa ricostruzione è esatta, ci troveremmo qui di fronte ad una delle prime testimonianze dell’uso della parola “bambino” nella storia della lingua italiana. Questa parola infatti, come è noto, non esiste in latino. Per indicare i piccoli dell’uomo il latino usa soprattutto due parole: “puer” e “infans”. Sono tutte e due parole negative. “Puer” viene dalla stessa radice di “paucus” o “pauper” e indica chi è poco, piccolo. “Infans” invece viene da “in – falo” che vuol dire “non – parlo”. L’“infante” è per definizione colui che non ha la parola. È vero che in latino esistono anche dei vezzeggiativi, come “pupus”, da cui deriva l’italiano “pupo”, e “puella”, che significa “bambina”, ma è pur vero che le parole di gran lunga più attestate restano per secoli “puer” e “infans”.
Nel corso del Medioevo invece cominciano ad affermarsi parole fino ad allora sconosciute per indicare i piccoli umani. In italiano “bambino”, in spagnolo “niño”, in inglese “baby”, in francese (ma solo per i neonati) “bébé”. La parola italiana è il diminutivo di “bimbo”. Forse Francesco ha detto “il bimbo di Betlemme”. Si può avanzare l’ipotesi che tutte queste parole nascano dal linguaggio stesso dei bambini, cioè dalla lallazione che i piccoli cominciano a sviluppare tra il quarto e quinto mese di vita4. Tante parole nascono così: mamma, papà, nonno, nonna, pappa, cacca, ninna, bua… Questa etimologia non è sicura, ma nello stesso periodo in altre lingue neo latine, come il portoghese, per dire pueri si affermavano altre parole come crianças, che rivelano la loro origine cristiana. Il fatto che le nuove lingue europee abbiano avvertito il bisogno di trovare nuove parole per indicare i bambini è segno di una nuova attenzione verso di loro. È molto probabile che Francesco d’Assisi sia stato testimone e protagonista di questa nuova attenzione verso i bambini, che lui chiama con il nome con cui li chiamavano le mamme e non più con il nome latino.
In ogni caso il significato dell’episodio di Greccio non si limita soltanto a una parola. Il contrasto è tutto tra il Re e il povero. Gesù è il re che i Magi sono venuti ad adorare dall’Oriente, ma è anche un povero bambino, tanto povero da nascere in una mangiatoia, in mezzo alle bestie. L’ossimoro si può rovesciare: quel povero è re! Quel bambino pieno di disagi, che non ha dove essere posto, in realtà è il Re dei Re, il Signore, Dio dell’universo! Come spesso accade a Francesco, non si limita a predicare… comunica il vangelo con tutto se stesso. Il modo di pronunciare le parole colpisce l’attenzione dei presenti. Per Francesco il nome di Dio non è “indicibile” come nella tradizione veterotestamentaria e altomedievale; il nome di Dio è per lui, al contrario, talmente soave che lo si può gustare e assaporare, riempiendo la bocca di ogni dolcezza. Il Re dei Re ha scelto di farsi povero, fino a incarnarsi in un bambino nato lungo la strada, senza casa, in mezzo alle bestie. Quale amore più grande di questo?
Qual è l’atteggiamento di Francesco davanti al bambino? Tommaso da Celano dice che “il santo sta in piedi di fronte alla mangiatoia, pieno di sospiri, contrito per la pietà ma ripieno di gaudio ineffabile”. I sentimenti di Francesco sono due: la contrizione, cioè il dispiacere davanti ai disagi del bambino che nasce tra le bestie, e il gaudio ineffabile, davanti all’amore che quel bambino incarna per gli uomini. Lo stesso Tommaso da Celano dirà che Francesco aveva gli stessi sentimenti un anno più tardi, sul monte della Verna, quando ebbe la visione del serafino crocifisso. Anche in quel caso il dolore davanti a tanta sofferenza si associava alla gioia davanti ad uno sguardo d’amore così intenso. Di quella gioia e di quel dolore Francesco porterà i segni nella sua carne per il resto della sua vita.
La liturgia del natale del 1223 a Greccio non era frutto di improvvisazione. Francesco meditava da anni su questi misteri. Ne abbiamo traccia nel suo Ufficio della croce, un testo che Francesco aveva composto e imparato a memoria e che era solito recitare tutti i giorni a intervalli regolari, ogni tre ore. Era questo il modo con qui Francesco ogni giorno si ricordava degli ultimi momenti della vita di Gesù. L’Ufficio era stato composto prima di tutto per la Settimana Santa, anzi, più esattamente, per ricordare il tempo tra l’Ultima cena e la Crocifissione di Gesù. Ma in seguito Francesco aveva aggiunto alcuni salmi, da lui composti, per le feste più importanti. Uno di questi salmi è dedicato proprio al Natale. In esso c’è, tra le altre cose, una notazione particolare.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: esultiamo e rallegriamoci in esso.
Perché il santissimo bambino che amiamo ci è stato dato, e per noi è nato lungo la via e deposto in una mangiatoia, perché non c’era posto in albergo.
Francesco, per scrivere questo salmo, utilizza passi della Scrittura. È molto importante però sottolineare le aggiunte che egli fa, perché in esse si ritrovano le cose che per lui erano talmente importanti che dovevano essere aggiunte persino al testo sacro. Una di queste aggiunte è rappresentata dalle parole “in via”, che possono essere tradotte “lungo la strada”. Francesco dice: “il santissimo bambino che amiamo ci è stato dato, e per noi è nato lungo la strada e deposto in una mangiatoia”. Nel testo evangelico non si usa l’espressione “in via”, “lungo la strada”, anche se è chiaro che Gesù nacque mentre Giuseppe e Maria erano in viaggio per andare a farsi registrare per il censimento.
L’osservazione che Gesù sia nato “per strada” forse Francesco l’ha ripresa dalla liturgia, ma in ogni caso ha voluto farla propria. Per lui era molto importante sottolineare che il bambino era un senza fissa dimora, un profugo, un pellegrino.
In quello stesso periodo in cui volle realizzare il ricordo di Betlemme a Greccio, Francesco stava componendo la Regola per i suoi frati. Nella prima stesura di questa Regola (quella conosciuta come Regola non bollata, cioè non approvata dalla Sede Apostolica) c’è un passo molto significativo: “[i frati] devono essere lieti quando vivono tra persone di poco conto e disprezzate, tra poveri e deboli, tra infermi e lebbrosi e tra i mendicanti lungo la strada”5. Anche in questo caso torna l’espressione lungo la strada. I frati debbono essere lieti quando si trovano in mezzo a chi vive lungo la strada, esattamente come Gesù è nato lungo la strada. Vivere lungo la strada fa parte del cuore della sequela di Gesù, secondo la lettura di Francesco.
In sintesi cosa è successo a Greccio quella notte? Francesco ha fatto celebrare una Messa solenne in una stalla, con un altare sistemato su una mangiatoia, in mezzo alle bestie e lì ha cantato e predicato sul Vangelo di Natale. Con quella celebrazione e con le parole di Francesco i presenti ebbero l’impressione di vedere proprio il bambino Gesù di cui Francesco parlava. Anzi, uno dei presenti, con molta probabilità lo stesso messere Giovanni di Greccio (colui al quale Francesco aveva chiesto di preparare tutto per la cerimonia) raccontò di averlo visto.
uno dei presenti, uomo virtuoso, ha una mirabile visione. Gli sembra che il Bambinello giaccia privo di vita nella mangiatoia, e Francesco gli si avvicina e lo desta da quella specie di sonno profondo6.
Il commento di fra Tommaso da Celano è particolarmente significativo.
Né la visione prodigiosa discordava dai fatti, perché, per i meriti del Santo, il fanciullo Gesù veniva risuscitato nei cuori di molti, che l’avevano dimenticato, e il ricordo di lui rimaneva impresso profondamente nella loro memoria7.
Spesso si ha l’idea che nel medioevo tutti fossero naturalmente cristiani. Invece, come nota questo testo, anche al tempo di Francesco Dio sembrava come morto, o almeno addormentato, nel cuore di tanti. La celebrazione di Greccio ha saputo risvegliare nei cuori dei presenti (e di coloro che ne ascoltavano il racconto) la coscienza della presenza di Dio nella vita degli uomini. Francesco sembra ricordare agli uomini del suo tempo (e di ogni tempo) che Dio c’è, anzi, che Dio si è fatto tanto vicino, che è possibile incontrarlo in un bambino che nasce povero, lungo la strada.
1 Tommaso da Celano, Vita beati Francisci, I, XXX, 86.
2 Ibidem.
3 Ms Little 197: «Frater mi agnicule, animal innocens et hominibus valde utile, clamans semper et annuntians bene».
4 I linguisti non sono unanimi nello stabilire l’etimologia della parola “bambino”. B. Migliorini - A. Duro, Prontuario etimologico della lingua italiana, Paravia, Torino 1953, p. 55: “voce onomatopeica infantile”; G. Devoto, Avviamento alla etimologia italiana. Dizionario etimologico, Le Monnier, Firenze 1968, p. 41: “dimin. di bambo, forma arcaica con valore di ‘sciocco’, appartenente alla stessa famiglia onomatopeica di babbèo”. A questa seconda interpretazione fa riferimento Carlo Pancera, Semantiche d’infanzia, in «Aut-Aut», 191-192, 1982, p. 193: «Il bambino è dunque essenzialmente il piccolo sciocco che biascica malamente stupidaggini in una società che non riesce a vedere in lui altri tratti salienti». Questa interpretazione decisamente negativa però non tiene conto del contemporaneo apparire di forme simili in lingue diverse.
5 Francesco d’Assisi, Regula non bullata, IX.
6 Tommaso da Celano, Vita beati Francisci, I, XXX, 86.
7 Ibidem.
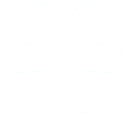 NOTEdiSTORIA
NOTEdiSTORIA