Nel corso del XIII secolo, i frati Predicatori, i cosiddetti Domenicani, si diedero da fare per costruire una cultura cristiana che potesse abbracciare tutti gli aspetti della vita, personale e associata. Nacquero così delle vere e proprie cattedrali del sapere, che spesso venivano chiamate Summae, cioè riassunti, non perché erano brevi, ma perché condensavano in un solo testo tutta la sapienza sin lì conosciuta. La più celebre di queste Summae è la Summa teologica di Tommaso d’Aquino, che, come dice il nome, cercava di condensare tutta la sapienza teologica.
Un confratello di Tommaso, Vincenzo di Beauvais, scrisse lo Speculum historiale, che è una Summa di tutta la storia. Un terzo domenicano, Tommaso di Cantimpré scrisse il De rerum naturis che è una Summa delle scienze naturali. Un quarto frate Predicatore, Jacopo da Varagine [o da Varazze se si preferisce usare la grafia moderna], scrisse quella che è conosciuta come Legenda aurea, che è una vera e propria Summa delle vite dei santi.
Jacopo, che fu esponente di rilievo dell’Ordine dei Frati Predicatori e poi arcivescovo di Genova, città in cui era nato, lavorò alla sua Legenda dal 1260 all’anno della sua morte, 1297, continuando, modificando e arricchendo il suo testo. Il suo scopo non è solo quello di raccogliere le Vite dei santi fino ad allora conosciute, ma quello di fornire una teologia pratica, che aiuti i semplici fedeli a comprendere, giorno per giorno, come Dio si sia inserito nella storia degli uomini. Jacques Le Goff nel 2011 riassumeva così lo scopo del libro di Jacopo: “Riprendendo un’espressione di Max Weber, Marcel Gauchet ha intitolato un suo importante libro Il disincanto del mondo. L’impresa di Iacopo da Varazze è l’esatto contrario: sacralizzare il mondo e l’umanità per mezzo del tempo – senza trascurare l’opposizione del Maligno”1.
In questo “mondo incantato” della Legenda aurea ci sono anche i bambini. A cominciare dal primo dei bambini in ordine di importanza teologica: il bambino Gesù. Jacopo conosce certamente i Vangeli dell’Infanzia, che cita a proposito dell’infanzia di Maria, ma tralascia volutamente i racconti relativi all’infanzia di Gesù. In questo senso egli è figlio del suo secolo: per lui Gesù è un vero bambino. Eppure per spiegare come un bambino possa essere anche il Figlio di Dio, Jacopo fa ricorso ad antiche leggende, che ritrova soprattutto a Roma.
Ci narra infine papa Innocenzo III che il senato voleva adorare come un dio Ottaviano per aver riunito e pacificato tutto il mondo; ma il prudente imperatore non volle usurpare il nome di immortale poiché ben sapeva di essere come uomo, mortale. Insistevano i senatori nel loro proposito onde Ottaviano interrogò la Sibilla per sapere se mai sarebbe nato nel mondo qualcuno più grande di lui. Era il giorno della Natività di Cristo e la Sibilla si trovava in una stanza sola con l’imperatore: ed ecco apparire un cerchio d’oro attorno al sole e in questo cerchio una vergine bellissima con un fanciullo in grembo. La Sibilla mostrò questo portento all’imperatore: mentre costui teneva fissi gli occhi nella visione sentì una voce che diceva: “Questa è l’ara del cielo!”. Esclamò allora la Sibilla: “Questo fanciullo è più grande di te; adoralo”. La stanza dove avvenne tale fatto è stata poi consacrata alla Madonna e ora si chiama S. Maria ara coeli. L’imperatore dopo aver saputo che quel fanciullo era più grande di lui non volle essere onorato come un Dio2.
A Roma la leggenda di fondazione della chiesa dell’Ara Coeli era molto nota. I Romani amavano ricordare che anche Virgilio, insigne poeta latino, aveva vaticinato la nascita di Gesù3. È il celebre passo della IV Bucolica: “La Vergine ormai torna, i regni di Saturno tornano / già una nuova stirpe scende dall’alto dei cieli. / Tu, pura Lucina, sii propizia al bambino, per cui / per la prima volta finirà l’età del ferro [delle guerre] / e si alzerà l’età dell’oro”4. Tutta la leggenda però serviva a dire che il bambino Gesù era più importante persino del primo Imperatore romano.
Questo tono leggendario non riguarda soltanto il bambino Gesù, ma tutti i bambini di cui parla Jacopo. A cominciare dai figli dei re. Degno di una favola è il racconto dell’infanzia di re Enrico III, futuro imperatore.
Al tempo di questo Corrado, nell’anno 1025, un certo conte Leopoldo, secondo quanto si legge nelle cronache, temendo l’ira del re, si era rifugiato con la moglie in una foresta e vi si teneva nascosto abitando in una capanna. Una volta l’imperatore si recò a caccia in questa foresta e, sorpreso dalla notte, chiese di essere accolto nella suddetta capanna. La moglie di Leopoldo che era incinta e prossima al parto fece del suo meglio per ospitarlo degnamente; nella stessa notte poi partorì e l’imperatore sentì i vagiti del bambino: ed ecco che una voce gli disse: “Questo fanciullo sarà il tuo genero!”. La mattina dopo Corrado chiamò due sicari e gli disse: “Andate e strappate il neonato dalle braccia della madre: uccidetelo e portatemi il cuore diviso per metà”. Subito quelli si impadronirono del bambino, ma, presi da pietà lo deposero su di un albero perché non venisse divorato dalle belve e portarono all’imperatore il cuore di una lepre.
Nello stesso giorno un principe passando di là sentì il bambino che piangeva: se lo fece portare dinanzi e poiché non aveva figli lo affidò alla moglie perché lo allevasse fingendo che fosse suo. Questo fanciullo, chiamato Enrico, rivelò, crescendo oltre a una grande bellezza, saggezza e piacevolezza di carattere. L’imperatore vedendolo tanto bello e saggio volle che si stabilisse presso di lui a corte ma poi accorgendosi che il giovinetto era amato e ricercato da tutti gli venne il dubbio che fosse colui che aveva comandato di uccidere e che fosse destinato a regnare dopo di lui. Per toglierlo di mezzo scrisse la seguente lettera alla moglie e la dette a Enrico perché gliela consegnasse: “Se ti è cara la vita, uccidi il giovine che ti porterà questa mia missiva”.
Enrico si mise in viaggio ma cammin facendo, vinto dalla stanchezza, si addormentò in una chiesa. Mentre dormiva un sacerdote spinto dalla curiosità gli aprì la borsa e lesse la lettera munita del reale sigillo. Ebbe orrore del delitto che si stava per compiere e sostituì alle parole “lo ucciderai” le seguenti: “gli darai in moglie la figlia nostra”. Così avvenne che la regina riconoscendo la calligrafia del re e il suo sigillo, convocò i principi e celebrò le nozze della figlia con Enrico nella chiesa di Aquisgrana.
Quando l’imperatore seppe che la figlia sua era ormai sposa di Enrico e quanto avevano fatto il sacerdote, il principe e i due sicari, capì che non è possibile resistere al volere di Dio, accettò il giovine come genero e stabilì che avrebbe regnato dopo di lui. Nel luogo dove Enrico era nato fu innalzato un monastero che esiste ancora oggi e che si chiama Ursania.
Difficile dire cosa ci sia di storico in un racconto come questo. Certamente nel 1026 (non 1025, ma i calendari nel medioevo erano diversi secondo le località) era imperatore Corrado II detto il Salico, il primo della dinastia di Franconia. È anche vero che a succedergli fu Enrico III. Ma quest’ultimo era il figlio e non il genero di Corrado e quindi non si capisce bene a cosa si riferisca il racconto della Legenda aurea. Quel che però importante notare è che il tono fiabesco di tutto il racconto ha un preciso intento, che è quello di spiegare che Dio protegge il bambino prescelto per il regno, anche contro la violenza gratuita di un re senza scrupoli.
Non è certo l’unico esempio di bambino che nasce e cresce in un mondo incantato. Un’altra, straordinaria storia narra la vicenda del figlio di un re dell’India, di nome Avennir, che era allora pagano e perseguitava i cristiani. Jacopo da Varagine dice che la storia era stata scritta con gran cura da Giovanni Damasceno.
Il re Avennir non aveva figli: ebbe alfine un figlio di una bellezza meravigliosa, che fu chiamato Josafat. Il re in questa occasione fece radunare una moltitudine di genti perché sacrificassero in onore della regale nascita; riunì poi sessanta astrologhi e li interrogò sui destini futuri del fanciullo. Tutti risposero che sarebbe stato molto potente e ricco; ma il più saggio degli indovini aggiunse: “Questo fanciullo che ti è nato sarà ricco e potente in un regno molto migliore del tuo. Infatti, se non mi sbaglio, sarà uno dei principi di questa religione cristiana che ora tu perseguiti”. Così parlò il saggio per divina ispirazione.
Nell’udire queste parole il re molto si spaventò e fece costruire fuori della città un magnifico palazzo e lo assegnò al figlio come dimora. Gli dette per compagni bellissimi giovani a cui era stato ordinato di non parlare mai né di morte, né di vecchiaia, né di malattie né di miseria e di qualsiasi altra cosa che potesse suscitare tristezza, perché l’animo del fanciullo sempre occupato in cose piacevoli mai avesse occasione di pensare al futuro. Se per caso un amico di Josafat si ammalava, il re lo faceva sostituire con un altro. Ma soprattutto Avennir ordinò che mai, in presenza del figlio, si, pronunciasse il nome di Cristo5.
È possibile educare un bambino come se il male non esistesse? La pretesa di Avennir di far crescere il figlio in un giardino chiuso, circondato solo di cose belle, senza mai fargli incontrare né la morte, né la malattia, né la miseria è meno improbabile di quanto appaia a prima vista. Il bambino Josafat somiglia molto ai figli del mondo occidentale in questo inizio del terzo millennio, che vengono tenuti all’oscuro (o al riparo, secondo i punti di vista) da ogni contatto con la sofferenza6.
È straordinario ritrovare questa storia in una collezione di vite di santi del XIII secolo. Naturalmente la storia si sviluppa in senso contrario alle aspettative del padre. Divenuto adulto, Josafat poté uscire dal giardino e incontrare per la prima volta un lebbroso, un cieco e un vecchio. Poi ricevette la visita di un monaco cristiano, Barlaam, il quale gli rivelò il segreto della vita, così che il principe divenne cristiano. La fine, degna di una fiaba, è il rovesciamento dei ruoli di partenza: non sarà il bambino a diventare come il padre, ma il padre a imitare il figlio.
Il re, disperato, dette al figlio metà del suo regno e Josafat, per quanto ardentemente desiderasse di ritirarsi nel deserto, giudicò più opportuno nell’interesse della fede, di accettare per qualche tempo il regno. Eresse nelle sue città templi e croci e convertì a Cristo tutti i cittadini. Anche Avennir più tardi finì per lasciarsi convincere dalla predicazione del figlio, credette in Gesù Cristo, ricevette il battesimo, lasciò l’intero regno a Josafat e finì santamente la propria vita7.
Si tratta di una storia stupefacente, ma ancor più stupefacente è il fatto che si tratta né più né meno che la storia di Buddha. Il racconto delle vicende del nobile Gautama, vissuto nel VI secolo a.C., riportato tra l’altro in un poema epico redatto in sanscrito nel II secolo d.C., coincide in molti particolari con quello di san Josafat. Sembra che tale racconto sia arrivato fino in Medio Oriente, dove sarebbe stato cristianizzato e tradotto in greco (di qui l’attribuzione di Jacopo da Varagine a Giovanni Damasceno). Successive traduzioni in latino avevano definitivamente trasformato il fondatore del buddismo in un santo cristiano.
Ai fini di ricostruire una storia dei bambini tutto ciò poco importa. Quel che conta è il significato della storia: non si può nascondere ai bambini la miseria, la sofferenza, la morte, perché vorrebbe dire pretendere di farli vivere in un mondo finto, in cui si vive una vita irreale.
In ogni caso il mondo incantato di Jacopo da Varagine non riguarda soltanto i figli dei re. Lo si comprende bene nella storia, famosissima, di san Cristoforo, che la Legenda aurea descrive come un “cananeo dall’altissima statura di dodici cubiti e di terribile aspetto”.
A lungo Cristoforo cercò qualcuno che potesse indicargli dove fosse Cristo; alfine si imbatté in un eremita che gli predicò la fede di Cristo e diligentemente lo istruì nelle verità della fede. Disse poi l’eremita a Cristoforo: “Il re a cui desideri servire deve essere onorato con frequenti digiuni”. E Cristoforo: “Mi chieda qualsiasi altro servizio perché in questo non posso servirlo”. Di nuovo l’eremita: “Dovrai anche pregare a lungo”. E Cristoforo: “Neppure in questo posso servirlo”. E l’eremita: “Conosci quel fiume laggiù in cui molti periscono miseramente quando cercano di attraversarlo?”. E Cristoforo: “Sì”. E l’eremita: “Poiché sei tanto alto e tanto forte va’ vicino a quel fiume e aiuta i passeggeri a traversarlo: ciò sarebbe molto grato a Cristo re, che tu desideri servire e potrebbe darsi che là si degnasse di manifestartisi”. E Cristoforo: “Questo è un servizio che io posso rendergli”. Si recò poi sulle rive del predetto fiume e vi si fabbricò una capanna; servendosi di un tronco di albero come di un bastone per meglio camminare nell’acqua, trasportava da una riva all’altra tutti coloro che ne avevano bisogno8.
Il significato di questa introduzione è chiaro: Cristoforo non se la sente di vivere una vita di preghiera e di digiuno, in altri termini una vita monastica. La domanda sottintesa (che interessava tutti gli ascoltatori laici) era: esiste un altro modo di incontrare Gesù, fuori dalla vita monastica?
Dopo molti giorni; mentre si riposava nella capanna, udì una voce infantile che gridava: “Cristoforo vieni fuori e portami al di là del fiume”. Cristoforo uscì fuori ma non trovò nessuno; ma non appena fu ritornato nella capanna di nuovo udì la medesima voce; di nuovo corse fuori e non trovò nessuno. Chiamato per la terza volta, corse fuori dalla capanna e trovò un fanciullo sulla riva del fiume che lo pregò di trasportarlo dall’altra parte. Cristoforo si prese il bambino sulle spalle ed entrò nel fiume appoggiandosi al bastone: ma ecco che l’acqua cominciò a gonfiare e il fanciullo a pesare come piombo; quanto più Cristoforo si inoltrava nel fiume, tanto più la corrente diventava minacciosa e il fanciullo pesava sulle sue spalle cosicché Cristoforo cominciò a temere di essere in estremo pericolo.
Quando alfine, fu arrivato sull’altra sponda ed ebbe deposto a terra il fanciullo gli disse: “Bambino, mi hai messo in gran pericolo perché il tuo peso era tanto grande che mi pareva di portare sulle spalle il mondo intero”. Rispose il fanciullo: “Non ti meravigliare, Cristoforo, perché hai portato sulle spalle non solo il mondo intero ma anche colui che l’ha creato: io sono Cristo re al cui servizio ti sei posto. E perché tu sappia che quanto dico è vero, quando avrai di nuovo varcato il fiume pianta il bastone vicino alla tua capanna e domattina lo troverai fiorito e carico di frutti”. Così detto il bambino disparve. Cristoforo piantò in terra il bastone e la mattina dopo lo trovò fronzuto a guisa di palma e carico di datteri9.
La storia ha conosciuto una diffusione straordinaria. Il significato è evidente: per incontrare Gesù non è necessario per forza vivere una vita monastica, perché è sufficiente prendere un bambino sulle spalle. In realtà il racconto sembra proprio una parabola inventata per spiegare un versetto evangelico: “chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me”10.
In fondo però questa parabola è giustamente famosa anche perché contiene il segreto di ogni pedagogia: chi prende sulle spalle la vita di un bambino, come Cristoforo, prende sulle spalle il mondo intero.
3 È noto che anche Dante condivide questa idea. Dante Alighieri, Commedia, Purgatorio XXII, 55-93.
4 Virgilio, Le Bucoliche, Egloga IV, a cura di F. Della Corte, Mondadori, Milano 1952.
5 Jacopo da Varagine, Legenda aurea, S. Barlaam e Josafat, trad. it. p. 816.
7 Jacopo da Varagine, Legenda aurea, S. Barlaam e Josafat, trad. it. p. 831.
8 Jacopo da Varagine, Legenda aurea, S. Cristoforo, trad. it. p. 423.
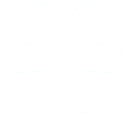 NOTEdiSTORIA
NOTEdiSTORIA