L’ultimo degli autori cui vogliamo dare la parola è Dante Alighieri. Il grande poeta ha qualcosa in comune con uno degli autori che abbiamo incontrato, Agostino d’Ippona. Come Agostino anche Dante è un padre nel senso biologico del termine, cioè un uomo che ha messo al mondo dei figli. Questo aspetto della personalità di Dante come padre non è molto studiato perché egli stesso, in ciò differenziandosi da Agostino, sembra non abbia amato parlare degli affetti familiari. In molti hanno letto un riferimento autobiografico nelle parole che il poeta mette in bocca ad Ulisse:
né dolcezza di figlio, né la pieta
del vecchio padre, né ‘l debito amore
lo qual dovea Penelope far lieta,
vincer potero dentro a me l’ardore
ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto
e de li vizi umani e del valore1.
Come Ulisse, nel racconto della Commedia, era ripartito da Itaca noncurante dei suoi, così anche Dante, costretto all’esilio, non aveva chiesto la grazia alla sua città, ben sapendo che la sua decisione avrebbe avuto un peso sulla vita dei suoi familiari e in particolare dei figli. A suggerire il paragone è stato niente meno che Francesco Petrarca, il quale, in una lettera a Boccaccio, sottolineava, con un certo tono di rimprovero, come il poeta “non si lasciò strappare nemmeno una volta dalla strada intrapresa né per amore del coniuge, né per pietà verso i figli”2.
Di certo il poeta sapeva che la legge fiorentina imponeva l’esilio anche ai figli maschi degli esuli, che avessero compiuto i 14 anni. Di fatto non richiese la grazia e la legge venne applicata al figlio Pietro nel 1315, quando venne rinnovata la condanna di esilio del padre3. La richiesta di perdono avrebbe significato in qualche modo il riconoscimento di una colpa mai commessa e questo Dante non lo volle mai fare, anche a costo di creare difficoltà al figlio che doveva avere allora tra 14 e 15 anni.
Dunque Dante sarebbe il tipico rappresentante di un mondo virile insensibile ai temi dell’infanzia e della puerizia? Certamente condivideva molte delle idee correnti al suo tempo. Ad esempio nel Convivio, per spiegare la scelta di abbassamento di Cristo che ha accettato pienamente la condizione umana, Dante dice: “non è credibile che Cristo non volesse dimorare in questa nostra vita al sommo, poi che stato c’era nel basso stato de la puerizia”4. Non vi è dubbio quindi che la puerizia sia un “basso stato”, cioè la condizione più misera della vita umana. Nello stesso Convivio si fa riferimento in senso dispregiativo anche a una puerizia non d’età, ma d’animo: “Dico adunque che per tre cagioni la presenza fa la persona di meno valore ch’ella non è: l’una de le quali è puerizia, non dico d’etate ma d’animo”5e poco dopo aggiunge che “La maggiore parte de li uomini vivono secondo senso e non secondo ragione, a guisa di pargoli”6. È chiaro qui il giudizio negativo sull’infanzia e sulla maggioranza degli uomini che vivono in modo infantile “a guisa di pargoli”. Qui Dante, credendo di esprimere un pensiero “secondo ragione” in realtà si fa portavoce di un preconcetto diffuso da secoli: quello dell’irragionevolezza dei bambini e di coloro che somigliano loro. I commentatori citano a questo proposito Tommaso d’Aquino7, ma sarebbe possibile trovare centinaia di possibili auctoritates a questo proposito.
A un’analisi più approfondita però i sentimenti di Dante Alighieri appaiono più complessi di quanto potrebbe sembrare. Per coglierli bisogna analizzare il modo in cui egli si poneva di fronte alla sua stessa autobiografia. In un certo senso infatti Dante scrive sempre di sé: non solo perché la Vita Nova è una prima autobiografia, ma anche e soprattutto perché ha scelto di fare di sé stesso il protagonista della Commedia. Eppure, nel Convivio, Dante sente il bisogno di giustificarsi perché “non si concede per li retorici alcuno di sé medesimo sanza necessaria cagione parlare”8. Per lui ci sono solo due ragioni che giustificano la scelta di parlare di sé.
Veramente… dico… per necessarie cagioni lo parlare di sé è conceduto: e in tra l’altre necessarie cagioni due sono più manifeste. L’una è quando sanza ragionare di sé grande infamia o pericolo non si può cessare; e allora si concede, per la ragione che de li due sentieri prendere lo men reo è quasi prendere un buono. E questa necessitate mosse Boezio di sé medesimo a parlare, acciò che sotto pretesto di consolazione escusasse la perpetuale infamia del suo essilio, mostrando quello essere ingiusto, poi che altro escusatore non si levava. L’altra è quando, per ragionare di sé, grandissima utilitade ne segue altrui per via di dottrina; e questa ragione mosse Agustino ne le sue Confessioni a parlare di sé, ché per lo processo de la sua vita, lo quale fu di [non] buono in buono, e di buono in migliore, e di migliore in ottimo, ne diede essemplo e dottrina, la quale per sì vero testimonio ricevere non si potea9.
Ci si può accingere a scrivere di sé quindi solo per due motivi: o per difendersi da false accuse, come fece Boezio, o per proporsi ad esempio per altri, come fece Agostino. Tutti e due questi motivi hanno spinto Dante a scrivere di sé nella Commedia che, quindi, non è una autobiografia nel senso che noi oggi diamo alla parola, perché il Dante della Commedia è un personaggio poetico, che è stato creato e descritto per essere d’esempio a ogni uomo. Questo spiega la ragione per cui, come ha scritto Umberto Bosco, “quanto alla sua vita privata, Dante parla, sì, degli amici, dei maestri, ma non spende una parola diretta sulla sua famiglia: padre, madre, moglie, figli; al punto che persino il dolore dell’esilio è presentato, almeno apparentemente, come dolore soltanto suo, e non anche dei suoi cari, che pure indirettamente e anche direttamente vi parteciparono”10. Nonostante queste notazioni, la vita di Dante traspare nella sua poesia, grazie allo sguardo poetico con cui descrive la vita quotidiana. Quando parla dei bambini egli trova gli accenti della più grande tenerezza. Come quando descrive due giovani genitori chini sulla culla, che parlano al bambino con la lingua propria dei piccoli:
L’una vegghiava a studio de la culla,
e, consolando, usava l’idioma
che prima i padri e le madri trastulla11.
O come quando descrive il rapporto tra sé e Virgilio come quello tra un bambino e la madre:
col respitto
col quale il fantolin corre a la mamma
quando ha paura o quando elli è afflitto;
a la mia guida
mi volsi, come parvol che ricorre
sempre colà dove più si confida;
e quella, come madre che soccorre
subito al figlio pallido e anelo
con la sua voce, che ’l suol ben disporre…12
Il tema del rapporto con i figli è centrale in diversi momenti della Commedia. In particolare si possono citare due personaggi: Ugolino e Farinata. È stato notato come in questi episodi ci sia il riflesso del sentimento personale di Dante verso i suoi figli. La storia di Ugolino della Gherardesca è ben nota. Si svolge a Pisa negli anni immediatamente successivi alla battaglia navale della Meloria, avvenuta il 6 agosto 1284. La flotta genovese, al comando di Oberto Doria, sconfisse quella pisana ponendo di fatto fine al predominio della città toscana sul Mediterraneo occidentale. Ugolino, che era a capo di 12 galere, sfuggì alla cattura rifugiandosi nel porto di Pisa. La città si trovava sotto un duplice attacco: sul mare da parte di Genova, sulla terraferma da parte di Firenze. Ugolino venne chiamato a reggere le sorti di Pisa durante quattro anni, che furono tra i più difficili per la città. Nel luglio 1288 però le cose precipitarono: l’arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini fomentò una rivolta popolare che alla fine catturò Ugolino con i figli Gaddo e Uguccione e i nipoti Anselmo e Nino, detto Brigata, che moriranno con lui. La prigionia si protrasse oltre nove mesi. Nel marzo 1289 tutti i protagonisti erano già morti13. Dante, come è noto, immagina di incontrare Ugolino nel punto più oscuro dell’Inferno, in quel lago di ghiaccio che circonda Lucifero, in mezzo ai peccatori più abietti: i traditori. Lo trova in una buca insieme al suo nemico, l’arcivescovo Ruggieri (che Dante ritiene responsabile della cattura dello stesso Ugolino). Il racconto però non si sofferma a delineare quale sia il tradimento di Ugolino, ma a descrivere la sua tragica detenzione. Qui il ricordo di un episodio storico si trasfigura. Non è un caso che il poeta immagini che i condannati nella torre fossero tutti figli (e non anche nipoti) di Ugolino e tutti adolescenti (quando invece l’unico ad avere forse 15 anni era Anselmo, detto Anselmuccio e tutti gli altri erano già adulti).
Dante descrive gli ultimi otto giorni di vita di Ugolino con i suoi figli. Tutti conoscono l’ultimo, terribile, verso: “Poscia, più che ‘l dolor, poté ‘l digiuno”. L’orrore che questo verso suscita non cancella però del tutto il sentimento di partecipazione emotiva creata nei versi precedenti. Il punto di vista è quello di un padre che assiste impotente (lui che era stato signore della città) alla morte dei figli. È quello che dice il figlio Gaddo, arrivati al quarto giorno: “Padre mio, ché non mi aiuti?”. E subito dopo, uno dopo l’altro, i quattro figli moriranno. Quello di Ugolino, nella profondità dell’Inferno, è il più grave dei peccati, ma anche il più doloroso dei tormenti: il rimorso di un padre che non ha potuto o saputo essere padre.
Accanto a Ugolino, si può leggere l’episodio di Farinata. Dante lo colloca all’ingresso dell’Inferno, Come è noto Manente degli Uberti, detto Farinata, era stato a capo dei ghibellini fiorentini sin dal 1239. Grazie al sostegno di Federico II di Svevia nel 1248 era riuscito a sconfiggere e mandare in esilio la parte avversa. I guelfi però ebbero di nuovo il sopravvento dopo la morte dell’imperatore, nel 1250. Anche Farinata fu costretto all’esilio nel 1258. Ma nella battaglia di Montaperti nel 1260 i ghibellini di tutta la Toscana sconfissero i guelfi fiorentini, il fiume Arbia si sarebbe colorato di sangue in quell’occasione. Dopo la battaglia, i capi ghibellini riuniti ad Empoli avrebbero voluto la completa distruzione di Firenze, ma Farinata si era opposto. Il suo successo ebbe in ogni caso breve durata giacché quattro anni dopo, alla sua morte, i ghibellini vennero di nuovo espulsi, questa volta per sempre, da Firenze.
Più esplicito a livello antropologico è il dialogo tra Dante e Farinata, centrato sulle vicende politiche che avevano sconvolto la vita della loro comune città. Dante non nasconde una certa ammirazione personale verso il personaggio, seppure lo colloca all’inferno. È comunque il dialogo tra due nemici politici. È Farinata a ricordarlo, dopo aver chiesto chi fossero gli antenati di Dante.
poi disse: «Fieramente furo avversi
a me e ai miei primi e a mia parte,
sì che per due fiate li dispersi»14
Farinata ricorda con un certo orgoglio di aver sconfitto e quindi esiliato da Firenze la parte di Dante per ben due volte. La risposta di Dante è altrettanto fiera:
«S’ei fur cacciati, ei tornar d’ogne parte»
Rispuos’ io lui, «l’una e l’altra fiata;
ma i vostri non appreser ben quell’arte»15.
Qui Dante ricorda certamente che l’espulsione dei ghibellini nel 1264, a differenza di quel che era accaduto ai guelfi, era stata definitiva. Ma, in realtà, i “vostri” di cui parla non sono tanto i ghibellini in generale, quanto i figli di Farinata, i membri della famiglia Uberti. A differenza di molte altre famiglie aristocratiche, che trovarono il modo di rientrare in città, gli Uberti subirono in effetti un definitivo interdetto16.
Il racconto continua con un intermezzo: l’ombra di Cavalcante de’ Cavalcanti interrompe il dialogo tra Dante e Farinata, per chiedere notizie del figlio. Ma Farinata non lascia senza risposta la provocazione di Dante e infatti, dopo poco, riprende dicendo:
«S’elli han quell’arte», disse, «male appresa,
ciò mi tormenta più che questo letto»
Qui c’è il cuore della riflessione dantesca sulla paternità. Farinata soffre più per la consapevolezza delle sofferenze dei suoi figli, che per la punizione che gli è comminata all’Inferno. Il tema è quello della punizione dei figli innocenti, coinvolti loro malgrado nelle scelte del padre. Vi è, a questo riguardo, un bel commento di Umberto Bosco:
Il dovere verso la patria, quello di essere coerente con sé stesso, possono assorbire e annullare il dovere di padre? È, a me sembra, lo stesso problema di Dante. Nel nostro poeta, il dovere morale vinse, sì, sugli affetti: ma ciò non potette umanamente avvenire senza crisi, senza che l’angoscia stringesse e aumentasse ogni volta che li eventi gli riproponevano la difficile scelta17.
D’altra parte che Dante, nel pensare alle vicende di Farinata, rievocasse anche le proprie vicende, è chiaro dalle parole con cui risponde all’Uberti: “Deh, se riposi mai vostra semenza”, con l’augurio che possa trovar pace un giorno la sua discendenza (semenza). Un augurio non formale, ma sincero, da parte del poeta che in fondo evoca lo stesso per la propria discendenza.
Si comprende così come la sensibilità dantesca verso l’infanzia sia più articolata di quel che appariva a prima vista. Se è vero che tutta la vita Dante ha vissuto “l’ardore… a divenir del mondo esperto e de li vizi umani e del valore”, per il quale ha messo in secondo piano persino la vita della sua famiglia, è pur vero che la felicità dei suoi figli doveva restare uno dei crucci che lo hanno accompagnato sempre nella sua vita di esule. La paura di esser stato un cattivo padre nasce pur sempre da un senso di responsabilità verso i propri figli. Sono forse questi sentimenti personali che, trasfigurati dal poeta, riappaiono in episodi come quello di Ugolino e di Farinata.
La riflessione di Dante sui bambini però non finisce qui, perché nel Paradiso ci sono molti riferimenti all’infanzia. Anzitutto la presenza dei fanciulli nella Candida Rosa che hanno voci puerili18. Per capire questa scelta occorre ricordare che il Paradiso di Dante è tutto marcato da un carattere domestico, familiare, che trova il suo compimento nell’affetto materno, e in particolare in Maria.
Nella descrizione che S. Bernardo fa della rosa celeste, nel XXXII canto, Maria siede nel seggio più alto, sotto di lei Eva, Rachele, Sara, Rebecca, Giuditta Ruth, e le altre donne. Di fronte a Maria, dall’altra parte della rosa, c’è Giovanni Battista e, sotto, S. Francesco, S. Benedetto, S. Agostino e gli altri santi. Infine la metà inferiore della rosa è occupata dai bambini.
E sappi che dal grado in giù che fiede
a mezzo il tratto le due discrezioni,
per nullo proprio merito si siede,
ma per l’altrui, con certe condizioni:
che tutti questi sono spiriti asciolti
prima ch’avesser vere elezioni.
Ben te ne puoi accorger per li volti
e anche per le voci puerili,
se tu li guardi bene e se li ascolti19,
S. Bernardo spiega che a partire dal gradino che divide a metà la rosa, verso il basso, si è seduti non per proprio merito, ma solo per merito altrui, a certe condizioni, perché si tratta di spiriti sciolti (dal peccato originale) prima di essere in grado di scegliere tra il bene e il male. Il fatto che siano spiriti sciolti, cioè liberi dal peccato, lo si capisce guardandone bene i volti e ascoltandone le voci che sono volti e voci di bambini.
Questa presenza dei bambini in paradiso non era scontata. Tommaso d’Aquino aveva ipotizzato che i beati, quando risorgeranno e si rivestiranno del loro corpo, prenderanno la figura che avrebbero avuto nella piena maturità, quella che i latini chiamavano iuventus, cioè nell’aspetto di maggiore forza e benessere20. Agostino, come si è visto nel capitolo a lui dedicato, aveva ipotizzato che nel Paradiso terrestre, se Eva avesse partorito bambini prima del peccato, Dio avrebbe provveduto a farli diventare immediatamente adulti. In altri termini, secondo il vescovo di Ippona non c’era posto in Paradiso per l’infirmitas puerorum21. Dante invece prevede la presenza in gran numero dei bambini nel suo paradiso. Bambini le cui voci e i cui volti fanno immediatamente percepire l’amore gratuito di Dio, “se tu li guardi bene e se li ascolti”.
C’è un ultimo accenno che non può essere taciuto, perché si trova proprio alla fine della Commedia. Nel XXXIII Canto Dante dice
Omai sarà più corta mia favella,
pur a quel ch’io ricordo, che d’un fante
che bagni ancor la lingua alla mammella22.
Siamo a sole 12 terzine dalla fine del poema e Dante vuole spiegare che ormai la sua lingua non è più in grado di esprimere la luce divina che sta contemplando. Non più di un lattante che, infante, non sa ancora parlare. È solo un paragone, ma in questa immagine di Dante come lattante si nasconde un’ultima, intensa, percezione di felicità. Non è forse necessario ricordare che il poeta non aveva mai conosciuto sua madre, che alcuni ipotizzano sia morta dandolo alla luce23.
Il contesto qui è solenne. Come è stato scritto: “più il Poeta va in alto nel Paradiso e più dice che sta tornando bambino”24. L’uomo che aveva sentito fortissimo il desiderio di “divenir del mondo esperto e de li vizi umani e del valore” alla fine identifica la beatitudine del Paradiso nella condizione di un bambino in braccio a sua madre.
1 Inferno XXVI, 94-99.
2 Petrarca, Familiari, XXI, 15,7-8: «non amor coniugis, non natorum pietas ab arrepto semel calle distraheret». Petrarca contrappone il comportamento di Dante a quello di suo padre, che invece, aveva scelto la famiglia.
3 Arnaldo D’Addario, Alighieri Pietro, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 2, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1960.
4 Convivio, IV, XXIII, 10.
5 Convivio, I, IV, 2.
6 Convivio, I, IV, 3.
7 Thomas de Aquino, Sententia libri Ethicorum, lib. 1 l. 3 n. 9: «Ad actus autem virtuosos non perveniunt, qui passiones sectantur. Et sic nihil differt quantum ad hoc quod arceantur ab auditu huius scientiae iuvenis aetate vel iuvenis moribus, scilicet passionum sectator, quia, sicut iuvenis aetate deficit a fine huius scientiae, qui est cognitio, ita ille qui est iuvenis moribus deficit a fine, qui est actio: non enim est defectus eius propter tempus, sed propter hoc quod vivit secundum passiones»
8 Convivio, I, II, 3.
9 Convivio, I, II, 12-14.
10 Umberto Bosco, Gli affetti familiari di Dante nella «Commedia», in Altre pagine dantesche, Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 1987, p. 12.
11 Paradiso XV, 121-123.
12 Purgatorio XXX, 43-54; Paradiso XXII, 1-6
13 Cfr. Simonetta Saffiotti Bernardi, Ugolino della Gherardesca, conte di Donoratico, in Enciclopedia Dantesca, vol. IV, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1970.
14 Inferno X, 46-48.
15 Inferno X, 49-51.
16 Cfr. Federico Canaccini, Gli Uberti di Firenze: dall’apice al tracollo, in «La Fusta, Journal of Italian Literature and Culture, Devotion», vol. XXII, Rutgers, Fall 2014, pp. 1-12.
17 U. Bosco, Gli affetti familiari di Dante, p. 25.
18 Paradiso XXXII, 47.
19 Paradiso XXXII, 40-48.
20 Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, Supplementum, q. LXXXI, a. 1-2.
21 Cfr. Supra, cap. 3.
22 Paradiso XXXIII, 106-108.
23 Cfr. Alessandro Barbero, Dante, Roma-Bari, Edizioni Laterza, 2020, p. 55.
24 L’espressione è tratta dal delizioso libretto di Gianni Vacchelli, Dante e i bambini, Lemma Press, Bergamo 2019.
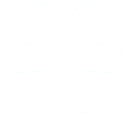 NOTEdiSTORIA
NOTEdiSTORIA