Ambrogio nacque quando suo padre era a capo della prefettura delle Gallie. Un giorno mentre il bambino, posta la culla nel cortile del pretorio, dormiva a bocca aperta, improvvisamente sopraggiunse uno sciame d’api e riempì tutta la sua faccia, a tal punto che le api entravano ed uscivano dalla bocca. Il padre, che stava passeggiando lì vicino insieme con la madre e la figlia, impedì alla schiava, addetta alla cura del bambino, di cacciar via le api timorosa che quelle gli facessero del male, e pur nel suo affetto di padre, volle aspettare e vedere come si sarebbe concluso quell’evento miracoloso. E dopo un po’ quelle volando si sollevarono a tanta altezza da sottrarsi allo sguardo dell’uomo. Atterrito dall’evento, il padre disse: “Se questo bambino vivrà diventerà qualcosa di grande”. Infatti già allora operava il Signore nell’infanzia del suo servo, perché si realizzasse ciò che è scritto: Favi di miele sono le buone parole1. Quello sciame di api ci avrebbe generato i favi dei suoi scritti, che avrebbero annunziato dono celesti e avrebbero innalzato le menti degli uomini dalle realtà terrene al cielo2.
Questo racconto dell’infanzia di Ambrogio di Milano merita una riflessione. Il racconto delle api che entravano e uscivano dalla bocca del bambino, come sapevano bene tutte le persone istruite alla fine del V secolo, è un topos, cioè un luogo comune tipico delle vite degli uomini illustri. Come racconta ad esempio Valerio Massimo, scrittore del I secolo, nel suo Facta et dicta memorabilia.
Mida, che fu re della Frigia, da bambino, dormendo nella culla, molte formiche gli portarono dei chicchi di grano nella bocca. I genitori, osservando appassionatamente ed esaminando dove volgesse quel prodigio meravigliosissimo, interrogarono gli indovini della città con molta preoccupazione. Allora gli indovini risposero: “il fanciullo sarà di gran lunga il più ricco tra tutti i mortali”. Questa predizione non apparì inutile. Infatti Mida precedette tutti i re del suo tempo per l’abbondantissima quantità di ricchezze.
Anche su Platone narrano un incredibile prodigio, che io giudico molto più mirabile. Dormendo nella culla il fanciullo, delle api inserirono nella sua bocca del miele dolcissimo. Gli interpreti dei prodigi predissero il dolcissimo eloquio di Platone da questo prodigio. Infatti dissero che quelle api non erano nutrite dal fiore del timo del colle Imetto ma dalla dottrina delle muse sui monti eliconi. Così io antepongo le api di Platone alle formiche di Mida, poiché il vaticinio delle api fu più ampio: le formiche infatti portarono una effimera e fragile felicità, le api al contrario una felicità eterna e solida3.
Perché il diacono Paolino, della diocesi di Milano, ha attribuito ad Ambrogio bambino lo stesso episodio che tutti conoscevano riferito a Platone? È evidente che lo ha fatto proprio per suggerire un confronto tra i due grandi personaggi. Al momento in cui scriveva infatti l’Impero romano d’Occidente non era ancora crollato e gli elementi di continuità con il mondo classico erano certamente prevalenti presso tutte le persone colte. Per Ambrogio come per Platone è possibile indovinare il futuro a partire dai prodigi, cioè da quegli avvenimenti simbolici che, come dirà Isidoro nelle Etymologiae, predicono il futuro. Infatti «prodigio, dal fatto che porro dicit, ossia predice il futuro»4. È questa una delle caratteristiche dell’atteggiamento verso il bambino presso tutti i popoli e tutte le epoche: il bambino, soprattutto il neonato, è circondato dal mistero. Le grandi domande che pone un nuovo nato sono sempre: da dove viene? Dove andrà? La sua vita sarà una benedizione o una maledizione del cielo? Per questo i genitori cercano i prodigi, cioè i segni che permettano di conoscere in anticipo il futuro. Poco importa, in questo senso, che Platone sia greco e cultore degli dei, mentre Ambrogio è figlio di genitori cristiani. Per l’uno come per l’altro sono le api che indicano l’avvenire.
Questo legame tra l’infanzia e il divino è confermata poco dopo, nella stessa Vita scritta da Paolino, in un altro episodio che ha come protagonista un bambino.
In quel tempo era morto Aussenzio, vescovo della setta eretica degli ariani, che aveva oppresso quella chiesa dopo che era stato mandato in esilio Dionigi, confessore di beata memoria. Poiché il popolo suscitava tumulti nel richiedere il nuovo vescovo, Ambrogio che si dava cura di sedare il tumulto per impedire che il popolo provocasse una situazione pericolosa per la città, andò in chiesa. Mentre lì parlava al popolo, si dice che all’improvviso la voce di un bambino acclamò, in mezzo al popolo, Ambrogio vescovo. Tutto il popolo si volse verso questa voce e acclamò vescovo Ambrogio. Così coloro che prima discordavano fra loro nel più grande disordine, perché sia gli ariani sia i cattolici desideravano che fosse ordinato un vescovo della loro parte, cercando di superarsi a vicenda, improvvisamente si trovarono d’accordo su questo nome con meravigliosa e incredibile concordia5.
Tutto il racconto è costruito su un ossimoro, cioè su una figura retorica che mette insieme gli opposti, in questo caso un infans, che vuole dire non parlante, che parla. Proprio perché infans le parole che escono dalla sua bocca non sono sue, ma sono parole divine, come divino è l’effetto di produrre la concordia tra ariani e cattolici attorno all’elezione del nuovo vescovo. Dal punto di vista della considerazione del bambino, racconti come questo non modificano il giudizio di fondo: l’infans resta incapace di parlare, perché incapace di ragionare, ma allo stesso tempo, l’idea che Dio possa parlare nella bocca di un bambino induce ad un’attenzione particolare per le voci dei bambini. Il modello, accanto, come si è visto, ai testi classici, sarà quello biblico di Giovanni Battista, il quale, sin dal grembo materno (quindi ancor prima di nascere) riconobbe Gesù nel bambino concepito nel grembo di Maria.
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo”6.
Questa idea delle potenzialità divinatorie degli infantes era certo presente anche prima del cristianesimo e rimase forte nella coscienza popolare a lungo nei secoli. Si può pensare a un esempio rimasto famoso, successivo di qualche decennio agli avvenimenti di Milano. I fatti si svolgono a Costantinopoli al tempo del patriarca Proclo, che è stato patriarca di Costantinopoli tra il 434 e il 446, come ricorda Giovanni Damasceno:
In verità, gli scrittori di storia ecclesiastica dicono che durante l’arcivescovato di Proclo, mentre il popolo in Costantinopoli pregava per un flagello inviato da Dio, capitò che un fanciullo del popolo fu rapito in estasi, e quindi da un qualche ammaestramento angelico gli fu insegnato misteriosamente il Trisagio: «Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi»; e poi, dopo che il fanciullo era ritornato in sé e aveva riferito ciò che gli era stato insegnato, tutta la moltitudine cantò l’inno e così il flagello cessò7.
Tutti questi episodi di bambini ispirati sono idealmente collegati al passo evangelico dell’entrata di Gesù a Gerusalemme: «E gli dissero: “Non senti quello che dicono costoro?”. Gesù rispose loro: “Sì! Non avete mai letto: Dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode?”»8.
In ogni caso, quelle citate finora sono le riflessioni del diacono Paolino, biografo di Ambrogio. È interessante, invece, esaminare l’atteggiamento verso l’infanzia dello stesso vescovo di Milano, perché si trattò di un personaggio pubblico di primissima importanza, che avrà un’influenza profonda in tutto il medioevo occidentale. Ambrogio nel 374 era diventato vescovo di Milano che a quel tempo era la capitale della parte occidentale dell’Impero. Nel 380 d.C. l’imperatore Teodosio, con l’editto di Tessalonica, aveva dichiarato il cristianesimo (nella forma proclamata dal Concilio di Nicea del 325 d.C.) come religione ufficiale dell’Impero. Ambrogio era dunque uno degli ecclesiastici in posizione di maggiore prestigio in tutto l’Impero.
Le idee di Ambrogio sull’infanzia e sui bambini non potevano che essere quelle tradizionali al suo tempo. Più volte egli presenta l’infanzia come caratterizzata da instabilità e immaturità. Lo fa ad esempio quando paragona il popolo di Israele a bambini:
[Dio] sapeva che il popolo dei Giudei era di dura cervice, facile a cedere, meschino, alquanto incline all’infedeltà, tale da ascoltare e non ascoltare con l’orecchio, da vedere e non vedere con gli occhi, per così dire; per l’insipienza dell’infanzia, leggero e immemore dei precetti. Perciò Dio usò la Legge come un pedagogo: per il carattere incostante del popolo e per la debolezza del suo animo9.
Questa immagine negativa dell’infanzia è associata non solo agli ebrei, ma anche ai cristiani che muovono i primi passi.
Non è superflua, dunque, la legge, che come un pedagogo accompagna coloro che sono ancora piuttosto deboli. Intendo parlare di debolezza morale, non fisica; sono infatti bambini incapaci di parlare coloro che non sanno articolare la parola di Dio, che non riconoscono le sue opere. Infatti, se vera longevità è una vita immacolata, certamente una vita contaminata equivale alla fanciullezza. La legge dunque fu il nostro pedagogo: cioè la norma, in attesa che venisse la fede. E poiché eravamo deboli, dice, eravamo custoditi dalla legge, rinchiusi in attesa di quella fede che doveva essere rivelata. Ma dopoché giunse la fede… venne «l’adozione a figli», cessò la debolezza, finì l’infanzia, cresciamo a uomo perfetto, «ci rivestiamo di Cristo»10.
Si tratta di un commento a quanto esposto dall’apostolo Paolo, il quale in effetti aveva più volte usato l’idea di infanzia come metafora della debolezza, ad esempio invitando gli Efesini a giungere alla piena conoscenza del Figlio di Dio “affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina”11, o scrivendo ai Galati “anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo schiavi degli elementi del mondo”12. Per questo Ambrogio ribadisce:
Ma chi è uomo perfetto se non quello che, liberato dall’infanzia d’una natura puerile e dalla sdrucciolevole irresolutezza dell’adolescenza e dallo smoderato ardore della gioventù, ha raggiunto la fermezza dell’uomo perfetto, progredendo fino ad una tale maturità di condotta da essere difficilmente piegato dai discorsi di chi sostiene l’errore?13
Il vertice di questa rilettura della categoria “infanzia” lo si trova nell’esegesi ambrosiana del versetto evangelico di Lc 18,15 “Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio”. Ambrogio non nasconde le proprie difficoltà:
Eppure quella è un’età debole di forze, fragile per intelligenza, immatura nel giudizio. Perciò non viene anteposta un’età all’altra; diversamente, il crescere negli anni sarebbe un danno. Che motivo c’è per desiderare che sopraggiunga la maturità degli anni, se è destinata a togliermi il merito del Regno celeste? Dunque Dio ci ha dato di avanzar negli anni per peccare, non per crescere nella virtù? Perché allora Egli scelse come suoi apostoli chi non aveva un’età da bambini, ma era avanti negli anni? Allora perché afferma che i bambini sono adatti per il Regno dei cieli? Forse perché non conoscono la malvagità, non sanno ingannare, non osano restituir colpo con colpo, ignorano la ricerca ansiosa delle ricchezze, non desiderano l’onore, l’ambizione? Ma la virtù non consiste nell’ignorare tutte queste cose, bensì nel disprezzarle, e la padronanza di se stessi non è un pregio là dove l’onestà non è che fiacchezza. Quindi qui viene designata non l’età puerile, bensì quella rettitudine che va a gara con la semplicità dei fanciulli. In realtà, la virtù non consiste nel non potere, ma nel non voler peccare, e nel mantenere una tale perseveranza della volontà da far sì che l’intenzione imiti l’infanzia, si segua la natura. E del resto lo stesso Salvatore ha indicato che è così, dicendo: “Se non vi convertirete e diverrete come questo fanciullo, non entrerete nel Regno dei cieli”14.
Come si vede Ambrogio è provocato dal testo evangelico, che mette in discussione idee sull’infanzia che erano da tutti condivise. Per questo motivo è costretto a trovare un’interpretazione originale del brano evangelico.
Chi è dunque il fanciullo che gli apostoli di Cristo debbono imitare? Forse un ragazzino? Sarebbe questa la virtù degli apostoli? Chi è dunque questo fanciullo? Non forse Colui del quale dice Isaia: “Un fanciullo è nato per noi, ci è stato donato un figlio? Proprio questo fanciullo ti ha detto: prendi la tua croce e seguimi”. E perché riconosca che è un fanciullo: “Oltraggiato non rispondeva con oltraggi; percosso non restituiva il colpo”: ecco la virtù perfetta. Perciò tanto nella fanciullezza vi è come una veneranda anzianità di carattere, tanto nella vecchiezza vi è un’innocente fanciullezza; infatti, “vecchiaia veneranda non è la longevità, né si calcola dal numero degli anni; la canizie per gli uomini sta nella sapienza, età senile una vita intemerata”. E per tale motivo è anche stato scritto: “Lodate, fanciulli, il Signore, lodate il nome del Signore”, perché nessuno loda il Signore, se non è perfetto; di fatto, nessuno può dire Gesù Signore se non in virtù dello Spirito Santo15.
Il commento di Ambrogio è sorprendente: il bambino cui Gesù ha chiesto di somigliare se si vuole entrare nel Regno di Dio è Gesù stesso, come profetizzato da Isaia, “Un fanciullo è nato per noi, ci è stato donato un figlio”16. Gesù si comportava da bambino, infatti “oltraggiato non rispondeva con oltraggi; percosso non restituiva il colpo”17. Ambrogio vede in Gesù un uomo con un animo da bambino, ovvero un bambino per scelta e non per condizione fisica. E qui aggiunge una citazione dal libro della Sapienza18, per spiegare che la vecchiaia veneranda non consiste nella durata degli anni, ma nella sapienza. Anche i vecchi possono avere uno spirito da bambini! Ed è in questo senso che va interpretato l’invito di Gesù a convertirsi e diventare come bambini. Un’interpretazione edificante, ma che non coincide con il contesto dell’episodio evangelico, in cui si parla di bambini in carne ed ossa, che vengono allontanati dai discepoli, timorosi che disturbino il Maestro19. Ed è facendo riferimento a quei bambini concreti – e non certo a se stesso – che Gesù dice “a chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio”.
L’interpretazione di Ambrogio è per certi versi geniale, perché è pur vero che Gesù nel vangelo di Luca è presentato come il bambino vaticinato da Isaia, ed è sempre vero che i discepoli sono chiamati a imitare il Maestro. Ma Ambrogio tralascia il confronto con i bambini in carne e ossa, che pure il vangelo di Luca esplicita in maniera non equivoca. In fondo si tratta dello stesso procedimento usato da Clemente. Verrebbe quasi da pensare che i primi autori cristiani, su questo punto, abbiano condiviso l’imbarazzo di quei discepoli di Gesù che rimproveravano coloro che gli portavano i bambini perché li toccasse.
Eppure Ambrogio elabora anche una riflessione sulla fede dei bambini. Lo fa nel momento in cui si pone la domanda se un bambino, con tutti i limiti (da lui dati per scontati) derivanti dalla sua età, possa ugualmente accedere alla pienezza della fede. Per fare questo Ambrogio usa una categoria nuova, che avrà un seguito importante nel pensiero occidentale, quella dell’animo. In latino, come in italiano, infatti la parola animo può essere sia maschile che femminile, anima. Ora l’anima è un concetto filosofico che al tempo di Ambrogio era molto ben definito. Aristotele ad esempio dice che l’anima è “la forma di un corpo naturale che ha la vita in potenza”20. Invece l’animo è qualcosa di diverso, come risulta ancora oggi da alcune espressioni italiane: avere in animo (che significa avere il proposito); non perdersi d’animo (cioè non scoraggiarsi). Anche in latino animus, seppure talvolta è del tutto sinonimo di ani ma, più spesso è usato per indicare il principio del sentire, del desiderare, del pensare. Al tempo di Ambrogio tutti gli uomini istruiti condividevano l’idea che i bambini, certamente, hanno un’anima razionale, come tutti gli esseri umani, ma in un certo senso un’anima ancora imperfetta, perché loro la parte sensitiva, proprio come per le donne, è ancora prevalente, a differenza dei maschi adulti nei quali la parte prevalente dell’anima è quella contemplativa, cioè razionale.
La domanda sulla fede del bambino può allora essere posta in questo modo: possono esseri dotati di un’anima ancora imperfetta, come sono appunto i bambini, avere invece un animo grande, capace di decisive risoluzioni?
Ambrogio nota che nelle Scritture si parla di alcuni bambini che sono ritenuti grandi. Nel Vangelo di Luca, ad esempio, si dice di Giovanni Battista prima ancora della sua nascita “egli sarà grande davanti al Signore”21. Il commento di Ambrogio è:
Non è la statura del corpo che si intende qui, ma la grandezza dell’anima. Agli occhi di Dio conta la grandezza dell’anima e la grandezza della virtù. Vi è anche una piccolezza dell’anima e una fanciullezza secondo la virtù che è in essa. Noi calcoliamo l’età di una persona (sia dell’anima sia del corpo) non cronologicamente, ma in base al grado di virtù da essa raggiunto. L’uomo perfetto è colui che ha abbandonato i difetti dell’infanzia, messo da parte i cammini incerti dell’adolescenza, e raggiunto la maturità dell’anima. Mentre l’uomo debole e meschino d’animo non ha ancora fatto alcun progresso nella virtù2.
Per Ambrogio, dunque, la statura dell’uomo interiore non è la stessa dell’uomo esteriore e l’età spirituale non dipende dal tempo, ma dal grado di virtù. Egli cerca nelle Scritture altri riferimenti all’infanzia, diversi da quelli usati da Paolo. Trova ad esempio il passo della prima lettera di Giovanni, al capitolo 2: “Ho scritto a voi figlioli, perché avete conosciuto il Padre”23; poi fa riferimento al vangelo di Matteo: “se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli”24. La conclusione a cui giunge il vescovo di Milano è che Vigor animi infirmitatem excludit aetatis (“la forza d’animo supera la debolezza dell’età”)25.
1 Prov. 16,24.
2 Paolino di Milano, Vita di Ambrogio, 3 (PL 14,30).
3 Valerio Massimo, Facta et Dicta Memorabilia 1.6(ext)1.1.
4 Isidoro di Siviglia, Etymologiae, lib. XI De homine et portentis, III. De portentis.
5 Paolino di Milano, Vita di Ambrogio, 6 (PL 14,30).
6 Luca 1,39-44.
7 Giovanni Damasceno, De fide orthodoxa, III,15.
8 Matteo 21,16.
9 Ambrogio, Lettere, lib. IX, lett. 64, 3, in Opera Omnia, vol. 20, p. 117.
10 Ambrogio, Lettere, lib. V, lett. 20, 9, in Opera omnia, vol. 19, p. 208.
11 Ef 4,14.
13 Ambrogio, Lettere, lib. IV, lett. 16,12, in Opera omnia, vol. 19, p. 167.
14 Ambrogio, Esposizione del Vangelo secondo Luca VIII, 57, in Opera Omnia, vol. 11, Milano-Roma 1978, p. 329.
15 Ibidem, 58, in Opera Omnia, vol. 11, Milano-Roma 1978, p. 331.
16 Is 9,6.
17 1Pt 2,23.
19 Lc 18,15-17.
20 Aristotele, De anima 412a; Aristotele, L’Anima, Loffredo, Napoli, 1979, p. 137.
21 Lc 1.15.
22 Ambrogio, Esposizione del Vangelo secondo Luca I,31 in Opera omnia, vol. 11, Milano-Roma 1978, p. 128.
23 1Gv 2,14.
24 Mt 18,3.
25 Ambrogio, Enarrationes in XII Psalmos Davidicos 36,52.
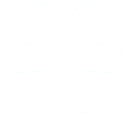 NOTEdiSTORIA
NOTEdiSTORIA