Il terzo autore di cui parleremo è l’unico di tutte la serie ad essere stato padre anche dal punto di vista biologico. Agostino di Ippona, prima di diventare un Padre della Chiesa è stato padre di Adeodato, un figlio avuto in gioventù e amato per tutta la vita. La storia è ben conosciuta. Siamo alla vigilia della fine dell’Impero romano d’Occidente, ma nella ricca provincia d’Africa non si ha sentore di decadenza, anzi la vita scorre confortevole e promettente. Le vicende biografiche di Agostino ci sono note perché lui stesso ha composto la sua autobiografia, Le confessioni, un libro che è divenuto un classico della cultura occidentale. A ben vedere non si tratta di un’autobiografia nel senso moderno del termine, ma di una rilettura teologica della sua vita. Il protagonista, in un certo senso, non è Agostino, ma Dio. L’intento del libro è quello di ricostruire l’intervento divino nella sua storia. Ma, per far questo, Agostino non può evidentemente far altro che raccontare le vicende che lo riguardano. È così che il libro ci consegna ricordi ed episodi che mai nessun altro autore aveva pensato di trasmettere ai posteri.
“Adeodato, nato dalla mia carne e frutto del mio peccato”1, era nato quando Agostino aveva diciotto anni, frutto di una relazione con una donna da lui conosciuta due anni prima a Tagaste. Di questa donna nelle Confessioni non si fa nemmeno il nome, ma si racconta che convisse con il giovane Agostino più di dieci anni. Era di condizioni sociali troppo modeste per diventare sua moglie, ma quando si separarono, ella decise di non unirsi più a nessun altro uomo, come si legge nelle Confessioni: “Essa partì per l’Africa, facendoti voto di non conoscere nessun altro uomo e lasciando con me il figlio naturale avuto da lei”2. Il figlio non era stato desiderato, almeno non da Agostino, che scriverà, ricordando quegli anni: “Ancora in quegli anni tenevo con me una donna, non posseduta in nozze, come si dicono, legittime, ma scovata nel vagolare della mia passione dissennata; una sola, comunque, e a cui prestavo per di più la fedeltà di un marito. Sperimentai tuttavia di persona in questa unione l’enorme divario esistente fra l’assetto di un patto coniugale stabilito in vista della procreazione, e l’intesa di un amore libidinoso, ove pure la prole nasce, ma contro il desiderio dei genitori, sebbene imponga di amarla dopo nata”3.
Il nome scelto, Adeodato, è in ogni caso chiaro: per Agostino, che in quel periodo della sua vita era vicino alle dottrine manichee, quel figlio era un dono di Dio.
Quando, nelle Confessioni, ripercorrerà i primi istanti della sua vita, è evidente che farà ricorso alla sua esperienza di padre, attribuendo a se stesso, quel che deve aver visto nel figlio:
Mi accolsero dunque i conforti del latte umano, ma non erano già mia madre o le mie nutrici a riempirsene le poppe, bensì eri tu [Dio], che per mezzo loro alimentavi la mia infanzia, secondo il criterio con cui hai distribuito le tue ricchezze sino al fondo dell’universo. Tu, anche, mi davi di non desiderare più di quanto davi, e a chi mi nutriva di darmi quanto le davi. Per un sentimento ben ordinato le donne desideravano darmi ciò di cui ridondavano per grazia tua, e il bene che io traevo da loro era un bene per loro, che procedeva non da loro, ma per mezzo loro4.
Pochi autori classici hanno dato descrizioni così accurate dello sviluppo del neonato:
Poi cominciai anche a ridere, prima nel sonno, quindi nella veglia. Così almeno mi fu riferito sul mio conto, e vi ho creduto, perché vediamo gli altri bambini comportarsi così; infatti non ricordo nulla di questi tempi miei. Ed ecco che a poco a poco incominciai ad avere anche coscienza del luogo ove mi trovavo; volevo manifestare i miei desideri alle persone che erano in grado di soddisfarli, senza esito alcuno, poiché i primi stavano nel mio interno, le seconde all’esterno e con nessuno dei loro sensi potevano penetrare nel mio animo. Perciò mi dibattevo e strillavo, esprimendo così per analogia i miei desideri, quanto poco potevo, e come potevo, in maniera, difatti, irriconoscibile5.
In seguito Agostino avrebbe sviluppato osservazioni molto pertinenti anche sul modo in cui i bambini imparano a parlare.
Dall’infanzia, procedendo verso l’età in cui mi trovo ora, passai dunque nella fanciullezza, se non fu piuttosto la fanciullezza a raggiungermi succedendo all’infanzia. Quest’ultima non si ritrasse certamente: dove svanì? Tuttavia ormai più non era. Io non ero più un infante senza favella, ma ormai un fanciullo loquace, ben lo ricordo. Del modo come appresi a parlare mi resi conto solo più tardi. Non mi ammaestrarono gli anziani, suggerendomi le parole con un insegnamento metodico, come poco dopo per la lettura e la scrittura; ma fui io stesso il mio maestro con l’intelligenza avuta da te, Dio mio, quando con gemiti e molteplici grida e molteplici gesti degli arti volevo manifestare i moti del mio cuore, affinché si ubbidisse alla mia volontà; ma ero incapace di manifestare tutta la mia volontà e a tutti coloro che volevo6.
Il bambino impara a parlare senza maestri, a differenza di quel che accade per imparare a leggere e scrivere. Nell’apprendimento hanno importanza intelligenza, volontà e memoria:
Afferravo con la memoria: quando i circostanti chiamavano con un certo nome un certo oggetto e si accostavano all’oggetto designato, io li osservavo e m’imprimevo nella mente il fatto che, volendo designare quell’oggetto, lo chiamavano con quel suono. Che quella fosse la loro intenzione, lo arguivo dal movimento del corpo, linguaggio, per così dire, comune di natura a tutte le genti e parlato col volto, con i cenni degli occhi, con i gesti degli arti e con quelle emissioni di voce, che rivelano la condizione dell’animo cupido, pago, ostile o avverso. Così le parole che ricorrevano sempre a un dato posto nella varietà delle frasi, e che udivo di frequente, riuscivo gradatamente a capire quali oggetti designassero, finché io pure cominciavo a usarle, dopo aver piegato la bocca ai loro suoni, per esprimere i miei desideri. Giunsi così a scambiare con le persone tra cui vivevo i segni che esprimevano i desideri, e m’inoltrai ulteriormente nel consorzio procelloso della vita umana, dipendendo dall’autorità dei genitori e dai cenni degli adulti7.
Queste osservazioni Agostino le riferisce a se stesso, ma è chiaro che le ha potute fare guardando lo sviluppo del figlio. Il quale crebbe, come tutti i bambini, molto in fretta. Divenne adolescente e rivelò doti intellettuali veramente notevoli. “Era appena quindicenne e superava per intelligenza molti importanti e dotti personaggi”8. Il padre riconosce che questa intelligenza non è merito suo, ma un dono di Dio:
Ti riconosco i tuoi doni, Signore Dio mio, creatore di tutto, abbastanza potente per dare forma alle nostre deformità; poiché di mio in quel ragazzo non avevo che il peccato, e se veniva allevato da noi nella tua disciplina, fu per tua ispirazione, non d’altri. Ti riconosco i tuoi doni. In uno dei miei libri, intitolato Il maestro, mio figlio appunto conversa con me. Tu sai che tutti i pensieri introdotti in quel libro dalla persona del mio interlocutore sono suoi, di quando aveva sedici anni9.
È forse utile rileggere le prime righe del De magistro per cogliere, per così dire in presa diretta, lo spessore dei dialoghi tra Agostino e suo figlio.
Agostino — Che cosa s’intende ottenere, secondo te, quando si parla?
Adeodato — Per quanto ora ho in mente, o insegnare o apprendere.
Agostino — M’è evidente il primo dei due casi, e son d’accordo. È chiaro che parlando s’intende insegnare. Ma apprendere come?
Adeodato — E come, secondo te, se non dialogando?10
Il dialogo è il cuore di ogni vero progetto educativo, ma era il cuore anche del rapporto intenso che univa Agostino e suo figlio. A Cassiciaco, nella villa in cui Agostino si era ritirato con alcuni amici per fare filosofia insieme con loro, c’era dunque anche il figlio. Nel De beata vita vi è un ricordo preciso: “Adeodato pure era con noi, mio figlio, il più giovane di noi tutti, e le sue qualità, se l’amore non mi rende cieco, promettevano qualcosa di grande”11. Non è un caso perciò se Adeodato venne battezzato insieme con il padre, a Milano, il giorno di Pasqua, il 24 aprile del 387. Quando poi Agostino tornò in Africa il figlio lo seguì, vivendo con lui nel monastero da lui fondato a Tagaste. Poco tempo dopo, Adeodato morì, per cause sconosciute. Forse non aveva ancora 18 anni, cioè non aveva ancora l’età in cui il padre lo aveva concepito. Il ricordo che Agostino ne fa nelle Confessioni è una delle più belle testimonianze di amore paterno che siano state conservate:
La sua intelligenza m’ispirava un sacro terrore; ma chi, al di fuori di te [Dio], poteva essere l’artefice di tali meraviglie?
Presto hai sottratto la sua vita alla terra, e il mio ricordo di lui è tanto più franco, in quanto non ho più nulla da temere per la sua fanciullezza, per l’adolescenza e l’intera sua vita. Ce lo associammo, dunque, come nostro coetaneo nella tua grazia, da educare nella tua disciplina. E fummo battezzati, e si dileguò da noi l’inquietudine della vita passata. In quei giorni non mi saziavo di considerare con mirabile dolcezza i tuoi profondi disegni sulla salute del genere umano12.
Partendo da queste parole da cui traspare un vero affetto paterno, appare difficile capire come invece Agostino, quando ricorda la sua stessa infanzia, ne abbia una percezione del tutto infelice. C’è un celebre passo del De civitate Dei che viene sempre citato a questo proposito:
la vita dei mortali è di per sé tutta un castigo perché è tutta una tentazione, come sentenzia la sacra Scrittura, in cui è scritto: “Non è forse una tentazione la vita umana sulla terra?”. Difatti non è un piccolo castigo la mancanza di educazione alle lettere e al lavoro e giustamente si ritiene che si deve superare al punto che attraverso castighi assai penosi i fanciulli sono costretti ad apprendere un qualche mestiere e le lettere; e l’apprendere stesso, al quale sono obbligati con castighi, è per loro tanto penoso che talvolta, anziché apprendere, preferiscono sopportare i castighi, con i quali sono stimolati ad apprendere. Chi non rabbrividirebbe e non sceglierebbe di morire se gli si proponesse l’alternativa, o rassegnarsi a morire o tornare all’infanzia? Essa, poiché inizia la vita non col sorriso ma col pianto, inconsapevolmente predice la serie di dolori che ha iniziato a percorrere13.
Tre osservazioni si impongono. La prima è che la vita comincia con un pianto, predizione dei dolori che seguiranno. La seconda è che la scuola è segnata da duri castighi. La terza è che per Agostino sarebbe meglio morire che tornare all’infanzia. È giustamente famoso il brano autobiografico delle Confessioni:
Fui mandato a scuola, a imparare a leggere e a scrivere, senza avere la minima idea, infelice, di che uso se ne potesse fare. E tuttavia, se ero tardo nell’apprendere, mi battevano. Perché era un metodo approvato dagli adulti, e molti venuti al mondo prima di noi avevano aperto le dolorose vie per cui ci costringevano a passare, tanto per accrescere un po’ la dose di fatica e affanno riservata ai figli di Adamo. Là però trovammo anche, mio Signore, persone che pregavano te, e da loro venimmo a sapere, per quanto era nelle nostre possibilità, che tu esistevi... E da bambino infatti cominciai a pregare te, soccorso e rifugio mio, e sfrenavo del tutto la mia lingua quando ti invocavo: e ti pregavo, per piccolo che fossi, con passione non piccola, di fare che non mi battessero. E… perfino i miei genitori, che pure non volevano mi accadesse nulla di male, ridevano delle botte che mi toccavano: come non fossero allora, per me, un male grande e angoscioso14.
L’idea che l’infanzia sia un’età di sofferenza era, ai tempi di Agostino, un’eredità del mondo classico, ampiamente diffusa15. Per averne un’idea, è sufficiente rifarsi a quanto ha lasciato scritto Cicerone:
Il corso della vita è stabilito e unica è la via della natura e semplice e a ciascuna parte della vita è stato assegnato un tempo opportuno, in modo che sia la debolezza dei fanciulli [= infirmitas puerorum ], sia la baldanza dei giovani, sia la serietà dell’età ormai consolidata, sia la maturità della vecchiaia, abbiano un che di naturale che deve essere colto a suo tempo16.
La caratteristica naturale dei bambini, secondo Cicerone, è l’infirmitas, cioè la debolezza, la fragilità, così come la ferocitas, cioè la baldanza o l’aggressività lo è dei giovani, la gravitas, cioè la serietà per gli adulti e la maturitas per gli anziani.
Agostino riprende quest’idea, arricchendola di importanti osservazioni.
Dio poteva dare certamente all’uomo quello che ha dato anche a molti animali. I loro figli, per quanto siano piccoli e non progrediscano nella conoscenza di pari passo con lo sviluppo successivo del corpo, non avendo un’anima razionale, tuttavia, anche quando sono minuscoli, corrono, riconoscono la propria madre e non hanno bisogno d’essere accostati dalla premura di altri a succhiare le mammelle, ma con meravigliosa facilità le trovano da sé, benché collocate in parti riposte del corpo materno. Al contrario, i bambini al momento in cui nascono non hanno né piedi idonei a camminare, né mani abili nemmeno a grattare e, se la nutrice non avvicina alle loro immote labbra e non vi introduce i capezzoli del petto, non sentono da sé dove siano e potrebbero più facilmente piangere per fame che succhiare le mammelle pendule accanto a loro. Corrisponde quindi in modo assoluto alla debilità della mente questa debilità del corpo17.
Vi è in queste parole l’eco delle idee correnti a quel tempo, a cominciare da Aristotele, che, come si è visto, aveva detto che i piccoli dell’uomo sono “più incompiuti di tutti gli altri animali compiuti”18. Lo sviluppo agostiniano dell’idea dell’infirmitas puerorum sta nel fatto di legare la debolezza del corpo del bambino alla debolezza della sua mente. Di qui deriva una riflessione ulteriore: sia la debolezza del corpo che quella della mente sono frutto di un’altra debolezza, quella morale, perché la infirmitas si è introdotta nel mondo a causa del peccato. Agostino sviluppa questa riflessione soprattutto in un’opera destinata a promuovere il battesimo dei bambini.
Così pertanto si adempì quello che aveva detto Dio: “Quando ne mangerete, certamente morirete”. Ogni bambino dunque che viene generato carnalmente da questa disobbedienza della carne, da questa legge di peccato e di morte, ha bisogno d’essere rigenerato spiritualmente non solo per essere portato al regno di Dio, ma anche per essere liberato dalla condanna del peccato. I bambini quindi nascono nella carne soggetti inseparabilmente al peccato e alla morte del primo uomo e rinascono nel battesimo associati inseparabilmente alla giustizia e alla vita eterna del secondo uomo19.
Andando avanti Agostino approfondisce il legame tra infirmitas e peccato, proponendo una riflessione su Adamo nel Paradiso terrestre:
Chiederà qualcuno: “Se questa natura [dei bambini] non è pura, ma si hanno in essa le prime manifestazioni di una natura viziosa, perché Adamo non fu creato in tali condizioni…?”. Al quesito così proposto rispondiamo: Quanto ad Adamo, la ragione per cui non fu creato nelle condizioni attuali è che, non essendo stato preceduto dal peccato di nessun ascendente, non fu creato nella carne del peccato. Quanto a noi, siamo nelle condizioni attuali, perché, essendo stati preceduti dal peccato di Adamo, siamo nati nella carne del peccato… Infatti qui non si tratta di Adamo quanto alla quantità del suo corpo, perché non fu fatto piccolo, bensì con le membra perfettamente formate…; ma si tratta qui di una certa vigoria della mente di Adamo e dell’uso della sua ragione, per cui poteva accettare docilmente l’autorità di Dio e la prescrizione del suo comando e la poteva osservare facilmente se voleva. Adesso invece l’uomo nasce così da non essere assolutamente capace di ciò a causa di un’orrenda ignoranza e debolezza, non della carne, ma della mente, sebbene siamo tutti concordi nel riconoscere che nel bambino vive un’anima non di un’altra sostanza, ma della medesima sostanza che aveva nel primo uomo, cioè un’anima ragionevole. Per quanto, anche la stessa debolezza così massiccia della carne sta a indicare a mio avviso un non so che di penale20.
Agostino dunque riconosce che i bambini abbiano un’anima, del tutto simile a quella degli adulti, cioè ragionevole, ma quest’anima è marchiata da un’orrenda infirmitas che è l’eredità del peccato. Una prova ne è il fatto che in Paradiso, cioè nel luogo della perfetta beatitudine, non c’erano bambini. La ragione è che Eva generò il primo figlio dopo il peccato, ma Agostino arriva a porsi un interrogativo interessante: come sarebbero stati i figli di Adamo ed Eva se fossero nati nel Paradiso terrestre?
Ci incuriosisce per esempio di sapere se i primi uomini, qualora non avessero peccato, avrebbero generato figli in tali condizioni da non avere l’uso né della lingua né delle mani né dei piedi. A causa della capienza dell’utero sarebbe stato forse inevitabile che nascessero piccoli. Però, pur essendo piccola parte del corpo una costola, non per questo tuttavia Dio fece ad Adamo una sposa piccola plasmando la donna con la costola. Perciò l’onnipotenza del Creatore poteva far diventare subito grandi anche i figli della donna appena dati alla luce21.
Dato che la piccolezza e l’infirmitas dei bambini non erano adatti al paradiso, Agostino ipotizza che Eva avrebbe potuto generare dei figli subito adulti. Poi però la sua capacità di osservazione delle cose umane gli fa abbandonare quest’idea: a causa delle dimensioni dell’utero della donna appare inevitabile che Eva non potesse che generare dei figli piccoli. Ma qui la soluzione è geniale: anche se fossero nati piccoli, Dio avrebbe potuto istantaneamente renderli adulti. C’era per questo un precedente: la creazione della stessa Eva, che, tratta da una costola di Adamo, era stata anche lei creata immediatamente adulta. Al di là della ingegnosità della soluzione trovata, resta comunque il fatto che, per Agostino, i bambini non erano adatti per il Paradiso terrestre.
Se si torna ai ricordi della propria infanzia che Agostino narra nelle Confessioni, si vede che egli attribuiva innanzi tutto a se stesso, l’idea di essere stato un bambino cattivo.
Chi mi rammenta i peccati della mia infanzia, se nessuno innanzi a te è “mondo di peccato”, neppure il bimbo, che ha “un giorno solo di vita sulla terra”? Chi me li rammenta, se non un piccino ora grande soltanto così, in cui vedo ciò che non ricordo di me stesso? Qual era dunque il mio peccato di allora? Forse l’avidità con cui cercavo piangendo le poppe? Se oggi facessi altrettanto, cercando avidamente non più le poppe, s’intende, ma il nutrimento conveniente alla mia età, mi farei deridere e riprendere a buon diritto. Ossia, a quell’età commettevo atti riprovevoli, ma, poiché non avrei potuto comprendere i rimproveri, si evitava, come fanno tutti ragionevolmente, di rimproverarmi. Tanto è vero, che noi estirpiamo ed eliminiamo quei difetti durante la crescita, e non ho mai visto nessuno gettar via deliberatamente il buono mentre vuole estirpare il cattivo. O forse erano anche quelle azioni buone, in rapporto all’età: le implorazioni, cioè, con cui chiedevo piangendo persino doni nocivi, le aspre bizze contro persone di libera condizione e di età più grave della mia, che non si assoggettavano alla mia volontà; gli sforzi per colpire con tutte le mie forze chi mi aveva dato la vita e molte altre persone più prudenti di me, che non ubbidivano ai miei cenni, percuotendole perché non eseguivano certi ordini che si sarebbero eseguiti con mio danno? Dunque l’innocenza dei bambini risiede nella fragilità delle membra, non dell’anima22.
Qui sembra che Agostino si discosti da Clemente. Per quest’ultimo il bambino era il simbolo stesso dell’innocenza, per il vescovo di Ippona invece l’innocenza non è che una condizione di fragilità delle membra, mentre nell’anima permane un sentimento malvagio.
Io ho visto e considerato a lungo un piccino in preda alla gelosia: non parlava ancora e già guardava livido, torvo, il suo compagno di latte. È cosa nota, e le madri e le nutrici pretendono di saper eliminare queste pecche con non so quali rimedi; ma non si può ritenere innocente chi innanzi al fluire ubertoso e abbondante del latte dal fonte materno non tollera di condividerlo con altri, che pure ha tanto bisogno di soccorso e che solo con quell’alimento si mantiene in vita. Ciò nonostante si tollerano con indulgenza questi atti, non perché siano inconsistenti o da poco, ma perché destinati a sparire col crescere degli anni. Lo prova il fatto che gli stessi atti, sorpresi in una persona più attempata, non si possono più tollerare con indifferenza23.
Tutte queste riflessioni sono proprie di Agostino e avranno un’influenza considerevole nei pensatori cristiani del Medioevo occidentale. Ma lo stesso Agostino, diventato cristiano e poi vescovo, si è misurato con le numerose espressioni bibliche che contraddicono ogni giudizio negativo riguardo all’infanzia. Un esempio molto interessante è il suo commento al Salmo 112, che, nella traduzione latina della Vulgata, che riprendeva quella greca dei Settanta, si intitola Laudate, pueri, Dominum, Lodate, bambini, il Signore. Si tratta di un salmo molto importante, perché introduce la preghiera dell’Hallel, cioè la preghiera che gli ebrei recitano nella notte di Pasqua. Come è possibile che i primi chiamati a lodare il Signore siano proprio i bambini? Agostino lo spiega così:
Voi, fratelli, che con molta assiduità ascoltate [la parola di Dio], ricordate certamente quanto dice il Signore nel Vangelo: “Lasciate che i fanciulli vengano a me, poiché proprio di loro è il regno dei cieli; e inoltre: Chi non avrà accolto il regno dei cieli come un bambino non vi entrerà”. In molte pagine il Signore pone sotto accusa la superbia del nostro uomo vecchio ricorrendo all’esempio caratteristico dei bambini, volendo con tale raffronto instaurare in noi una nuova vita basata sull’umiltà. Pertanto, o carissimi, quando udite cantare le parole del salmo: “Lodate, o bambini, il Signore”, non dovete pensare che l’invito non sia rivolto a voi che siete usciti dalla puerizia, trovandovi nel bel fiore della giovinezza o nella veneranda canizie della vecchiaia24.
La puerizia è contrapposta da Agostino alla superbia.
Per la superbia l’uomo diventa presuntuoso e, gonfiandosi vanamente della propria eccellenza, non riesce a camminare per la strada stretta né a entrare per la porta piccola. Il bambino invece si caccia con molta facilità anche nei luoghi stretti, e proprio per questo nessuno potrà entrare nel regno dei cieli se non diventerà come un bambino25.
Il salmo, interpretato da Agostino alla luce del Vangelo, vuole “instaurare in noi una nuova vita basata sull’umiltà”. Abbiamo così una nuova idealizzazione: se per Clemente il bambino era il simbolo dell’innocenza e della purezza, per Agostino diventa il simbolo dell’umiltà. In ogni caso, per l’uno come per l’altro, le parole evangeliche non cessano di mettere in discussione identità acquisite, con l’invito a uomini adulti di diventare bambini.
Per spiegare questo aspetto del messaggio evangelico Agostino utilizza un verbo, già usato da Tertulliano: repuescere, che vuol dire tornare bambini (puer). L’ideale diventa così quello di una vecchiaia infantile e di una infanzia adulta. Come dice ancora nel commento al Salmo 112:
Sia pertanto la vostra vecchiaia una vecchiaia infantile, e la vostra fanciullezza una fanciullezza adulta. Cioè la vostra sapienza non sia mescolata a superbia, né la vostra umiltà sia priva di saggezza, sicché lodiate il Signore e ora e nei secoli26.
È una ripresa dell’antico tema del puer senex, ma che a questo punto si colora di sfumature diverse, perché si prefigura anche l’immagine del senex puer, che avevamo incontrato già in Ambrogio, cioè dell’anziano che ritorna bambino. Tutti temi che avranno un lungo seguito nel corso del medioevo occidentale.
1 Agostino, Confessioni, 9,6,14.
2 Ibidem, 6,15,25.
3 Ibidem, 4,2,2.
4 Agostino, Confessioni, 1,6,7.
5 Ibidem, 1,6,8.
6 Agostino, Confessioni, 1,8,13.
7 Agostino, Confessioni, 1,8,13.
8 Agostino, Confessioni, 9,6,14.
9 Ibidem.
10 Agostino, De magistro, 1,1.
11 Agostino, De beata vita, 1,6.
12 Agostino, Confessioni, 9,6,14.
13 Agostino, La città di Dio, XXI, 14.
14 Agostino, Confessioni, I,9,14.
15 Note analoghe a quelle di Agostino a proposito delle sofferenze scolastiche si ritrovano in Giovanni Crisostomo, cfr. Rudolph Braendle, Giovanni Crisostomo. Vescovo, riformatore, martire, Borla, Roma 2007, p. 27.
16 Cicerone, De senectute, X, 33: «Cursus est certus aetatis et una via naturae, eaque simplex, suaque cuique parti aetatis tempestivitas est data, ut et infirmitas puerorum, et ferocitas iuvenum et gravitas iam constantis aetatis et senectutis maturitas naturale quiddam habeat, quod suo tempore percipi debeat». Traduzione Luigi Chiosi.
17 Agostino, Il castigo e il perdono dei peccati e il battesimo dei bambini, III, 38.
18 Vedi cap. 1, nota 25.
19 Agostino, Il castigo e il perdono dei peccati e il battesimo dei bambini, 16.
20 Agostino, Il castigo e il perdono dei peccati e il battesimo dei bambini, 37, 68.
21 Ibidem.
22 Agostino Le Confessioni, 1, 7, 11.
23 Agostino, Le Confessioni, 1, 7, 11.
24 Agostino, Esposizione sul salmo 112, Discorso al popolo, 1.
25 Ibidem.
26 Agostino, Esposizione sul salmo 112, 2.
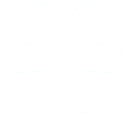 NOTEdiSTORIA
NOTEdiSTORIA