“La storia dell’educazione è oggi un contenitore di molte storie, dialetticamente interconnesse e interagenti, accomunate dall’oggetto complesso «educazione», se pure messo sotto lenti diverse e differenziato nella sua fenomenologia. Non solo anche i metodi (le lenti, per così dire) hanno caratteri preliminarmente differenziati, in modo da dare a ogni ambito d’indagine la sua autonomia/specificità, da riconoscerlo come un «territorio» dell’indagine storica”1. Con queste parole Franco Cambi, nel suo Manuale di storia della pedagogia, dà ragione del carattere poliedrico di tale disciplina. Lo stesso Cambi descrive così le facce di questo poliedro:
Se dovessimo, un po’ approssimativamente, caratterizzare le diverse storie (i loro oggetti e i loro metodi) potremmo indicare, come ambiti dotati di autonomia, di settorialità e di tradizione di ricerca, quello delle teorie, quello delle istituzioni, quello delle politiche, poi quello (più ampio e sfumato) della storia sociale (intesa come storia del costume e di alcune figure sociali, come storia delle culture e delle mentalità) e infine quello dell’immaginario (nell’educazione e per l’educazione) che è, forse, ancora gracile nel suo sviluppo, ma in via di affermazione2.
Come si è arrivati a questa ricchezza di approcci e di metodologie? Un punto di svolta è rappresentato certamente dal 1960, quando a Parigi veniva pubblicato un saggio di Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime, tradotto in italiano nel 1968 con il titolo Padri e figli nell’Europa medievale e moderna3.
Il bambino era già da tempo al centro dell’interesse da parte di letterati, filosofi, artisti4. Nell’anno 1900, Ellen Key aveva pubblicato il suo volume Il secolo del bambino profetizzando che nel XX secolo il ruolo dei bambini sarebbe diventato di primaria importanza5. Il volume della Key era solo una delle tante espressioni del nuovo interesse per l’infanzia6. Per fare anche solo un esempio, non si può non citare Maria Montessori, come ha osservato Monica Ferrari:
Prima di Ariès, l’opera di Maria Montessori (che Ariès non nomina mai nel suo volume del 1960), alla ricerca del «segreto dell’infanzia», aveva introdotto il mondo della pedagogia alla scoperta del bambino e alla «questione sociale» dell’infanzia7.
Malgrado questo interesse crescente e generale per l’infanzia, quelli che Franco Cardini chiama gli storici «di professione» prima di Philippe Ariès non avevano dedicato un interesse specifico ai bambini dei secoli passati. Perché tanto ritardo a identificare il bambino come «soggetto storico»? La prima risposta che si può dare è che la Storia dei bambini è difficile, per la particolare condizione delle fonti che la riguardano. Infans, la parola latina da cui viene il termine infanzia, significa “senza voce”. Non avendo voce e non avendo accesso alla cultura scritta, i bambini non hanno potuto lasciare traccia di sé. Per questo motivo non si trovano facilmente fonti sui bambini8. Ma le fonti sono gli strumenti di base per il lavoro degli storici, che consiste nella ricostruzione della vita degli uomini e delle donne dei tempi passati. I bambini in questo senso condividono la condizione di tutti i gruppi subalterni (donne, schiavi, disabili, popoli colonizzati). La storia la scrive chi è al potere. Le fonti trasmettono il punto di vista di chi le ha scritte. Come per scrivere la storia delle donne non si dispone, per molti secoli, che di testi scritti da uomini; come per scrivere la storia dei popoli colonizzati occorre andare a cercare i documenti negli archivi delle capitali europee; come per scrivere la storia degli schiavi, almeno fino a La capanna dello zio Tom, si dovrà far uso di testimonianze scritte lasciate dagli schiavisti, così per la storia dei bambini si dovrà ricorrere a fonti scritte dagli adulti. Nel caso dei bambini però vi è una difficoltà in più. Non soltanto i bambini non hanno potuto lasciare testi scritti dal loro punto di vista, ma anche gli adulti per molti secoli si sono interessati molto poco di loro. I bambini sono anche assenti dalla storia perché chi l’ha scritta per molti secoli non ha ritenuto interessante parlarne. La ragione di questo disinteresse è sempre legata alle fonti che, nel caso dei bambini, sono state scritte da adulti per di più maschi. Il maschio adulto è stato per secoli l’unico vero detentore del potere e, nel caso dei bambini, questo potere era condizionato dal fatto che non era lui, fisicamente, a mettere al mondo i bambini e ad allevarli nei primi anni di vita.
Il rapporto tra padri e figli è stato sempre piuttosto complesso. In questo senso il titolo scelto per la traduzione del volume di Ariès è particolarmente felice: Padri e figli nell’Europa medievale e moderna. In effetti la Storia dei bambini non può che essere anche una Storia di padri: per secoli, sono loro che, pur con tanta scarsezza e riluttanza, hanno lasciato fonti scritte riguardo ai loro figli.
La storia dell’infanzia
Prima di addentrarsi nell’analisi è però utile ripercorrere, almeno a grandi linee, l’evoluzione della Storia dell’infanzia, a cominciare proprio da Philippe Ariès che, come è noto, non era un accademico9. Egli ebbe l’idea di usare fonti poco utilizzate dagli storici: le immagini, cioè le fonti iconografiche, giungendo a conclusioni sorprendenti. Nel secondo capitolo, che si intitola La scoperta dell’infanzia, si legge: “L’arte medievale, all’incirca fino al XII secolo, non conosceva l’infanzia o non tentava di rappresentarla, non vien fatto di credere che quest’assenza fosse dovuta a goffaggine o incapacità. Si è portati piuttosto a pensare che in quel mondo non ci fosse posto per i bambini”10.
Questa osservazione che nel medioevo – cioè nel cuore dell’Europa cristiana – non ci fosse spazio per i bambini, appariva del tutto nuova nel 1960. Ariès la spiegava così:
Nel Medioevo, all’inizio dei tempi moderni, ancora per un pezzo nelle classi popolari, i bambini andavano a confondersi con gli adulti appena erano ritenuti capaci di fare a meno delle madri o delle nutrici, pochi anni dopo un divezzamento ritardato, a sette anni circa. Da questo momento essi entravano di colpo nella grande comunità degli uomini, dividevano coi loro amici, giovani o vecchi, i lavori e le gioie di ogni giorno. Il moto della vita collettiva trascinava nello stesso flusso età e condizioni, senza lasciar tempo a nessuno per la solitudine o l’intimità. In quelle esistenze troppo dense, troppo collettive, non c’era posto per un settore privato. La famiglia assicurava la trasmissione della vita, dei beni, dei nomi; non penetrava a fondo nella sensibilità… La civiltà medievale aveva dimenticato la paideia degli antichi e non conosceva ancora l’educazione dei moderni11.
L’intuizione fu condensata in un’espressione fortunata quanto contestata: il medioevo non conosceva il «sentimento dell’infanzia».
Il libro di Ariès piacque molto, tra gli altri, a Jacques Le Goff12 e venne presto associato a quella nouvelle histoire che, in quegli anni, sulla scia delle riflessioni prodotte dalla rivista Annales, ebbe grande eco in tutto il mondo. Era il tempo in cui era di moda la «storia della mentalità» e la«storia del folklore e della cultura popolare». Tutte categorie di difficile utilizzazione in ambito storico, ma che avevano il fascino e l’interesse di aprire nuovi campi di ricerca, al di là della tradizionale storia del potere e delle istituzioni.
Nel 1960 i tempi per lo studio della Storia dei bambini erano maturi. Dall’altra parte dell’oceano Atlantico, negli Stati Uniti, un altro studioso con un approccio scientifico totalmente diverso da quello di Aries, si stava dedicando in quegli stessi anni al tema della relazione tra genitori e figli nella storia. Si tratta di Lloyd deMause, che legherà la sua fama alla nascita della «psico-storia». Ora, proprio il significato “plurale” (e se si vuole ambivalente) del termine sentiment, ha suscitato la reazione di Lloyd deMause, che ha scritto: «Le tesi centrali dell’Ariès sono l’opposto delle mie: Ariès sostiene che, mentre il bimbo inizialmente era felice perché libero di stare insieme a persone di classi sociali ed età diverse, la particolare condizione conosciuta come infanzia fu “inventata” all’inizio dell’era moderna»13. Il Medioevo, secondo deMause, aveva già un suo sentimento dell’infanzia. Solo che questo sentimento, secondo lui, era fortemente negativo. La sua idea centrale è che i rapporti adulto-bambino siano la chiave di lettura di tutta la storia. Il cuore della sua intuizione storiografica infatti è che i rapporti complessi tra adulti e bambini abbiano caratterizzato tutta la storia dell’umanità. Egli studia i “momenti che incidono maggiormente sulla psiche della generazione a venire”, identificando principalmente tre reazioni possibili dell’adulto davanti al bambino: “a. proiezione;
DeMause amplia l’indagine ai secoli precedenti al Medioevo, fino alle società cosiddette “primitive”, rintracciando, sin dai tempi più remoti, una “pulsione di morte verso i bambini”. Un esempio molto importante viene indentificato nei cosiddetti “sacrifici umani” che, nella grande maggioranza dei casi, non erano altro che sacrifici di bambini. Si trovano tracce sicure del sacrificio rituale dei bambini praticamente in tutte le società antiche: era praticato dai Celti d’Irlanda, dai Galli, dagli Scandinavi, dagli Egiziani, dai Fenici, dai Moabiti, dagli Ammoniti e, in certi periodi, dagli Israeliti15. DeMause sostiene che anche nel Medioevo cristiano l’infanticidio doveva essere praticato:
Ad onta di copiose testimonianze letterarie, il prolungarsi del fenomeno dell’infanticidio lungo il Medioevo è, comunque, di solito, negato dagli stessi storici, forti del fatto che i documenti ecclesiastici e altre fonti statistiche non registrano nulla a proposito. Ma se il rapporto tra i due sessi (156 a 100 nell’801; 172 a 100 nel 1391) offre un’indicazione sulla soppressione delle figlie legittime, e se gli illegittimi erano soppressi senza distinzione di sesso la percentuale effettiva di infanticidi nel Medioevo dovette essere notevole. Certamente Innocenzo III era a conoscenza del gran numero di donne che gettavano i figli nel Tevere, allorché aprì a Roma l’ospedale di Santo Spirito16.
In quest’ultimo caso non si sta parlando più di sacrificio rituale, ma di infanticidio. Per deMause ambedue i fenomeni sono espressione di quella pulsione di morte verso i bambini che caratterizza la storia dell’umanità per molti secoli. Egli infatti identifica sei fasi della storia del rapporto genitori-figli: 1) L’infanticidio (dall’antichità al secolo IV d.C.); 2) L’abbandono (dal IV al XIII secolo d.C.); 3) L’ambivalenza (dal XIV al XVII secolo); 4) L’intrusione (secolo XVIII); 5) La socializzazione (dall’inizio del secolo XIX alla metà del secolo XX); 6) L’aiuto (dalla seconda metà del secolo XX).
L’identificazione di questa evoluzione venne ritenuta da deMause così importante da costituire un nuovo paradigma storiografico: “Io credo che la teoria psicogenetica possa fornire un paradigma veramente nuovo per lo studio della storia”17. Anche se confessa che “come il mutamento storico sia connesso col cambiamento nelle cure dei bambini dobbiamo ancora capirlo”, nondimeno ritiene che esso possa essere posto a fondamento di quella che chiama psico-storia.
Si tratta di un’intuizione di grande interesse: il rapporto tra genitori e figli è un nodo fondamentale per la costruzione di ogni società umana e gli storici non possono disinteressarsene.
Ci sono però alcuni punti deboli nella ricostruzione di deMause. Il primo è legato alla lettura progressiva delle relazioni genitori-figli. Le sei fasi da lui descritte porterebbero a un deciso miglioramento della percezione dell’infanzia in epoca contemporanea rispetto al passato. Ciò è senz’altro vero sul piano culturale, se si pensa ad esempio all’importantissima acquisizione della Carta dei diritti del bambino nel 1989. Ma non è facilmente dimostrabile da un punto di vista sociale. I bambini continuano a fare paura anche oggi. È certamente diminuito il numero degli infanticidi, ma è anche vero che la soppressione dei neonati è stata resa inutile dalla pratica dell’aborto selettivo: le tecniche di indagine prenatale consentono di identificare i bambini portatori di handicap poco dopo il concepimento. Non vi è dubbio che fino a poche generazioni fa l’infanticidio rappresentasse in molti casi una forma di eugenetica, cioè di selezione di bambini alla nascita, questo però non autorizza a ritenere migliore la condizione di milioni di bambini del nostro tempo. Bambini soldato, bambini schiavi, bambini migranti, bambini abusati sessualmente sono lì a dirci che la storia non conosce solo una progressione positiva che porta verso la relazione di aiuto: ancora oggi milioni di adulti si comportano verso i bambini con atteggiamenti dettati da una «pulsione violenta» nei loro confronti.
Il secondo punto debole del paradigma proposto da deMause, consiste nella pretesa di indentificare un solo, principale, motore della storia. Gli storici di professione sono stati vaccinati contro questo tipo di letture univoche, tipiche dalla storiografia marxista, che cercava di identificare il motore della storia nell’economia. In realtà la storia è sempre una grande improvvisatrice, nel senso che l’evoluzione delle vicende umane è determinata da fattori molteplici e talvolta in concorrenza tra loro: dal clima, all’economia, ai fenomeni sociali, alle guerre, alle religioni… Certamente anche le relazioni tra genitori e figli hanno avuto un peso nel determinare la storia dell’umanità, ma non possono essere assunte come unico paradigma interpretativo.
Ciò detto, occorre ribadire che la nascita della Storia dell’infanzia rappresenta un grande progresso negli studi storici, perché mette a fuoco un problema che è certamente cruciale nella vicenda degli uomini e delle donne di tutti i tempi.
Il dibattito storiografico
Le ricerche di deMause e di Ariès hanno suscitato numerose prese di posizione18. Sono molti gli studiosi, in tutto il mondo, che hanno sentito il bisogno di prendere le distanze soprattutto dalle idee di Philippe Ariès. In Francia si è scatenata una polemica, che ha coinvolto studiosi come Pierre Riché, Jean-Louis Flandrin e Emmanuel Le Roy Ladurie. Le ragioni di queste diverse critiche sono state esposte con acutezza da Danièle Alexandre-Bidon19, la quale, in un lavoro del 1997, arriva a dire che:
Philippe Ariès, tenendo conto dell’insieme di queste critiche, sin dal 1973 ha sfumato le sue posizioni in una lunga prefazione alla nuova edizione del suo lavoro. Sette anni più tardi ha confessato: “Mi dispiace di non essermi informato meglio sul Medioevo, di cui il mio libro parla così poco”. Purtroppo, mentre il fondatore sfumava le sue affermazioni, i suoi emuli sono andati ancora più lontano del loro ispiratore nella negazione del sentimento dell’infanzia… Elisabeth Badinter, che non è storica, ma il cui libro L’amore in più ha conosciuto anch’esso un successo notevole, non esita ad affermare che, prima dell’inizio del XIX secolo, l’Occidente è “una società senza amore”, che l’affetto materno non esiste e che il bambino, disprezzato “come un giocattolo o una macchina… fa paura”. Il bisogno radicato in noi di credere che l’amore per i bambini sia una conquista recente, un modo per nobilitare la nostra storia contemporanea per tanti aspetti così tragica, è forse all’origine del disprezzo che ha permesso di credere all’assenza di amore e di tenerezza verso i bambini nei tempi antichi. Trentasette anni sono passati dall’apparizione del libro di Philippe Ariès. La gran parte delle sue idee sono oggi ridotte in cenere20.
In Gran Bretagna le prese di posizione contro Ariès non sono meno esplicite. Nicholas Orme, ad esempio, esprime in modo deciso le sue perplessità davanti alle tesi dello storico francese:
Ariès concede che i padri e le madri nel medioevo si prendevano cura dei loro figli e li amavano, ma sostiene che la relazione con essi fosse abitualmente più distaccata e meno simpatetica. Gli adulti non erano così interessati all’infanzia da riconoscerle uno status separato: “nella società medievale l’idea di infanzia non esisteva”… Un lettore casuale del libro potrebbe pensare che il suo autore sia giunto a queste conclusioni dopo uno studio approfondito. In realtà il libro fa scarso uso di fonti medievali, al di là di immagini, sculture e poche memorie letterarie del XV secolo. Le opinioni di Ariès hanno avuto un’influenza soprattutto tra persone che non erano storici del medioevo… Nessuno studioso ha trovato materiale per confermare le tesi di Ariès, tutti, in modi diversi, le hanno confutate21.
L’affermazione di Orme non è del tutto vera: ci sono stati studiosi che invece hanno trovato conferma delle idee di Ariès. Si può fare l’esempio di Christiane Klapisch-Zuber, che nel 1987 scriveva: «nell’iconografia come nel linguaggio quotidiano il bambino dopo i sette anni non era altro che un individuo di seconda classe, spesso ignorato nel silenzio o spinto brutalmente nel mondo degli adulti»22. In Italia le reazioni alle tesi di Ariès sono state più sfumate, anche grazie alla lettura che di esse ha fatto Egle Becchi, la più importante storica dell’infanzia in Italia, che ha compreso correttamente il valore del termine-chiave “sentiment” utilizzato dallo storico francese.
il termine di sentimento, sentiment in francese, [è] uno dei non pochi costrutti che la storia delle mentalità e poi quella nouvelle hanno scelto e usato per veicolare idee nuove, non del tutto perspicue, che andavano proposte e fatte accettare, su cui venivano costruite intere impalcature interpretative… Sentimento infatti vuol dire [per Ariès], ancor prima che feeling, cioè emozione – accezione che egli non rifiuta – idea, rappresentazione nel senso duplice di raffigurazione e di nozione, nonché di assegnazione di valore23.
La posizione della Becchi consente di distinguere i piani. Non si può immaginare che per secoli le madri e i padri non abbiano avuto amore per i loro figli, ma si può capire come la comprensione dell’infanzia, il sentiment come consapevolezza culturale del suo valore, sia stata per moltissimo tempo, come aveva intuito Ariès, diversa da quella contemporanea.
In Italia, insieme ai lavori della Becchi, hanno avuto poi una profonda influenza i lavori di Ottavia Niccoli e in particolare un volume collettivo, da lei curato, dal titolo Infanzie. Funzioni di un gruppo liminale dal mondo classico all’Età moderna, pubblicato nel 199324. In questi lavori si trovava una spiegazione dell’atteggiamento molteplice e a volte contraddittorio verso l’infanzia. I bambini sono percepiti come gruppo liminale, cioè posto in una terra di frontiera, al confine tra natura e grazia, tra razionalità e follia e, proprio per questa condizione, suscitano disprezzo e paura, ma anche attesa e ammirazione. Per usare le parole della Niccoli a illustrazione del pensiero cristiano dei primi secoli:
L’infanzia è un’età di negligenza e di indolenza; anzi essa diventa addirittura in qualche modo simbolo di peccato… Il bambino è creatura incompiuta e imperfetta, remota dalla pienezza positiva dell’essere costituita dal maschio adulto. Per questo… diviene degno di attenzione solo quando la grazia gli concede di superare la natura e di manifestare con la sua eccezionalità – col dono divino della sapienza o almeno con quello, sicuramente umano della parola – l’onnipotenza divina25.
Nello stesso volume, Cristiano Grottanelli sintetizzava questa condizione liminale dei bambini.
I bambini, insomma, rivelano segnali dell’Altro perché stanno ai confini del Noi. Per questo stesso motivo, essi sono i mediatori con il caso, che è Altro in quanto gratuito. Per lo stesso motivo, infine, sono sacri26.
In ogni caso, quando si è andati a guardare le fonti a partire da questi diversi punti di vista, ci si è accorti che questa mancata “assegnazione di valore” è durata molto a lungo, se si pensa che anche Jean-Jacques Rousseau, riconosciuto come padre del pensiero pedagogico moderno, nelle sue Confessioni, scriveva:
Il mio terzo figlio fu dunque posto all’ospizio, al par dei primi, e così fu dei due che seguirono; ché ne ebbi cinque in tutto. Quell’accomodamento mi parve sì buono, sensato, legittimo, che se non me ne vantai apertamente fu solo per riguardo alla madre […] In una parola, non feci alcun mistero della mia condotta… perché in realtà non ci vedevo alcun male. Dopo aver soppesato il pro e il contro, scelsi per i miei figli il meglio, o ciò che mi parve tale27.
Gli sviluppi della ricerca
La Storia dell’infanzia in questi anni ha fatto numerosi progressi, nella metodologia, nell’ampiamento dei campi di indagine, nella capacità di leggere le fonti. Si è registrata così una crescita di interesse attorno alla vita dei bambini e alle idee intorno all’infanzia nel passato, sia per quel che riguarda la ricerca scientifica e accademica che per quel che riguarda la produzione culturale rivolta al più ampio pubblico28. Alcune acquisizioni sono oggi in gran parte condivise da tutti i ricercatori e possono essere messe in evidenza. La prima è che i bambini nel medioevo erano tanti. Più esattamente, sappiamo che durante tutto il millennio medievale i bambini e i giovani in età prima del matrimonio erano la maggioranza della popolazione. Questa acquisizione ci viene dagli studi di demografia storica, pur coscienti che gli studi di questo tipo si scontrano con la scarsezza dei documenti. È però una certezza il fatto che, tanto nel Polittico dell’Abbazia di San Vittore di Marsiglia redatto negli anni 813-81429, come nel catasto fiorentino del 142730, la fascia di età da 0 a 21 anni supera decisamente il 50% delle persone censite. È quindi molto interessante cercare di restituire la voce a questa maggioranza silenziosa che per secoli è rimasta per tanti versi nascosta. D’altra parte, conoscere il modo in cui una società tratta i suoi bambini e in generale i suoi membri più deboli, può contribuire in modo decisivo alla comprensione dei valori di fondo di una cultura e di una civiltà: il senso della vita, l’atteggiamento verso la sofferenza, la dimensione della coesione sociale31. Valgono ancora una volta, su questi temi, le osservazioni di Egle Becchi.
La conoscenza storica dell’infanzia… si deve cimentare con una figura del passato ambigua al pari di altre – la donna, l’anziano, il povero, chi non ha diritti, l’insano – che non hanno lasciato quasi traccia di sé, ma è più criptica, perché fortemente e fatalmente iscritta nel tempo della crescita del suo oggetto – che è appunto il bambino – il quale si trasforma velocemente in un’altra figura, quella dell’adulto e diviene pertanto oggetto di un altro discorso32.
Una seconda acquisizione è che i bambini nella storia sono stati meno muti di quel che si credeva. Sessant’anni fa si riteneva che non avessero lasciato tracce e che dunque non ci fossero fonti dirette da utilizzare per ricostruirne la storia. Oggi la situazione è diversa. Le fonti scritte da bambini ci sono, anche se, naturalmente, sono poche e di difficile lettura. Come per qualsiasi altra cosa, nel momento in cui si comincia a cercare, si trova ciò che si cerca. È così, ad esempio, che Egle Becchi già nel 1994 faceva notare che alcuni graffiti di Pompei sono certamente opera di bambini33.
Queste intuizioni sono state portate avanti da Monica Ferrari e da un nutrito gruppo di specialisti che si sono interessati alle testimonianze scritte da bambini. In particolare sono di grande interesse gli studi sugli ultimi secoli del Medioevo in Italia, quando ai figli, maschi e femmine, delle case principesche si insegnava a leggere e a scrivere perché le competenze grafiche facevano parte del bagaglio culturale richiesto alle famiglie che detenevano il potere. Le lettere autografe dei giovani principi assumono un grande interesse come testimonianze della consapevolezza politica e familiare alla quale erano educati34.
Scoperte sorprendenti vengono anche dall’Egitto. Come ha scritto la papirologa italiana Raffaella Cribiore: «Le sabbie d’Egitto hanno conservato gli esercizi scolastici scritti da studenti e insegnanti e alcuni testi che sono stati utilizzati nelle scuole. Questo materiale didattico è presente su papiro, ostraca [frammenti di ceramica o terracotta n.d.t.], tavolette di legno e di cera, e, più raramente, pergamena»35.
Un’osservazione si impone. Se queste, come sembra, sono le prime fonti puerili della storia, allora si deve notare che si tratta di fonti derivate da un impegno intellettuale. Le più antiche attestazioni che i bambini hanno lasciato di sé nella storia sono testimonianze della loro intelligenza. I graffiti e i testi sui papiri infatti non sono solo esercizi scolastici che mostrano competenze e capacità (ovviamente iniziali) da parte dei bambini, ma sono esplicite testimonianze del loro impegno e del loro desiderio di imparare.
Non solo: quella dei bambini è un’intelligenza plastica, capace di innovare. Lo provano alcune lettere in papiro ritrovate dalla Cribiore: mentre lo stile epistolare degli adulti era piuttosto formale e convenzionale, le lettere dei bambini rivelano una spontaneità e un’inventiva che allora forse venivano corrette, ma che oggi suscitano la nostra ammirazione.
Una terza acquisizione è che vi è stato nei confronti dei bambini un perdurante preconcetto negativo. In fondo questa era la novità che aveva suscitato tante resistenze 60 anni fa: Ariès aveva parlato di carenza del sentimento dell’infanzia, deMause aveva aggiunto che il bambino nel corso della storia non è stato solo dimenticato, ma anche violentato, disprezzato, escluso. Rileggendo in questa prospettiva gli autori classici più citati nel corso del medioevo, ci si accorge di un preconcetto anti infantile che ha attraversato i secoli e le culture. Come non ricordare la pagina dell’Etica Nicomachea nella quale Aristotele dichiara che i bambini, come gli animali, non possono essere veramente felici?36. Nelle Etymologiae di Isidoro di Siviglia, la prima grande enciclopedia medievale, si paragonano i bambini agli stolti: «I fisici, infatti, dicono che gli stolti hanno sangue più freddo, i prudenti, invece, caldo: per questo i vecchi, nei quali il sangue si va ormai raffreddando, così come i bambini, nei quali non è ancora caldo, sono meno assennati»37.
Certo gli stessi autori non esprimono soltanto il preconcetto. Per restare su Isidoro, assieme all’idea dell’insensatezza dei bambini egli trasmette l’importanza dell’amore materno. Lo fa, ad esempio, parlando delle cicogne, le quali “manifestano un grandissimo sentimento di amore e tenerezza nei confronti dei propri figli: riscaldano il nido con tanta cura che il continuo covare fa perdere loro le piume”38. Per questi motivi l’idea di arrivare a scrivere una Storia dei bambini nel Medioevo è bella e allo stesso tempo difficile. In Italia, un frutto dei progressi sulla Storia dei bambini è stato proposto recentemente da Chiara Frugoni, che in un suo volume ha voluto ricostruire la vita dei bambini dalla culla (con le relative fasce e amuleti che accompagnavano il neonato) alle difficoltà della primissima e prima infanzia (con i pericoli di morte, gli infanticidi, ma anche una certa tenerezza), per poi passare alla prima alfabetizzazione, ai giochi e finire con l’adolescenza custodita delle giovani donne. Per far questo ha fatto ampio uso delle fonti iconografiche, riprendendo così una delle intuizioni originarie di Ariès, ma anche la migliore storiografia sull’argomento39.
Santa innocenza
Questo lavoro però, collocandosi nella prospettiva della Storia dell’infanzia, vuol essere un contributo allo studio delle idee, ovvero delle rappresentazioni, che gli adulti si sono fatti dell’infanzia nel corso del millennio medievale.
In effetti tra tutti gli importanti progressi nella conoscenza della condizione infantile nel medioevo, il settore di studio su cui forse è necessario un maggiore approfondimento è proprio quello relativo all’immaginario. Come ha notato Franco Cambi:
Si tratta di un settore, in altri fronti della ricerca storica, ormai sviluppato, dopo le indagini pionieristiche di un Huizinga e poi di un Ariès o di un Tenenti, a cui stanno lavorando intensamente soprattutto i medievalisti, ma che ha un ruolo importante anche nelle indagini sul Moderno e sul Contemporaneo (si pensi a Baczko, si pensi a Mosse). Scarsissima è stata, invece, la ricaduta in ambito educativo. Eppure molta parte dell’educazione – dai processi di inculturazione alla formazione delle mentalità – passa attraverso l’immaginario40.
Chi scrive non è uno storico dell’educazione e pertanto chiede scusa ai colleghi per eventuali sconfinamenti di steccati disciplinari. Al massimo, da storico, rivendica il titolo di lettore attento delle fonti. Ma è in questa veste che si è accorto che lungo tutto l’arco del medioevo si deve rilevare un perdurante preconcetto anti infantile da parte degli uomini di cultura. Si può giungere a una migliore comprensione di fonti, che nella grande maggioranza dei casi, sono state prodotte – come si è detto – da maschi adulti che avevano fatto la scelta di castità e, in generale, non avevano figli propri. Erano padri nel senso spirituale, ma non lo erano in senso materiale. Questi uomini avevano certamente una qualche esperienza di bambini, perché i monasteri furono praticamente l’unica agenzia educativa per molti secoli e bambini (maschi e femmine) venivano donati a Dio nelle comunità monastiche, dove venivano cresciuti. Praticamente le uniche testimonianze scritte per molti secoli provengono da padri che non erano padri.
Tutti questi uomini sono uomini di Chiesa, cioè persone che avevano fatto del cristianesimo il centro della loro scelta di vita. Per questo non è possibile evitare il problema dell’impatto che il cristianesimo ha avuto su questi temi. Anche se anche altre tradizioni culturali hanno contribuito a formare il pensiero medievale, non vi è dubbio che la tradizione cristiana abbia avuto un’influenza preponderante. L’impatto del messaggio evangelico sulle idee e sulle pratiche relative all’infanzia è valutato dagli specialisti in modo diverso: c’è chi dice che il messaggio evangelico ha prodotto un significativo cambiamento e chi nega decisamente questa lettura. Tra i primi Henny Fiskå Hägg ad esempio ha sottolineato come il cristianesimo abbia introdotto un nuovo atteggiamento verso i bambini come esseri umani, con una maggiore attenzione per la loro vulnerabilità41. Nicholas Orme condivide in gran parte questo punto di vista nelle sue importanti ricerche sulla condizione dei bambini nell’Inghilterra dei secoli centrali del medioevo42. Tra i critici si possono citare, in area italiana, Luigi Canetti, che sottolinea la continuità tra mondo antico e medievale ad esempio per quel che riguarda la divinazione e la profezia infantile43, o Silvia Nagel e Silvana Vecchio, che hanno notato il peggioramento della valutazione morale del bambino ad opera di Agostino e di molti teologi medievali44. Altri ancora, come Reidar Aasgaard hanno fatto vedere come differenti e a volte contrastanti idee sul bambino come essere umano possono essere state presenti nella stessa area culturale e nello stesso contesto storico45. È chiaro come su un tema tanto sensibile le opinioni degli studiosi siano influenzate dalle rispettive convinzioni personali.
Questo lavoro si ripropone di analizzare alcuni testi medievali di diversa tipologia. Ci si renderà conto di un perdurante atteggiamento negativo nei confronti dell’infanzia, in taluni casi aggravato da pratiche (come l’oblazione monastica, cioè l’offerta dei bambini nei monasteri, di cui si parlerà ampiamente nelle pagine che seguono) che non esistevano nell’antichità. È necessario quindi porsi la domanda: “la christianitas medievale ha rappresentato un regresso o un miglioramento nella percezione comune dei bambini e dell’infanzia?”.
Alcuni elementi sembrano andare nella direzione del miglioramento. Brian Patrick McGuire ad esempio ha notato una coincidenza tra la fine della pratica dell’oblazione dei bambini e l’accresciuto interesse per la figura di Gesù bambino, come si vede nei testi di Aelredo di Rievaulx46. Già David Herlihy aveva notato che “il culto del bambino Gesù fu l’arena più adatta all’espressione di sentimenti riguardanti l’infanzia, sacra e profana”47. Si può ritenere che il messaggio evangelico abbia avuto un impatto positivo sulla percezione dell’infanzia, ma che gli effetti si siano visti soltanto sul lungo, o forse lunghissimo, periodo. Per fare un confronto, qualcosa di analogo è stato osservato per la storia delle donne. Anche la condizione femminile nel medioevo ha conosciuto evoluzioni positive solo sul lunghissimo periodo, eppure il messaggio evangelico ha avuto nel corso dei secoli una funzione di fermento, rimettendo in discussione idee che sembravano immutabili48. Forse un discorso analogo si potrebbe fare su altri temi, come la schiavitù, la disabilità o le esecuzioni capitali. In tutti questi casi la storia dell’evoluzione delle idee assume particolare interesse perché avevano conseguenze concrete sulla vita di esseri umani.
Alcune ultime osservazioni circa l’arco cronologico preso in esame: si sono privilegiate le fonti tra VI e XIII secolo, che rappresentano il periodo più intenso di elaborazione delle idee medievali sull’infanzia. Precedono però alcune pagine dedicate a Clemente, Ambrogio, Agostino e Girolamo che non sono certo autori medievali, ma hanno profondamente influenzato il pensiero degli autori che sono qui presentati. Infine si è aggiunta un’appendice sulle testimonianze rese al processo sui martiri di Otranto, anche se fuori dall’arco cronologico prescelto, perché si tratta di una fonte eccezionale, in cui dei bambini prendono la parola. La voce dei bambini di Otranto può rappresentare il punto di arrivo di una linea di evoluzione storica che ha le sue origini nei secoli esaminati in questo libro.
1 F. Cambi, Manuale di storia della pedagogia, Editori Laterza, Roma-Bari 2003.
2 Ibidem.
3 Ph. Ariès, Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, Laterza ed., Roma-Bari 1968.
4 Pensiamo, solo per fare un esempio, a Maria Montessori la cui Antropologia pedagogica è datata normalmente al 1910.
5 E. Key, Barnets århundrade, Stockholm 1900, trad. inglese The Century of the Child, New York 1909, trad. it. Il secolo del bambino, nuova edizione italiana a c. di T. Pironi e L. Ceccarelli, Edizioni Junior, Bergamo 2019.
6 Per avere un’idea dell’interesse per l’infanzia nel XX secolo si può far riferimento a Il Novecento: il secolo del bambino?, a cura di M. Gecchele, S. Polenghi, P. Dal Toso, Edizioni Junior, Bergamo 2017.
7 Monica Ferrari, Costrutti euristici e prospettive di ricerca sull’infanzia nella storia, in Crescere bambini. Immagini d’Infanzia in educazione e formazione degli adulti, Edizioni Junior, Bergamo 2017, p. 29.
8 Su questi temi sono sempre importanti le riflessioni di E. Becchi, Una storiografia dell’infanzia, una storiografia nell’infanzia, in Il Novecento: il secolo del bambino?, Edizioni Junior, Bergamo 2017, pp. 17-30.
9 Lui stesso si presenta come uno storico della domenica. Cfr. Ariès, Uno storico della domenica, 1992.
10 Ph. Ariès, Padri e figli, p. 33.
11 Ibidem, ed. 1981, 483.
12 J. Le Goff, La civilisation de l’Occident médiéval, Paris 1964, trad. it. La civiltà dell’Occidente medievale, Firenze 1969, p. 346: “Lo si è detto, non ci sono bambini nel Medioevo, ci sono solo piccoli adulti”.13 Lloyd deMause, L’evoluzione dell’infanzia, in Storia dell’Infanzia, Traduzione italiana di Lucia Bonardi, Emme Edizioni, Milano 1983, p. 6.
14 Cfr. L. deMause, L’evoluzione dell’infanzia, p. 7.
15 Ibidem, p. 22.
16 Ibidem, p. 26.
17 Ibidem, p. 47.
18 Per una panoramica di questi sviluppi cfr. M. Ferrari, Costrutti euristici e prospettive di ricerca sull’infanzia nella storia, in Crescere bambini. Immagini d’infanzia in educazione e formazione degli adulti, Edizioni Junior, Bergamo 2017, pp. 21-40.
19 D. Alexandre-Bidon, Grandeur et renaissance du sentiment de l’enfance au Moyen Âge, in Educations médiévales, l’enfance, l’école, l’Église en Occident (VieXVe siècles), numero monografico de «Histoire de l’Education», INPR, 1991, pp. 39-63.
20 Danièle Alexandre-Bidon-Didier Lett, Les enfants au Moyen Âge. Ve –XVe siècle, Parigi 1997, p. 10 [trad. it. a cura di chi scrive].
21 N. Orme, Medieval Children, New Haven Yale University Press, London 2001, p. 5 [trad. it. a cura di chi scrive].
22 C. Klapisch-Zuber, La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze, Roma-Bari, Laterza, 1988 (ed. orig. 1987, p. 116).
23 E. Becchi, Il bambino di ieri: breve storia di una storiografia, in «Studi sulla formazione», 1-2010, p. 10.
24 O. Niccoli, Compagnie di bambini nell’Italia del Rinascimento, in «Rivista storica italiana» 101 (1989), pp. 346-374. O. Niccoli, a cura di, Infanzie. Funzioni di un gruppo liminale dal mondo classico all’Età moderna, Firenze, Ponte alle grazie, 1993.
25 O. Niccoli, Infanzia, terra di frontiera, in Infanzie, p. 13.
26 C. Grottanelli, Bambini e divinazione, in Infanzie, p. 69.
27 J.-J. Rousseau, Confessioni, Einaudi, Torino 1955, pp. 390-391. Anche se in seguito Rousseau si pentì di questa scelta.
28 Cfr. J.-F. Chauvard A. Groppi, La place des enfants, in Enfance et monde adulte (Moyen Âge – Époque contemporaine), in «MEFRIM», 123/2 (2011), pp. 311-314.
29 Cfr. M. Zerner, Enfants et jeunes au IXe siècle, la démographie du polyptyque de Marseille, 813814, in «Provence Historique» XXXI, 1981, pp. 355-380.
30 Cfr. D. Herlihy C. Klapisch Zuber, I toscani e le loro famiglie. Uno studio sul catasto fiorentino del 1427, Il Mulino, Bologna 1988.
31 Cfr. R. Aasgaard C. Horn O.M. Cojocaru, Introduction, in Childhood in History. Perceptions of Children in the Ancient and Medieval World, Londra-New York, Routledge 2018, p. 5.
32 E. Becchi, I bambini nella storia, Ed. Laterza, Roma-Bari 1994, p. VI.
33 Ibidem, p. 6. Ma si veda anche E. Becchi Q. Antonelli, Scritture bambine, Roma Bari 1995.
34 M. Ferrari - I. Lazzarini - F. Piseri, Autografie dell’età minore. Lettere di tre dinastie italiane tra Quattrocento e Cinquecento, Viella, Roma 2016. Per un’introduzione storiografica su questi studi si veda anche M. Ferrari - F. Piseri, Scolarizzazione e alfabetizzazione nel Medioevo italiano, in «Reti Medievali Rivista», 14, 1 (2013), pp. 1-36. M. Ferrari, “Per non manchare in tuto del debito mio”. L’educazione dei bambini Sforza nel Quattrocento, FrancoAngeli Editore, Milano 2000.
35 R. Cribiore, Education in the Papyri, in The Oxford Handbook of Papyrology, ed. by Roger S. Bagnall, Oxford University Press, 2009, pp. 320-337 [citazione p. 320].
36 “Logicamente non diciamo che è felice un bue, un cavallo o un altro animale; nessuno di essi infatti è capace di essere partecipe di una tale attività. Per questa causa neppure un bambino può essere felice; a causa dell’età egli infatti non è ancora in grado di essere attivo in tal maniera: i bambini sono detti felici solo in vista delle speranze future. La felicità infatti, come dicemmo, richiede una perfetta virtù e una vita compiuta”: Aristotele, Etica nicomachea, I, 9.
37 Isidoro di Siviglia, Etymologiae, lib. IX, 2, 26.
38 Ibidem, lib. XII, 7, 17.
39 C. Frugoni, Vivere nel medioevo. Donne, uomini e soprattutto bambini, Il Mulino, Bologna 2017.
40 F. Cambi, Manuale di storia della pedagogia, Editori Laterza, Roma-Bari 2003.
41 Henny Fiskå Hägg, Aspects of childhood in secondand thirdcentury Christianity. The case of Clement of Alexandria, in Childhood in History, pp. 127-141.
42 N. Orme, Medieval Children, New Haven-Londra, Yale University Press, 2001.
43 L. Canetti, Bambini, divinazione e profezia nel Tardoantico cristiano, in Il bambino nelle fonti cristiane, Augistinianum, Roma 2019, pp. 23-39.
44 S. Nagel - S. Vecchio, Il bambino, la parola, il silenzio nella cultura medievale, in «Quaderni storici» 57, anno XIX/3, 1984, pp. 719-763.
45 R. Aasgaard, Children in Antiquity and Early Christianity: Research History and Central Issues, «Familia» 33 (2006), pp. 23-46.
46 B.P. McGuire, “Children and youth in monastic life Western Europe 400-1250 CE”, in Childhood in History pp. 224-239.
47 D. Herlihy, La famiglia nel medioevo, Laterza, Roma-Bari 1989, p. 162.
48 Nell’immensa bibliografia sull’argomento, cfr. la collana Storia delle donne e di genere, a c. della Società Italiana delle Storiche, Edizioni Viella, Roma.
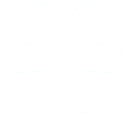 NOTEdiSTORIA
NOTEdiSTORIA