“Sinite parvulos…”. Ma che cosa comunicava poi, ai piccoli, Colui ch’era detto e che è restato, per eccellenza, il Maestro? Li considerava in quanto tali o li riteneva in fondo dei simboli, di un’innocenza che poi non era scelta di non nuocere ma incapacità di nuocere: non bontà, bensì letteralmente impotentia nocendi, al di là del loro istinto? Perché i miti dell’antichità ci dicono – e il dottor Sigmund Freud l’ha confermato – che se il bambino potesse, ucciderebbe il padre per congiungersi carnalmente con la madre.
Il bambino è preda di Satana, ripetevano i padri della Chiesa: come tutti i piccoli mammiferi è vorace, prepotente, crudele. Solo che – qui sta la differenza rispetto agli altri cuccioli d’animale – loro imparano subito o quasi a sbrigarsela. Gli ovipari, ci mettono un po’ di più, i mammiferi si arrangiano facilmente. Tutti, tranne il cucciolo d’uomo: che, come tristemente rilevava Erasmo da Rotterdam, per sua natura sa solo piangere.
Il piccolo che non è ancora in grado di parlare – l’infans, nell’accezione tecnicamente etimologica del termine – e che è tale in quanto non può comunicare e anzi, addirittura, non ha coscienza di sé (ma ha invece il “senso” di sé, sotto forma d’impulsi in genere terribili: la fame, la sete, la rabbia, la paura…), dispone per esprimersi solo di una gamma di espressioni facciali e di una serie disordinata di atteggiamenti corporei: e quando lentamente impara a modulare la voce per dar espressione ai bisogni e ai desideri, si rende subito conto di non saper nulla e di non ricordare. L’amnesia del periodo prenatale e dei primi mesi dell’esistenza lo accompagnerà per tutta la vita, salvo reminiscenze che affioreranno magari nei suoi sogni ma ch’egli raramente sarà in grado di riconoscere.
Gli adulti hanno paura dei bambini. Senza dubbio, possono dissimulare o travestire in mille modi quella paura: da affetto, da cura, da preoccupazione, da severità. E sanno anche dominarli: terrorizzandoli, seducendoli, corrompendoli (basta poco: una ciliegia, una caramella…), violentandoli, ingannandoli, obbligandoli, trascurandoli.
Quel che resta più difficile, tuttavia, è prenderli per quello che sono. Perché che cosa essi siano, noi in realtà non lo sappiamo. In molte culture il bambino è sacro: come l’animale, la donna, il vecchio, il folle, il dio. Noialtri occidentali abbiamo imparato per secoli a vedere in ciascuno di loro soltanto l’ombra imperfetta di quel che sarebbe diventato: e a trattarlo pertanto come un uomo o una donna in miniatura, divertendosi o spazientendosi per la loro inadeguatezza a comportarsi come adulti. Poi, negli ultimi decenni e nelle ultime generazioni – nella misura in cui la gente diventava più longeva e le morti superavano le nascite – ci siamo incamminati sicuri sulla via della pedolatria e della pedomania, entrambe corrette da ricorrenti crisi di ferocia. “Tutto l’oro e il petrolio del mondo non valgono le lacrime di un solo bambino”, sentenziava giorni fa in TV una colta ed elegante signora: e intorno a lei, dietro alle sue spalle, correvano sul piccolo schermo immagini ormai purtroppo divenute consuete che dimostrano come nella nostra società tutte le lacrime dei bambini del mondo non valgono né una goccia di petrolio, né un grammo d’oro. D’altro canto, sovente i bambini sono utilizzati, nella società dei consumi, per fare business: ci commoviamo ancora sul destino del povero David Copperfield, sui bambini africani costretti a fare il soldato, ma c’è mai stato un neonato al mondo più sfruttato periodicamente, una volta all’anno, del piccolo Gesù?
È comunque difficile riuscire a far la storia del Diverso, dell’Altro-da-Noi. Dopo millenni di soliloquio e di autocentrismo, abbiamo imparato a guardare oltre noi stessi; ci siamo resi conto che esistono altri modi di ragionare e di valutare, oltre i nostri: “coscienze altre”, “ragioni nascoste”.
Le scienze dell’infanzia sono state tra le ultime a maturare. Se l’incontro con se stesso in onirocritica come nella psicanalisi può essere tremendo, l’incontro con un noi stessi che non comprendiamo e di cui non ricordiamo nulla, che non ci conosce e non ci ricorda, anzi, che magari ci teme e ci odia e che per questo impara subito a fingere di amare in quanto si aspetta un vantaggio immediato è ancora più arduo.
Da qui parte appunto quest’indagine avvincente e complessa di Marco Bartoli, medievista specializzato soprattutto in storia francescana, per non dire in una scienza nuova e immensa, quel vero e proprio continente storiografico che è la “francescanistica” come storia dell’Ordine minorita, ma in special modo la “francescologia”, la storia di “frate” Francesco e di “san” Francesco in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue pieghe.
Marco Bartoli ha provato a scrivere una storia dei bambini: e immediatamente si è trovato dinanzi un ostacolo difficile da controllare. Si può certo far la storia dell’educazione e la storia della pedagogia, come la storia della pediatria: lo si fa da molto tempo, e anche con buoni risultati. Ma scrivere di metodi e di sistemi educativi, studiarne i processi teorici, è come studiarne la malattie e le cure. Manca – e parrà strano che manchi – una vera e propria pedologia: uno studio dei bambini per quello che sono e per quello che giorno per giorno e ora per ora diventano; studiarli non in quanto oggetto – di crescita, di apprendimento, di malattie e di guarigioni – ma in quanto soggetto.
Molto a lungo si è creduto di studiare i bambini e magari di scriverne la storia: ma in realtà si studiava quello che gli adulti sapevano o credevano di sapere dei bambini, le loro teorie e le loro esperienze.
Per questo motivo Marco Bartoli rende con ragione omaggio a un libro che per anni è stato ammirato, saccheggiato, ma anche sottovalutato e talora vilipeso, specie dagli storici “di professione”: L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime, edito a Parigi nel 1960 e tradotto in molte lingue. Ebbe un grande successo, piacque anche a grandi studiosi come Jacques Le Goff, ma fu al tempo stesso oggetto di diffidenza, anche perché il suo autore, Philippe Ariès, non esitava a definirsi un “reazionario” e a qualificarsi come “storico della domenica”. Il fatto è ch’egli aveva cercato di operare – non è detto riuscendovi – una sorta di “rivoluzione copernicana” nella storia dedicata all’infanzia, cercando di trattare l’oggetto dei suoi studi senza scriverne sistematicamente come può scriverne chi è “al potere”: quindi, nel caso della storia dei bambini – che sono soggetti agli adulti – di scriverne mettendo al centro del suo racconto il bambino stesso.
Il punto è che su ciò le fonti scarseggiano in modo disperante. Ariès svelò di colpo una realtà che per secoli, magari per millenni, era rimasta sotto l’occhio di tutti: i bambini non avevano mai avuto una storia “loro”, e a scriverla erano sempre stati quelli che li governavano, perché alle loro espressioni non si era mai fatto davvero attenzione: essi erano stati considerati solo degli esseri che stavano progressivamente diventando adulti, e l’interesse da loro suscitato maturava soltanto quando, appunto, erano già tali o stavano sul punto di esserlo. Certo però, la storia si scrive con le fonti: che sono in gran parte, per loro natura, fonti scritte. Ariès provò a volger gli occhi altrove e a utilizzare, per esempio, le fonti iconiche, le immagini, che una sessantina di anni fa erano pochissimo usate e soprattutto pochissimo considerate dagli storici: i quali le lasciavano semmai ai loro colleghi allora considerati “secondari”, “marginali”, “di complemento”, in quanto specialisti di “discipline ausiliarie della storia”: quindi ad esempio gli storici dell’arte e gli archeologi. Infine, c’indicò una chiave interpretativa davvero efficace attraverso lo studio non solo e non tanto del bambino in quanto tale, in sé e per sé, quanto attraverso quello delle relazioni tra padri e figli. Qualcosa rispetto alla quale siamo stati a lungo non solo distratti, ma addirittura ciechi e sordi.
Il vecchio Bertolt Brecht si domandava se Giulio Cesare avesse mai avuto un cuoco; Lucio Dalla chiedeva a capitan Ulisse, che aveva negli occhi il suo nobile destino, se pensasse mai al marinaio a cui mancava pane e vino; ma noialtri occidentali moderni e democratici non abbiamo fatto nemmeno una piega quando uno dei benemeriti della costruzione delle nostre coscienze, Jean-Jacques Rousseau, ci ha candidamente confessato, con nonchalance, che i suoi cinque figli li aveva tutti sistemati all’ospizio (e noi ci vergogniamo di mandarci il nonno).
Mettiamo quindi da canto Brecht e Dalla, i cuochi e i marinai, e domandiamoci – dopo aver per lunghi secoli giudicato con severo sussiego o con pietosa comprensione le file interminabili di povere sciagurate che portavano nottetempo i loro figli davanti alla ruota degli ospizi, che in fondo era sempre meglio che abortire o affogarli appena nati – se per caso questi ragazzini non avessero anche un padre; e queste interminabili file di padri non meno insensibili di Rousseau noialtri le abbiamo per secoli assolte d’ufficio. Da qui gli Innocenti, i Proietti, gli Esposito, i Diotallevi e perfino i Gettatelli, i discendenti dei quali hanno riempito per lunghi decenni i nostri elenchi telefonici.
Il fatto è che i bambini li fanno gli esseri umani di sesso femminile, le donne, che di solito li allevano; ma per secoli la storia l’hanno scritta soprattutto quelli di sesso maschile, gli uomini. Da qui la mancanza almeno apparente, nel mondo medievale, di “sentimento dell’infanzia”. Ma la storia dei sentimenti divenne, come quella “delle mentalità” o, in un campo apparentemente a entrambi contrapposto, della storia “materiale” e di quella “del quotidiano”, la nuova frontiera di un movimento nuovo e complesso fondato sul rapporto tra scienze storiche e scienze sociali e umane, la Nouvelle Histoire. In quell’ambito si cominciò a occuparsi con maggior interesse anche di questioni relazionali, ad esempio di storia dei rapporti tra bambini, ragazzi e adulti: e si scoprì che certi fenomeni, come la diffusa pratica dell’infanticidio nel medioevo cristiano, erano stati troppo a lungo ignorati solo perché non ci si era curati di studiarli. Allo stesso modo, si scoprì che ponendo attenzione agli scritti autobiografici i bambini divenivano meno trascurati e anche meno enigmatici in quanto, se pochi erano gli scritti “obiettivi” a loro dedicati, molte erano le memorie che uomini fatti adulti o maturi o addirittura anziani dedicavano ai loro ricordi d’infanzia: e questa specie di “diario-autobiografia postuma”, discretamente diffusa, era suscettibile di venir metodologicamente trattata come una fonte storica di primaria importanza, anche perché sovente non si limitava a descrivere eventi e situazioni, ma aggiungeva a ciò i ricordi di sensazioni e di emozioni.
Dopo la Nouvelle Histoire e la sua interlocutrice statunitense, la psicostoria, il nostro modo di pensare ai bambini è radicalmente cambiato. E Bartoli ci aiuta davvero, con questo suo nuovo bel libro, a ripercorrere il nostro medioevo cominciando ab imis, dai primi autori cristiani, e procedendo per autori illustri e meno illustri, noti e meno noti: da Clemente d’Alessandria al sempre oceanico Agostino, e questi due ce li aspettavamo, attraverso Girolamo e Benedetto e Gregorio Magno (e fin qui, tutto bene), fino a presentarci, anzi a svelarci, i meno frequentati Rabano Mauro e Godescalco o Ermanno Contratto (e la tragedia che si cela dietro quest’aggettivo che siamo abituati a leggere tante volte con noncuranza nelle fitte vecchie colonne della Patrologia Latina ci mozza letteralmente il fiato: e ci costringe a ripensare a Stephen Hawking) sino a Francesco d’Assisi, a proposito del quale è immediato rivisitare quella miracolosa, giocosa profondità del presepio di Greccio (qui però Marco Bartoli “gioca in casa”); e ancora Tommaso d’Aquino e Bonaventura da Bagnoregio, Chiara da Montefalco e Jacopo da Varagine – la descrizione dell’incontro fra il gigante Cristoforo e il Bambino è una pagina da antologia. Infine i bambini di Otranto trucidati dai turchi nel 1480, che rivivono nelle tardive testimonianze con accenti che – nonostante le inevitabili scorie: le amnesie, i fraintendimenti, le rielaborazioni, gli errori, le autoapologie, i rimorsi, le bugie… – ricordano certe immagini richiamate da quanti, tre quarti di secoli dopo, sono stati di recente invitati a ricucire il flash delle loro memorie di bambini di quattro-cinque anni a proposito dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, sulle pendici della Alpi Apuane, nell’estate del 1944.
Se a ciò potessi permettermi di aggiungere un suggerimento riguardante la “mia” Firenze quattrocentesca, mi piacerebbe che Bartoli analizzasse il sogno bellissimo e terribile del diarista Giovanni di Pagolo Morelli, tormentato dai rimorsi a proposito del figlio giovinetto da lui trascurato e quindi morto precocemente e trasformato in onirico, bellissimo e piangente volatile paradisiaco. Un sogno catartico, che ci rinvia a una massima molto profonda di Maria Montessori: “il bambino è il padre dell’uomo”.
Ed è proprio Agostino a comprovare la validità dell’intuizione montessoriana. Inutile ricordare fino a che punto, dal petrarchesco Secretum in poi, il vescovo d’Ippona sia veramente – con Erasmo da Rotterdam, aggiungo da parte mia – uno dei Padri Fondatori della nostra sensibilità moderna. Con delicatezza ma anche con una capacità d’introspezione che a volte rasenta una sorta di pietosa crudeltà. Agostino intervista (e processa se stesso) rivisitando e razionalizzando i suoi ricordi, le sue emozioni, i suoi rimorsi d’infanzia. Anche lui, come tantissimi altri, è stato un “povero bambino” e il suo affettuoso pellegrinaggio attraverso la sua infanzia – magari con qualche fantasioso o autoapologetico “restauro”: non è stato forse il Grande Africano a redigere l’impietoso De mendacio? – è un altro episodio di qualcosa della quale egli è notorio maestro: l’incontro con se stesso, orazianamente alius eppur sempre idem.
Un grazie sincero, perfino un po’ commosso, a Marco Bartoli per un libro che va in realtà ben oltre il suo “mestiere di medievista”. Anche se è un “grazie” con una punta d’amaro. Libri come questi, è fatale introiettarli: li leggi, e diventano parte della tua autobiografia; e ti obbligano ad allungare la lista dei tuoi conti da saldare. Sapevo già di essere stato un cattivo, povero padre. Chiudendo queste pagine sono costretto ad ammettere quel che già sospettavo, pur rifuggendo dall’introspezione: di essere stato a mia volta anche un cattivo, povero bambino. Padre, montessorianamente, del padre che sono diventato.
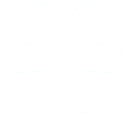 NOTEdiSTORIA
NOTEdiSTORIA