Post haec incidit sibi in mentem investigare utrum uno solo et brevi argumento probari posset id quod de Deo creditur et praedicatur: videlicet quod sit aeternus, incommutabilis, omnipotens, ubique totus, incomprehensibilis, justus, pius, misericors, verax, veritas, bonitas, justitia, et nonnulla alia, et quomodo haec omnia in ipso unum sint (Joan. XVII, 21). Quae res, sicut ipse referebat, magnam sibi peperit difficultatem. Nam haec cogitatio partim illi cibum, potum et somnum tollebat, partim et quod magis eum gravabat, intentionem ejus qua matutinis et alii servitio Dei intendere debebat, perturbabat. Quod ipse animadvertens, nec adhuc quod quaerebat ad plenum capere valens, ratus est hujusmodi cogitationem, diaboli esse tentationem, nisusque est eam procul repellero a sua intentione. Verum quanto plus in hoc desudabat, tanto illum cogitatio ipsa magis ac magis infestabat. Et ecce quadam nocte inter nocturnas vigilias, Dei gratia illuxit in corde ejus, et res patuit intellectui, immensoque gaudio et jubilatione replevit omnia intima ejus. Reputans ergo apud se hoc ipsum, et aliis si sciretur posse placere, livore carens, rem illico scripsit in tabulis, easque sollicitius custodiendas uni ex monasterii fratribus tradidit. Post dies aliquot, tabulas repetit a custode. Quaeruntur in loco ubi repositae fuerant, nec inveniuntur. Requiruntur a fratribus, ne forte aliquis eas acceperit, sed nequaquam. Nec enim huc usque inventus est, qui recognoverit se quidquam inde scivisse. Reparat Anselmus aliud de eadem materia dictamen in aliis tabulis, et illas eidem sub cautiori custodia tradit custodiendas. Ille in secretiore parte lectuli sui tabulas reponit, et sequenti die nil sinistri suspicatus, easdem in pavimento sparsas, ante lectum reperit, cera quae in ipsis erat hac illac frustatim dispersa. Levantur tabulae, cera colligitur, et pariter Anselmo repertantur; adunat ipse ceram, et, licet vix, scripturam recuperat. Veritus autem ne qua incuria penitus perditum eat, eam in nomine Domini pergameno jubet tradi. Composuit ergo inde volumen parvulum, sed sententiarum ac subtilissimae contemplationis pondere magnum, quod Prostagion nominavit. Alloquitur etenim in eo opere aut seipsum, aut Deum. Quod opus, cum in manus cujusdam venisset, et is in quamdam ipsius operis argumentationem non parum offendisset, ratus [ al., iratus] est eamdem argumentationem ratam non esse: quam refellere gestiens, quoddam contra illam [ al., illum] scriptum composuit, et illud fini ejusdem operis scriptum apposuit. Quod cum sibi a quodam amico suo transmissum Anselmus considerasset, gavisus est; et reprehensori suo gratias agens, suam ad hoc responsionem edidit, eamque libello sibi directo subscriptam sub uno ei qui miserat amico remisit. Hoc ab eo et ab aliis, qui libellum illum habere dignantur petitum iri desiderans, quatenus in fine ipsius operis ( vide var. lect.), suae argumentationis reprehensio; et reprehensioni sua responsio subscribatur.
Dopo questi eventi, gli venne in mente di indagare se fosse possibile dimostrare con un unico e breve argomento tutto ciò che si crede e si predica di Dio, ossia che Egli è eterno, immutabile, onnipotente, presente interamente in ogni luogo, incomprensibile, giusto, pio, misericordioso, verace, la verità stessa, bontà, giustizia, e molte altre cose ancora, e come tutte queste realtà in Lui siano una cosa sola (Ut omnes unum sint, Gv 17,21).
Tale ricerca, come lui stesso raccontava, gli arrecò grande difficoltà. Infatti, questo pensiero a volte gli toglieva il cibo, il sonno e il riposo, e ciò che più lo affliggeva era che disturbava la sua attenzione nel servizio divino, in particolare durante l’Ufficio mattutino.
Accortosi di questo, e non riuscendo ancora a cogliere pienamente ciò che cercava, pensò che tale pensiero fosse una tentazione del diavolo e tentò di respingerlo con ogni sforzo.
Ma quanto più si sforzava di liberarsene, tanto più quel pensiero lo tormentava senza tregua.
Ed ecco che, una notte, durante le vigilie notturne, per grazia di Dio la luce si accese nel suo cuore, e la questione gli divenne chiara. Fu colmato da una gioia e un’esultanza immense, che riempirono tutto il suo animo.
Allora, riflettendo tra sé che forse questa scoperta avrebbe potuto piacere anche ad altri e, non essendo mosso da alcuna gelosia, la scrisse immediatamente su alcune tavolette di cera e le affidò alla custodia di un monaco del monastero, affinché le conservasse con attenzione.
Dopo alcuni giorni, chiese al custode di restituirgli le tavolette.
Furono cercate nel luogo dove erano state riposte, ma non furono trovate. Furono domandate ai fratelli, nel caso qualcuno le avesse prese, ma nessuno dichiarò di averne saputo nulla.
E fino a oggi non si è mai trovato nessuno che abbia ammesso di esserne stato a conoscenza.
Anselmo allora riscrisse lo stesso trattato su altre tavolette e le affidò di nuovo allo stesso monaco, ma questa volta con una custodia ancora più cauta.
Il monaco le ripose in un luogo segreto accanto al suo letto e, il giorno seguente, senza sospettare nulla, le trovò sparse sul pavimento di fronte al suo giaciglio, con la cera spezzata e dispersa qua e là.
Le tavolette furono raccolte e la cera recuperata; furono quindi riportate ad Anselmo, che la riunì faticosamente e riuscì a ricostruire, seppur a fatica, la scrittura.
Tuttavia, temendo che un’ulteriore negligenza potesse far perdere definitivamente il lavoro, ordinò che il testo fosse trascritto su pergamena nel nome del Signore.
Così ne compose un piccolo volume, che tuttavia, per il peso delle sue sentenze e della sua sottilissima contemplazione, risultava grande. Lo chiamò Proslogion.
In quest’opera, infatti, egli si rivolgeva ora a sé stesso, ora a Dio.
Quando il libro giunse nelle mani di un lettore, questi trovò non poco da ridire su una delle argomentazioni presenti nell’opera.
Pensando dunque che tale argomentazione non fosse valida e volendola confutare, scrisse un’opera contro di essa e la aggiunse alla fine del Proslogion.
Quando questo scritto, trasmesso da un amico, giunse ad Anselmo, egli ne fu lieto e, ringraziando il suo critico, compose una risposta alla sua obiezione e la inserì in fondo al libretto, che restituì allo stesso amico che glielo aveva inviato.
Desiderava che questa sua risposta, su richiesta di lui e di altri che avessero il libro, fosse aggiunta in fondo all’opera, affinché l’obiezione alla sua argomentazione e la sua confutazione fossero conservate insieme nel testo.
Traduzione in italiano a cura di Note di Storia, pubblicata a solo scopo divulgativo e per facilitare la comprensione del testo.
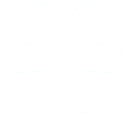 NOTEdiSTORIA
NOTEdiSTORIA